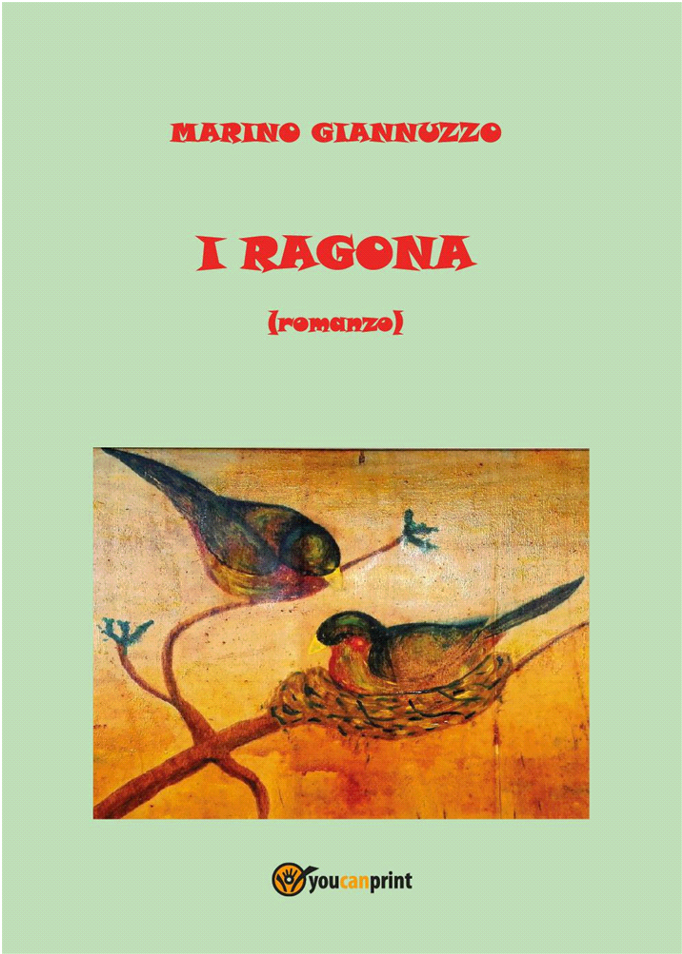|
Saro e altri racconti
Recensione a cura di Antonio
Magnolo
di
“Saro e altri racconti”
di
MARINO GIANNUZZO
Il testo “Saro e altri racconti” presenta al lettore otto frammenti di
vita: alcuni brevi e concisi, “Gnazio, Buck, e Contrabbando”; altri con
un intreccio più articolato “Le chiavi, Sfrattati, Tania, La giustizia di
Tano” e infine “Saro” racconto lungo e, a ben ragione, da ritenersi
romanzo breve. Otto contesti diversi, certamente, ma è possibile trovare
un filo logico che li lega, al di là dei fatti narrati; il nesso va
ricercato nell’ansia mai sopita di giustizia, nel desiderio di veder
riconosciuto per tutti il diritto al rispetto, che si deve ad ogni persona
umana.
E Buck? Non è una persona, è un cane … ma ha i sentimenti di una
persona. Intrappolato da “Le
pareti” che “scendevano quasi a strapiombo nella cava, perché di
cava di pietra si trattava: questo era evidente. Buck desiderò essere una
rondine”. Sa di dover morire e l’ultimo sguardo è al cielo dove
volteggiano le rondini; ora fisse, punti neri “stelle spente, vaganti
per il cielo”. Il lettore si sente coinvolto da profonda emozione e
commozione. Non sembra la condizione di un cane, sembra piuttosto la
condizione di tanti diseredati stanchi per il peso del vivere; l’augurio
che anche per loro l’ultimo sguardo abbia l’azzurro del cielo.
In Gnazio, la caricatura di un losco sanguisuga vittima della sua
spropositata ingordigia e del coraggio spregiudicato ed incosciente di “un
giovane di circa vent’anni che io non conoscevo e ... Neppure l’esattore
pareva conoscesse ...”
In contrabbando l’intima soddisfazione, di un umilissimo Andrea, in cui
il lettore si identifica, per esser riuscito con il suo ingegno a superare
il controllo dei dazieri, “di tutto si trasportava, con mille
sotterfugi, eludendo la vigilanza e i controlli degli uomini del dazio”,
per portare a casa il necessario, in un tempo che la fame rodeva lo
stomaco di adulti e bambini. Sorride Andrea per lo smacco di “quello
che doveva essere il capo” per esser riuscito a sporcargli di “merda”
l’incauto dito …, e sorride il lettore.
“Le chiavi”, inappuntabile descrizione di rapporti di vicinato, spesso
inveleniti da futili motivi, come il passaggio preteso/negato su una
strada vicinale. I personaggi sono descritti attraverso i dati distintivi
del loro carattere; i ritratti che il lettore si raffigura sono stupende
caricature di personaggi che non è certo difficile ritrovarsi intorno.
In “Sfrattati”, il contrasto di vizi e virtù che a diverso titolo recitano
i vari attori in una scena purtroppo frequente, ora più che mai. Su tutti
spicca la figura tragicamente losca di Carlo Brunella, vero responsabile …
d’aver buttato sulla strada la povera madre; per fortuna l’astio del
lettore termina quando “si udì la sirena della volante della polizia.
Quando si dileguò non si udì più nulla: se l’erano portato.”
In “Tania” la voglia crudele di vendetta per aver voluto a tutti costi
trovare un colpevole a una disgrazia, … inchiodata su una sedia a rotelle,
verso una sorella rea solo d’accudirla, di restarle a fianco; per il fatto
di essere più bella ed essere quindi la preferita, la prescelta. A nulla
valgono i vincoli di sangue quando l’odio come fuoco divampa, alimentato
da invidia e gelosia che tutto divora.
“La giustizia di Tano” racconta il dramma di un animo onesto, quello del
protagonista. Tano ha perfettamente intuito che la morte della suocera in
realtà è un omicidio perpetrato dal marito, Saruzzo, ma ha sbattuto la
testa contro l’inefficienza della giustizia, contro l’ignavia del cognato
Peppe, contro le paure della moglie Sabina timorosa per un presente in cui
non mancano gli stenti … per essere pronta a scoprire laceranti
inconfessabili segreti familiari.
Toccherà a “Saro” spezzare le remore di preconcetti stilemi di vita. Se,
infatti, in questi racconti vi è la rappresentazione di “Un mondo di
“vinti” che fanno ricordare i personaggi verghiani” con Saro si
approda ad altro grande narratore: Corrado Alvaro.
Nel
suo capolavoro, di
“Gente in Aspromonte”, egli descrive vita e costumi di gente semplice, da
sempre asservita, ma che riscopre il coraggio, il sapore dolce-amaro della
rivolta e del riscatto. Ed anche il nostro autore, Marino Giannuzzo, non
sembra immune a questo richiamo, al desiderio … che giustizia sia fatta.
Già in “Gnazio” l’anonimo giovane si era ribellato, ma il suo era stato
un gesto immediato, istintivo, di incoscienza … appunto. Ben diversa la
vendetta di Saro, studiata e pianificata fin nei minimi particolari.
Ed infatti Saro avrebbe potuto essere un personaggio del grande
scrittore calabrese, Corrado Alvaro, non importa se ha preferito chiamarlo
Antonello e non Saro. In entrambi i personaggi ritroviamo l’incarnazione
del desiderio di giustizia della gente, la voglia di dire - basta ai
soprusi! -, con la decisione di farsi giustizia da sé. Sembra di rileggere
l’auspicio messo in bocca ad Argirò, padre di Antonello eroe della rivolta
in Aspromonte:
- Qui in questo paese non c’è scampo per nessuno, con questi
mariuoli che comandano. Bella rivincita che sarebbe per me, per noi tutti,
che da casa nostra uscisse qualcuno che potesse parlare a voce alta, e li
mettesse a posto.
Come non leggervi anche il pensiero di Saro, desideroso di vendicare
la morte del padre!
Saro pagherà il suo prezzo, e assai salato. Per un momento di gloria
vestirà i panni dell’eroe, da tutti osannato (ed è qui che il nostro
autore si avvicina tanto ad Alvaro), salvo poi a pagar lo scotto di
vedersi tradito dalla ragazza amata, Ilenia, e ancor peggio da Lucio,
amico fratello, di un’intera vita (e qui ricompare prepotente Verga).
E' difficile per il lettore estraniarsi dai fatti e dai
personaggi, perché ciascuno si vedrà, anche solo in parte, rappresentato
con gli alti e i bassi delle proprie vicende, parte infinitesima di un
ingranaggio il cui nome è … vita.
Sogliano Cavour 01. 05
2015 Antonio
Magnolo
Saro e altri racconti
La giustizia di Tano
Quel pomeriggio di giugno torrido siciliano Ninetta aveva
bussato alla porta di Silvia e non avendo ricevuto risposta,
come tante altre volte, spinse l’uscio già aperto e
s’introdusse nella stanza in penombra chiamando: - Sil….,
Silvi…., Silvia……
Non ci fu risposta. Scrutando meglio nella penombra stava
per tornare sui suoi passi quando si sentì afferrare per i
capelli. Volle gridare, ma una bocca, una bocca mascolina le
chiuse la sua. Vide su di sé gli occhi spalancati e forsennati
di compare Saruzzu. Ebbe un moto istintivo di graffiargli la
faccia, ma le sue mani si fermarono sulle guance ruvide e
irsute in una carezza. Senza averne l’intenzione anche lei si
mosse come forsennata. Se lo sarebbe divorato vivo se non
avesse avuto paura. Si staccò da lui e ricomponendosi gli
disse: - non permetterti mai più.
- Ti voglio. - fu la risposta di Saruzzu.
Ninetta lo guardò con tenerezza, si voltò verso la porta e in
fretta andò via.
Di irreparabile non era successo nulla, ma entrambi si resero
conto che una falla si era aperta nella diga che aveva
contenuto i loro sguardi e i loro desideri, che per tanti mesi,
forse per anni, aveva arginato i sentimenti inconfessati e
inconfessabili di entrambi.
Ninetta era arrivata alla bella età di trentatre anni senza aver
mai sentito da vicino l’odore aspro di sudore d’un maschio
in calore, senza che almeno per una volta due braccia più
forti delle sue l’avessero stretta e sottomessa come lei aveva
sempre desiderato.
Comare Silvia e compare Saruzzu da oltre tre anni si erano
trasferiti in quella casa di fronte alla sua. L’avevano
comprata a buon prezzo, si diceva. Non erano ricchi, ma
almeno avevano la casa, avevano un figlio maschio che già
portava pane a casa e una bambina che frequentava le prime
classi della scuola elementare. Avevano anche un’altra
femmina, ormai sposata, che aveva il suo da fare con il
marito e con un figlio e per questo si vedeva poco dai
genitori, almeno di giorno.
Comare Silvia era una buona vicina, una donna tutta casa e
chiesa. Le sue preoccupazioni erano quelle di far trovare un
piatto di minestra calda a tavola quando il marito rientrava
dal lavoro, provvedere che fossero sempre pronti per la sera
un pantalone e una camicia per il figlio Peppe e seguire con
gli occhi la bambina la mattina quando si recava a scuola.
Infine venivano le normali faccende di casa.
Compare Saruzzu era impiegato, diceva lui, come guardiano
presso la Colmer spa, una ditta che provvedeva alla posa di
tubi in ghisa e in ferro per la conduttura di acque nere e di
acqua potabile. Talvolta dava una mano a spostare qualche
macchinario che gli avevano insegnato a manovrare. Ma il
suo compito specifico consisteva in questo: che non
venissero a mancare tubi e che non venissero danneggiati da
atti di vandalismo. Nei primi tempi era stato larvatamente
minacciato. Quell’impiego era preteso da altri. Poi era stato
spaventato: gli avevano fatto trovare una testa di agnello
ancora sanguinante avvolta in un foglio di giornale una sera
davanti al cancello della ditta. Saruzzu sapeva che
combattere contro i fantasmi era pericoloso. Avrebbe dato
sciabolate al vento, a destra e a manca, senza colpire chi
doveva essere colpito. L’indomani cercò, e lo trovò al centro
della piazza del paese, don Vincenzo Chiesazza. Con poche
parole gli espose i fatti e le apprensioni. Don Vincenzo lo
guardò con un sorriso compiaciuto, gli fece paternamente
sobbalzare una spalla con alcuni colpi della mano e
sorridendo gli disse: - va’ a lavorare tranquillo, guadagnati il
pane e sii sempre rispettoso.
Saruzzu fece per baciargli la mano ma Don Vincenzo la
ritrasse.
- Va’… - gli ripeté.
Da allora Saruzzu non aveva avuto più problemi, sul lavoro.
Anzi da quel giorno si era visto prendere in considerazione
da tutti: dai suoi capi, dagli operai della Colmer, dagli amici
e dai conoscenti. Insomma l’ispirazione che aveva avuto di
rivolgersi a don Vincenzo Chiesazza era stata forse l’idea
più brillante che avesse avuto in vita sua. Non era diventato
ricco ma non era mai mancato il pane in casa sua e i suoi
figli avevano potuto condurre una vita dignitosa. Il lavoro
notturno talvolta aveva dato occasione alla moglie di avere
qualche sospetto sulla sua fedeltà. Ma anche lei, alla tirata
delle somme, si era convinta che l’uomo è cacciatore e che
se lascia guai dove passa l’importante è che non ne porti in
casa. Così erano passati ventiquattro anni di sopportato
felice matrimonio per entrambi.
Si erano sposati molto giovani: Saruzzu diciott’anni e lei,
Silvia, sedici. I primi tempi era stata dura, ma col passare
degli anni e con l’assidua buona volontà non avevano avuto
bisogno di aiuto da parte di nessuno. Avevano fatto la fuitina
per amore e si erano voluti bene anche e soprattutto nei
momenti di difficoltà economica. Poi la sorte era stata
benevola con loro ed avevano avuto una vita se non agiata
almeno tranquilla.
Ma da un certo tempo lei, Silvia, aveva avuto l’impressione
che qualcosa non andava nei rapporti col marito. Era sempre
nervoso, le si rivolgeva in modo sgarbato per un nonnulla, a
letto le girava le spalle e si addormentava subito. Aveva dei
sospetti, ma non aveva prove. E quei sospetti, in fondo,
risultavano senza fondamento. Le sue erano solo congetture,
andava ripetendo a se stessa, mentre solitaria andava
mettendo ordine nella casa durante il giorno. Non aveva una
sorella con cui confidarsi. Non aveva più madre. E
comunque cosa avrebbe potuto confidare?
Così erano trascorsi gli ultimi mesi.
Una sera, sul finire di ottobre, mentre Saruzzu si accingeva
a sganciare il lucchetto dalla catena che teneva chiuso il
cancello dell’azienda sentì dei passi alle sue spalle. Si voltò:
dall’ombra due uomini si avvicinavano frettolosi a lui. Dalle
voci li riconobbe. Erano Cicco e Paolo Malerba, suoi vicini
di casa, anzi suoi dirimpettai, fratelli della comare Ninetta.
- Da queste parti? - chiese Saruzzu.
- Ci trovavamo a passare per puro caso e abbiamo pensato di
venirvi a trovare. O non gradite le visite?
- Ma con piacere. E’ un onore. Avanti, avanti … - e così
dicendo Saruzzu, seguito dai Malerba, si diresse verso la
baracca, posta al centro dello spiazzo. L’aprì e, accesa
l’unica lampada che pendeva dal tetto, li fece entrare.
- Accomodatevi. - E indicò loro due vecchie sedie.
- Non ha importanza, possiamo restare in piedi - disse Paolo.
- Come volete. In che posso essere utile?
- Niente che abbia importanza. Solo una cortesia. Voi sapete
che nostra sorella Ninetta è ormai grandicella ed è molto
difficile che trovi un marito scapolo, con l’età che si ritrova.
Voi sapete quanto noi l’abbiamo in considerazione e quanto
rispettiamo gli amici e i vicini. Però per nostra sorella siamo
capaci di fare qualsiasi fesseria, e, vi assicuro, non abbiamo
alcuna intenzione di farne. C’è una persona di nostra e vostra
conoscenza che purtroppo ne ha combinata una grossa
quanto il mare ed è giusto che questa persona trovi la
soluzione. Alla fine di novembre, un mese da questa sera,
scade il termine che viene concesso. Non vi saranno ulteriori
comunicazioni. E ora se avete la bontà di farcene andare vi
diamo la buona notte.
- Buona notte… - rispose Saruzzu, come inebetito, mentre
apriva la porta della baracca in lamiera zincata dirigendosi al
cancello. Lo aprì. I Malerba andarono via senza salutare,
contrariamente a come erano soliti da sempre.
Il discorso era stato chiarissimo. Saruzzu era stato colpito in
pieno. Un masso lanciato sulla sua testa gli avrebbe arrecato
minore scompiglio. La minchiata che aveva fatto era tutta
davanti a lui, in tutta la sua madornale immensità.
L’esperienza e l’età avrebbero dovuto insegnargli qualcosa.
Ma, si sa, tutti siamo esperti, intelligenti, navigati fino a
quando non scivoliamo nella merda. Davanti agli occhi di
tutti e di noi stessi siamo i più stupidi e i più sprovveduti.
Egli lo sapeva. Con Ninetta si erano frequentati, dopo quel
torrido pomeriggio di giugno. Lei gli si era donata senza
limiti, aveva concentrato in quei pochi mesi tutto il furore
amoroso represso per almeno quindici anni, ma era rimasta
incinta da due mesi. Ne avevano parlato. Ninetta non era
disposta ad abortire: ci teneva al suo bambino, in particolar
modo perché era frutto dell’amore di Saruzzu, diceva lei.
Saruzzu dal canto suo non poteva costringerla e in fin dei
conti un po’ d’affetto lo sentiva pure lui per lei e per quel
figlio che era di là da venire, espressione della sua potenza
virile, a quarantadue anni, da poco superati.
Ma una soluzione non riusciva a trovarla, né di giorno né di
notte, quando, malgrado avesse gli occhi chiusi, non riusciva
a prendere sonno, accanto a Silvia.
I morti erano passati. E San Martino pure stava passando.
La serata era trascorsa apparentemente serena. Solo
apparentemente. Saruzzu quella sera aveva trascinato Silvia
a casa della figlia Sabina insieme con Gina, la loro bambina.
Subito dopo erano arrivati anche i suoceri di Sabina che,
resisi conto di essere in troppi, dopo i soliti convenevoli, con
una scusa decisero di andare via. Ma Tano bloccò tutti.
- E’ San Martino. Ci troviamo qui e qui resteremo. Sabina,
prepara la tavola! Vedi cosa c’è in casa mentre io scendo
nello scantinato a prendere il vino. -
Di fatto sia i genitori di Tano che i genitori di Sabina si
erano recati presso i rispettivi figli per passarvi la serata,
com’era consuetudine nel paese, e qualcosa l’avevano
portata anche loro.
In meno di dieci minuti comparvero formaggi, salumi, frutta
secca, un pezzo di frittata, avanzata dalla cena consumata
poco prima, arance, mele e vino in quantità. Insomma tutto
ciò che di alimentare Sabina era riuscita a trovare in casa. La
serata trascorse in discreta allegria. I maschi bevvero in
quantità, malgrado i rimbrotti delle donne, in particolare
Saruzzu, che alla fine risultò piuttosto brillo. Gina si divertì
col nipotino. Poi, siccome l’indomani sarebbe stata
domenica e nessuno sarebbe andato a lavorare e non ci
sarebbe stata scuola, Gina insisté per restare a dormine
insieme con Filippetto, il nipotino. Dapprima Saruzzu e
Silvia si opposero ma poi udite le insistenze di Tano
accondiscesero. Gina restò a dormire presso la sorella ed essi
andarono via.
Quando furono a letto Saruzzu si lamentava sordamente di
capogiri che aveva alla testa. Se posava la testa su un lato
sentiva il vino scendergli tutto su quel lato. Se la posava
sull’altro sentiva il vino invadergliela su quell’altro lato.
Infastidita Silvia lo riprese: - è una vergogna. Bell’esempio
che diamo ai figli e bellissimi spettacoli che diamo agli
estranei. Vergogna, vergogna, vergogna. -
Per un istante Saruzzu restò muto. Ma quando Silvia in
sottotono riprese: - vergogna ... vergogna …
- E ora è tempo di finirla! - sbottò.
- Ora è tempo di cominciarla, invece. Il cattivo esempio
glielo dai in tutti i modi ai figli tuoi. Fuori di casa e dentro
casa. Vicino e lontano … -
- Zitta, ho detto!
- Zitta io non posso stare, perché il cuore so io come ce l’ho
pieno e come me lo sento. Vergogna, vergogna, vergo … -
Saruzzu in modo automatico aveva afferrato il proprio
cuscino e con quello zittì la moglie. Non disse una parola.
Premé il cuscino sul volto di lei. Non seppe mai dirsi per
quanto. Silvia dimenava le braccia e le gambe, ma era tenuta
giù, inchiodata al letto, dalle ginocchia di Saruzzu che le
schiacciavano il seno.
Poi la donna si arrese, non si mosse più e non parlò più.
Saruzzu abbandonò la presa emettendo un profondo respiro.
Si girò sull’altro lato e s’addormentò.
Si svegliò in piena notte. Sentì accanto la presenza immobile
della moglie. La chiamò. La scosse varie volte. Poi soffocò
un urlo disperato contro il cuscino che aveva tra le mani.
Silvia era morta ed era stato lui ad ucciderla.
Non seppe mai confessare a se stesso se era stato un atto
voluto o se era stato un effetto del vino. Di fatto aveva
ammazzato sua moglie. Le aveva voluto bene. Lei lo aveva
amato. Si erano sopportati come si sopportano tutti coloro
che convivono per decenni nella stessa casa. Anche quei
rimproveri nella notte, che egli ricordava vagamente, erano
stati una manifestazione di affetto e di stima. Volle piangere
ma non gli riuscì. Il cuore lo sentiva indurito, quasi
insensibile. Ora bisognava darsi da fare per salvare il
salvabile.
Aveva tremato tutto il giorno e tutta la notte di quella
domenica Saruzzu davanti alla bara posata su quattro sedie
in mezzo alla stanza principale della casa che era stata
salotto, garage, sala di ricevimento per gli ospiti, dormitorio
per la bambina, dormitorio per qualche coppia di amici che
avevano pernottato quando il tempo era stato troppo brutto o
la notte era stata trascorsa a bere qualche bicchiere in più.
Silvia era ormai dei più. Aveva finito di soffrire per quel
marito che le era toccato. Sempre dietro la gonnella di questa
e di quella, senza mai combinare nulla probabilmente. Ma
qualche cosa era successa negli ultimi tempi se Saruzzu era
stato inquieto, se si era prodigato oltre ogni necessità per
tranquillizzarla che non c’era nulla di cui preoccuparsi, che
l’amore per lei era rimasto sempre intatto, anche se erano
passati ventiquattro anni da quando l’aveva sposata, con tutti
i sacramenti della Santa Romana Chiesa.
Ma ora tutto era finito. Silvia non avrebbe più manifestato
apprensioni e preoccupazioni. Era stata una morte naturale:
era chiaro e palese per tutti. Era morta. Questa era la triste
realtà per parenti ed amici. Anche per Sabina, la figlia
maggiore, ventitreenne ormai, da quattro anni sposa di Tano.
Ma qualcosa non aveva convinto Tano, suo marito, che
teneva le labbra strette e aveva scosso la testa varie volte,
fissando la bara.
Durante la veglia funebre, davanti ad alcune decine di
persone, tra parenti ed amici, Saruzzu aveva rosicchiato,
proprio rosicchiato come un topo, un intero fazzoletto da
naso e aveva tremato ininterrottamente come una foglia
attaccata al ramo allo spirare dello scirocco trapanese, nel
tardo autunno.
Sabina, Gina e Peppe gli si erano stretti attorno, avevano
pianto, erano rimasti scioccati dalla scomparsa così
improvvisa e innaturale della madre. Era morta senza un
perché, senza lasciar trapelare un minimo indizio sulle cause
di quella morte. Non si era suicidata e nessuno l’aveva
uccisa: questo era certo. Ma in qualcuno un dubbio l’aveva
lasciato.
Tano aveva osservato per tutto il tempo il suocero nervoso,
la suocera morta, i cognati. In particolare aveva posato la sua
attenzione su Gina, la cognatina di nove anni, che guardava
sbalordita tutti coloro che le si avvicinavano per porgerle le
condoglianze ed era meravigliata del ruolo che le veniva
attribuito in quella circostanza, senza che lei avesse fatto
nulla per averlo. Col trascorrere delle ore si era convinta
anche lei che qualcosa di importante doveva essere successo,
se tanta gente, conosciuta e non conosciuta, veniva ad
abbracciarla mormorando parole incomprensibili come per
scusarsi di quanto era accaduto.
Sabina si era attaccata al marito. Tremava anche lei. Non
seppe mai dire a se stessa se tremasse per paura o per
nervosismo o perché si sentiva sull’orlo di un precipizio nero
come la notte, mai cercato. Il più sereno sembrava Peppe, il
figlio ventenne, che era precipitosamente tornato da
Messina, dove era in servizio militare, per le esequie della
madre. Dopo un attacco di isterismo alla vista della bara, in
cui era stata ormai sigillata la madre e che ad ogni costo
pretendeva dovesse essere aperta perché lui potesse
abbracciarla e baciarla per l’ultima volta, si era dato pace
quando il responsabile delle pompe funebri gli disse in tono
deciso che un soldato dinanzi al dolore doveva dimostrare di
essere un uomo. Perché quando tutto va bene tutti siamo
capaci di dimostrare il valore. Ma quando qualcosa va male
è allora che si vedono gli uomini o i quaquaraquà. Allora
Peppe si era chiuso in un mutismo assoluto. Non aveva più
pianto, non aveva più parlato, non aveva più risposto alle
domande che gli venivano rivolte, non aveva voluto più
mangiare. Sembrava che anche il suo spirito non fosse più
presente.
Gli amici e i conoscenti lo guardavano e scuotevano la testa.
Quando gli si avvicinavano per le condoglianze lo
abbracciavano senza che egli dicesse nulla. Era
completamente assente.
Subito dopo i funerali della madre, solo come era venuto, se
ne andò a Messina, dove, imbarcatosi sulla nave militare,
partì senza comunicare più con i suoi.
Tano si era svegliato in piena notte. Per tre volte si era
levato dal letto e tre volte si era nuovamente coricato nella
speranza di riprender sonno ma non c’era stata volontà di
Dio che gli riuscisse di addormentarsi. Udiva la moglie che
respirava nel sonno profondo della notte e desiderava tanto
dormire. L’indomani lo attendeva una giornataccia. Ma più
ci pensava e più sentiva sveglio il suo spirito. Stringeva gli
occhi nella speranza di addormentarsi, ma più li stringeva
più gli facevano male. Se li stropicciò, e fu peggio. Gli si
spalancarono in piena notte e si disse che riusciva a vedere
nel buio.
Rivide Sabina taciturna. Rivide Gina, la cognatina, che
dormiva nel camerino a fianco della sua stanza. Rivide
Peppe che se ne era andato senza dare più notizie di sé.
Rivide la suocera, dapprima sul letto, poi cianotica e nella
cassa funebre. Poi più nulla. Per un momento nella notte
vide il vuoto, solo il vuoto. Poi le impressioni cominciarono
a prendere forme, colori, dimensioni. E allora un altro
scenario sorse dinanzi a lui.
Rivide il suocero. Rivide Ninetta.
Già, il giorno dopo la morte di Silvia, Ninetta si era prestata
per i servizi più elementari necessari nella casa di Saruzzu.
Dove, oltre alla biancheria di Saruzzu e alla pulizia in casa,
vi era una bambina di nove anni che aveva bisogno di cure e
di attenzioni. I vicini avevano notato i movimenti, le
premure: erano rimasti sbalorditi, ma smisero di
meravigliarsi e anche di spettegolare quando dopo qualche
mese videro la pancia di Ninetta gonfia di almeno quattro
mesi. Solo un mese dopo i funerali si era introdotta nel letto
che era stato di Silvia e vi aveva preso possesso in pianta
stabile.
Quella sera Gina era stata mandata dal padre a buttare le
immondizie all’angolo della strada, ad una cinquantina di
metri dalla casa. Tornando aveva trovato la propria stanza al
buio. L’unica fioca lampada si era fulminata. Il padre l’aiutò
a mettersi a letto, raccomandandole di dormire.
La notte la bambina dormì poco e male. Di là dalla porta
della stanza del padre venivano dei mugolii, come dei
piacevoli lamenti, soffocati, ma non troppo. Sulla porta che
dava sulla strada, attraverso il buco che serviva per il
ricambio dell’aria nella casa e perché il gatto potesse entrare
ed uscire secondo le proprie necessità, la luna penetrava
prepotente e luminosa, tanto che nella stanza col chiarore
tutti i tegami appesi al muro erano perfettamente
distinguibili.
La mattina quando si svegliò Gina vide davanti al suo lettino
il padre in canottiera e mutande e al suo fianco Ninetta, in
vestaglia. Lei Ninetta l’aveva vista altre volte di giorno
aggirarsi per casa. In qualche modo le era stata grata perché
si era presa cura di lei come di suo padre, ma a quell’ora, in
sottoveste e con i capelli disfatti, certo, non se l’aspettava.
Capì che doveva esserci qualcosa di strano in tutto questo,
ma non disse nulla. Neppure quando il padre, carezzandole i
capelli le disse: - questa è la tua nuova mammina! Da oggi in
poi sarà lei che avrà cura di te. E tu le vorrai bene e la
rispetterai. Ora dalle un bacio. -
La repulsione fu istintiva nella bambina, ma non ebbe il
coraggio di ribellarsi agli ordini del padre. E rimase
immobile quando Ninetta si chinò su di lei, l’accarezzò sulla
fronte posandovi un bacio delicato. Poi avvicinò la guancia
alla sua boccuccia per riceverlo, restituito. Ma la bambina
non si mosse. Fu lei allora, Ninetta, a premere sulla bocca di
lei la propria guancia, sollevandola stizzita. Anche Saruzzo
se ne accorse e rivolse uno sguardo non proprio benevolo
alla figlia. Entrambi ritornarono nella stanza da letto che era
stata di sua madre chiudendosi la porta alle spalle.
Poi Gina, frastornata, confusa, umiliata, si levò dal letto, si
vestì, si lavò, raccolse i quaderni, i libri, le sue cose e scappò
a scuola.
All’uscita si recò a casa di Sabina, la sorella maggiore,
sposata con Tano.
Fin dal primo momento Tano le aveva detto che la propria
casa era la sua casa. Ci poteva andare quando voleva; di
giorno e di notte; e, se voleva, anche per sempre.
Quando Sabina le aprì la porta d’ingresso Gina scoppiò in
lacrime. Avrebbe voluto dire tante cose, ma non le venne
fuori neppure una parola. La sorella la lasciò sfogare. Poi
quando si rese conto che la piccola poteva parlare le chiese: -
e allora cosa è successo?
- Nulla.
- Non è possibile nulla; qualcosa di sicuro è successa.
- Il papà.
- Il papà cosa ti ha fatto?
- Niente.
- E allora, cosa ti ha detto?
- Mi ha detto … che Ninetta ... è la mia mammina.
- Farabutto e vigliacco. Non preoccuparti. Ci sono qua io. Da
ora in poi tu resterai qui con me. Non esiste nessuna
mammina. Ce n’era una e Dio se l’è portata. E anche questo
si vedrà, se è proprio stato Dio. -
Abbracciò la sorella, la coprì di baci, le tolse il fagotto di
libri dalle mani e stringendola a sé la trascinò quasi vicino al
tavolo, dove la sera lei e il marito erano soliti raccogliersi
per cenare, insieme con Filippetto, il figlioletto di tre anni.
Preparò un panino. Gina lo mangiò.
Quando Tano la sera rientrò dal lavoro abbracciò la
piccola, si meravigliò che fosse lì a quell’ora ma non chiese
nulla. Poi mentre si lavava di là, nello sgabuzzino riservato
ai servizi igienici, chiamò la moglie e: - che c’è? - le chiese
senza preamboli.
- Niente. Poi ti racconterò.
- Dimmelo ora; in due parole.
- Gina credo che dovrà restare con noi.
- Va bene. Ma perché?
- Perché mio padre si è messo con Ninetta e la fa dormire in
casa sua.
- Figli di puttana.
- Stai calmo, senza parlare in presenza della bambina e
sbrigati, che la minestra si raffredda.
Tano rimase calmo. Cenarono. Giocherellarono un po’ con
Filippetto, che ormai andava facendosi ometto. Sabina
accompagnò la sorella a letto, le rimboccò le coperte, le
diede un bacio su una guancia e le augurò la buona notte.
- Buona notte - rispose Gina mentre si andava assestando
sotto le lenzuola.
Poco dopo, quando Sabina andò a controllare, dormiva
serena, ignara dei terremoti che avvenivano negli animi
attorno a lei.
La sera successiva Tano si recò dall’avvocato Porrino che
gli disse chiaro e tondo:
- Tanuzzu begdru, tu non hai voce in capitolo. La tua firma
non conta. Portami tua moglie. Le facciamo firmare la
delega e possiamo cominciare a muoverci. Senza la firma di
tua moglie siamo fermi come la montagna.
- Ve la porterò. Poi cosa ci vuole altro?
- Per ora nulla. Strada facendo si vedrà. Sei avvertito: la
strada è lunga e piena di difficoltà. -
Tano si tirò su dalla sedia, guardò per un attimo l’avvocato,
salutò e: - Avrò pazienza - disse, e se ne andò.
La sera successiva accompagnò Sabina dall’avvocato
Porrino. Le disse di firmare dei fogli in bianco che le furono
presentati e lei firmò. Era fatta. Si poteva partire. Lasciò
sulla scrivania il denaro per le prime spese di carta bollata,
aveva detto l’avvocato, e chiese quando doveva farsi sentire.
- Fra una quindicina di giorni fatti vedere. Può darsi che
abbia qualche novità - gli rispose l’avvocato.
Marito e moglie salutarono e tornarono a casa.
Da quella sera erano trascorsi ben quattordici mesi e non si
era venuti a capo di nulla.
Saruzzu e Ninetta, che dopo sei mesi dalla morte di Silvia
avevano avuto un bambino, abitavano ancora nella casa che
era stata anche della povera Silvia, felici e strafottenti, fatta
eccezione per quell’anima innocente che non aveva colpe.
Dapprima si era detto che la casa era intestata a Saruzzu e
quindi, essendo egli l’unico proprietario, non si potevano
avanzare pretese. Poi finalmente si era riusciti a sbirciare
nell’atto di compravendita ed era saltato fuori che era
comproprietario con la morta, in parti uguali. Tano era stato
nominato tutore di Gina. Peppe era stato convinto a firmare
la delega alla lite in favore dell’avvocato Porrino. Di firme e
di carte bollate s’era perso il conto di quante erano state
necessarie. Tano aveva firmato nella qualità di tutore e di
garante degli interessi della bambina. Il Giudice aveva
disposto la divisione della casa. Saruzzu non aveva avuto il
denaro sufficiente per comprare la parte che era stata
assegnata ai figli e quindi era stata venduta, dopo
innumerevoli approcci e litigi, per una mangiata di pasta.
Erano stati pagati i debiti che si erano fatti per le spese legali
e alla tirata dei conti non c’era stato neppure un centesimo
d’avanzo. Tano anzi ci aveva rimesso qualcosa; ma dove c’è
soddisfazione non c’è prezzo, andava dicendo agli amici che
si congratulavano con lui per i risultati ottenuti.
Ma c’era l’altra questione che lo faceva incarognire. La
morte della suocera non gli era stata mai chiara fin dal primo
momento. Non era riuscito a convincere totalmente né la
moglie né il cognato della possibilità che la morte della
madre non fosse avvenuta per causa naturale. Con tutto ciò
era riuscito a far firmare loro la richiesta per l’autopsia del
cadavere. Si era informato presso il Commissariato di
Polizia e gli avevano detto che se il Giudice avesse accettato
l’istanza l’autopsia sarebbe avvenuta, e gratuitamente,
perché si trattava di giustizia di natura penale. Egli aveva
insistito che era stato il suocero, Saruzzu, a uccidere la
moglie, ma nessuno aveva voluto mettere nero su bianco.
L’avvocato Porrino gli aveva detto che ci volevano delle
prove, dei testimoni, che bisognava insomma essere certi al
cento per cento quando si asserivano cose del genere. Già
era una cosa eccezionale se la richiesta di autopsia, dopo
quattordici mesi, fosse stata accolta, sperando che non ci
fossero desideri di vendetta da parte di Saruzzu. Il che era
anche possibile.
E qualche dubbio l’avevano fatto venire pure a lui.
- Lascia perdere … - gli aveva detto qualche amico. Ma egli
aveva detto che quella partita se la doveva giocare tutta e: -
quel che costa costi! - aveva aggiunto. Né poteva ora tirarsi
indietro. Tutti sapevano che era stato lui a smuovere le
acque, a creare lo scompiglio, a scatenare il terremoto ed egli
non poteva ora prendersi il lusso di lasciarli tutti delusi,
senza far vedere come andava a finire quella guerra tra lui e
il suocero.
Dopo quattro mesi finalmente gli giunse notizia che il
sepolcro della suocera era stato aperto e che la giustizia
aveva provveduto a fare le sue indagini e l’autopsia sul
cadavere. Ma ufficialmente nulla era trapelato. Né mai si
seppe nulla. Al Commissariato, alle sue rimostranze perché
non era stato avvertito, gli dissero che la giustizia non ha
bisogno di testimoni ma di periti, in questi casi. La sua
richiesta non aveva fine risarcitorio personale, ma doveva
essere intesa come richiesta di giustizia per la società. Il
Tribunale l’aveva accolta e aveva provveduto. Ora egli
doveva essere sereno e tranquillo: sua suocera era morta
come muoiono la maggior parte degli uomini e delle donne,
di morte naturale, per arresto cardiaco.
- Siamo una nullità. Oggi ci siamo e domani non più.
Ognuno il suo destino! - aveva aggiunto il brigadiere
Murica, tendendogli la mano e facendogli capire che ogni
discorso ulteriore sarebbe stato superfluo.
Tano salutò e come un cane bastonato si avviò verso l’uscita.
Aveva perso la battaglia. Tutti l’avrebbero guardato con
commiserazione e avrebbero riso alle sue spalle.
- Ma non finisce qui - andava ripetendo a se stesso
mentalmente per consolarsi mentre scendeva le scale del
Commissariato.
Ogni giorno in campagna mentre lavorava la terra Tano si
chiedeva parecchie volte se proprio era il caso di attuare
quanto gli frullava in testa da qualche mese.
Per fare altri ricorsi alla Magistratura, fino alla Corte di
Cassazione, ci voleva denaro, molto denaro: forse non
sarebbe bastata la casa che con stenti e sacrifici era riuscito a
mettere su con le fatiche di tutta la sua giovinezza. E sia la
moglie che il cognato si erano espressi chiaramente: essi non
avrebbero mai firmato un altro documento contro il padre.
Chi muore tace e chi vive si dà pace. Lo sapevano tutti. Era
lui che si inventava tutte le supposizioni, le concomitanze, le
circostanze. Anche i giudici non avevano trovato argomenti
contro il padre. Ed egli non poteva intestardirsi così contro
l’evidenza dei fatti. Quindi da quel lato non poteva contare
su alcun supporto. Era il tutore della piccola Gina, e doveva
ringraziare Dio se Saruzzu, suo suocero, non aveva fatto
ricorso, ma non aveva un centesimo a disposizione. Non gli
restava da percorrere se non l’unica strada percorribile per
dimostrare a tutti che non era un “nenti e nugdru”. Tutti
avrebbero capito e nessuno avrebbe parlato.
Da tempo aveva preparato una catasta di ramaglie e di
sarmenti, tra il folto di alcuni cespugli sempre verdi. Vi
aveva aggiunto dei tronchi di eucalipti, perché il fuoco
divampasse presto, e tronchi d’ulivo e di mandorlo perché
potesse durare a lungo, fintantoché non fosse rimasta alcuna
traccia del corpo. Avrebbe trovato il modo per far giungere il
suocero fin là.
Un amico fidato, con una scusa qualsiasi, lo avrebbe fatto
venire sul luogo con le sue gambe. Poi l’amico sarebbe
andato via ed egli avrebbe dovuto sbrigarsela da solo. Ma
quando si è in due c’è sempre il rischio che la notizia prima
o poi trapeli: ed è la fine. Oppure doveva sbrigarsela da solo
in tutto e per tutto. Ma intravedeva un mare di difficoltà.
Così trascorreva le giornate nella solitudine della campagna.
Poi pensò e ripensò più volte che i primi ad accusarlo della
scomparsa di Saruzzu sicuramente sarebbero stati suo
cognato Peppe e sua moglie Sabina. Non sarebbe stato in
grado di sopportare i loro sguardi accusatori. Non parliamo
poi degli interrogatori dei Carabinieri e della Polizia. Lo
avrebbero fatto cantare come un cardellino accecato, perché
ognuno conosce il proprio mestiere.
Lui, in fin dei conti, non era tagliato per essere un assassino.
Non aveva la stoffa del giustiziere. Se almeno avesse denaro
a sufficienza pagherebbe e chi è capace di compiere certe
azioni senza rimorsi le compirebbe.
Poi i suoi pensieri presero altra direzione. Dinanzi a lui c’era
Filippetto, che fra un anno doveva andare a scuola, dalla
quale sarebbe tornato ogni giorno raccontandogli le sue
avventure e la sua bravura. C’era la piccoletta, Angioletta, la
nuova arrivata da nove mesi, che già dava segni di voler
camminare da sola. C’era sua moglie, Sabina. Infine c’era
Gina, ormai grandicella, che aveva bisogno di essere seguita
per non sbagliare. Egli e Sabina s’erano preso l’incarico di
farle da tutore fino al raggiungimento della maggiore età.
Chi avrebbe avuto cura di loro? Qualcuno inizialmente ne
avrebbe avuto pietà, ma poi tutti si sarebbero allontanati,
come ci si allontana dagli appestati. Egli avrebbe pagato e
Peppe si sarebbe goduta la vita. Peppe a cui non interessava
un bel niente se la madre fosse morta in modo naturale, per
arresto cardiaco, come si sapeva, o in modo violento, come
egli sospettava. Era morta e basta.
Si avvicinò alla catasta di legna. Diede fuoco. In pochi
minuti una vampata alta quanto gli alberi rischiarò il giorno,
che fino a quel momento era stato grigio. S’accovacciò su di
un masso, tese le mani verso la fiamma e rimase intontito a
riscaldarsi finché emise un guizzo l’ultima fiammella.
Tania
Tania da giovane non era stata una ragazza bella, anzi era
stata ritenuta piuttosto bruttina, ma era stata sempre
intraprendente. Se i giovanotti non la degnavano di uno
sguardo per le sue fattezze aveva trovato il modo di farli
interessare alla sua persona per altri versi. Non avrebbe
saputo spiegarlo neppure lei come avveniva ciò. Fatto è che
la circondavano innumerevoli amici. La madre non si era
mai preoccupata più di tanto del suo comportamento: se
qualcuno di quei giovanotti in un qualche modo se ne fosse
fatto carico, lei, in cuor suo, aveva fatto voto alla Madonna
dell’Alto che per tre anni consecutivi, l’otto settembre,
partendo da casa, sarebbe arrivata a piedi scalzi fino al suo
santuario, in cima al monte Bonifato.
Margherita, la sorella di due anni più piccola, invece era una
ragazza belloccia. Aveva spesso gli occhi dei vicini di casa
puntati su di sé. Bella, brava, servizievole, di famiglia in
discrete condizioni economiche. Molte madri speravano di
averla per nuora. Almeno fino a quando la poliomielite,
all’età di sedici anni, non colpì Tania, inchiodandola su una
sedia a rotelle. Molto denaro andò via in quel periodo senza
ritorno e senza risolvere alcun problema per la salute della
ragazza. Molti pensarono che si trattasse di un male
ereditario. Quei giovanotti che avevano sempre circondato
Tania per la sua simpatia, e in cuor loro facendo velatamente
la corte a Margherita, dopo la pietà dei primi tempi, ad uno
ad uno si dileguarono tutti. Unico restò Francesco, un
giovanottone di ventidue anni, a far compagnia a Tania nei
momenti che gli restavano liberi dal lavoro di parrucchiere,
come braccio destro del principale.
Bisogna dire che non gli dispiaceva affatto. Anzi era
particolarmente felice e tornava a casa a malincuore quando
Margherita alcune volte era restata a chiacchierare con lui e
Tania. Più con lui che con Tania. Un calore pervadeva tutto
il suo corpo se solo le loro mani inavvertitamente si
sfioravano nel porgere un bicchiere o nel passarsi un libro.
Durò alcuni mesi questa situazione senza che Margherita
desse segnali di interesse per il giovane, benché fosse
sempre cordiale con lui.
Un pomeriggio di mezzo luglio quando Francesco bussò alla
porta d’ingresso e il caldo spaccava le pietre la ragazza,
ormai prossima a compiere i suoi diciassette anni, andò ad
aprirgli. Lo invitò ad entrare. Poi: - Vado a prendere Tania; è
di là che dorme sulla sedia … - disse.
- Lasciala dormire, attenderò che si svegli. Intanto leggerò
qualcosa, qui, sul divano. -
- Allora accomodati. La mamma tarderà un po’. Io ho
appena finito di rassettare la cucina. Ho preparato il caffè da
poco: te ne offro una tazzina. -
- Te lo accetto volentieri. -
Margherita entrò in cucina, armeggiò per qualche minuto,
poi tornò con sul vassoietto due tazzine, una zuccheriera e
alcuni tovaglioli di carta. Lo posò sul tavolinetto di vetro e
prese posto sul divano, accanto al giovane.
- Zucchero? - chiese.
- Uno. -
Sorseggiava ancora il suo caffè Margherita quando
Francesco, avendo bevuto il suo tutto d’un fiato, le si
accostò per riceverne la tazzina da posare sul vassoio.
Mentre lei gliela porgeva meravigliata egli le afferrò la
tazzina insieme con la mano. La tirò a sé. Posò la tazzina sul
tavolino mentre con l’altro braccio e l’altra mano le
circondò la spalla, stringendola a sé. Margherita tentò di
ritrarsi, ma poi chiuse gli occhi e lasciò fare,
abbandonandosi completamente. Egli in silenzio l’abbracciò,
prima timoroso che lei lo respingesse e potesse fargli una
scenata, poi, resosi conto che anche lei si andava eccitando,
cercò le sue labbra, le trovò e con tutto il vigore che ebbe
nelle sue gliele succhiò e mordicchiò fino quasi a farle
sanguinare. Poi allentando la presa gliele sfiorò di nuovo
lievemente con le sue, mentre lei continuava a tenere gli
occhi chiusi e s’aggrappava ai suoi capelli e al suo collo.
Pochi minuti era durato l’abbraccio eppure a Margherita era
sembrato un’eternità, preoccupata dell’eventuale improvviso
rientro della madre. Ma la madre non rientrò. Si udì invece
la voce di Tania che dall’altra stanza chiamava la sorella.
Margherita accorse dicendole subito: - C’è Francesco. E’
giunto or ora. Sta prendendo il caffè. Vieni ti porto di là… -
mentre, afferrata la sedia a rotelle alle sue spalle, la spingeva
nel salotto, dov’era Francesco, il quale, ripresa la sua
tazzina, fingeva di finire il suo caffè.
Tania si dimostrò contenta di rivedere l’amico, ma quel
pomeriggio, egli disse, aveva alcune commissioni da
sbrigare e dopo dieci minuti andò via. I giorni seguenti egli
si dimostrò più premuroso del solito con la poveretta, che nel
suo intimo non osava sperare più nulla dalla vita, se non la
morte. Eppure un lumicino cominciava a prendere
consistenza davanti a lei, lontano, molto lontano, ma
probabilmente raggiungibile. E sperò. Giorno dopo giorno
attendeva con ansia la venuta di Francesco e il suo spirito
sembrava prendere vigore. Talvolta si rifiutava di mangiare
se non lo aveva visto almeno per pochi minuti durante il
giorno, e non si rendeva conto che più lei lo cercava più egli
si allontanava e che molto spesso le sue visite erano visite di
cortesia, se non di pietà.
Un fatto nuovo però aveva notato. Margherita da mesi quasi
non partecipava più ai loro discorsi, che erano diventati
sempre più aridi, brevi e noiosi, mentre le uscite di lei erano
diventate sempre più frequenti e più lunghe. Ma non poteva
lamentarsi della sorella. Ella aveva continuato, come tutti in
famiglia, ad accudirla in tutti i suoi bisogni. I suoi desideri
erano stati sempre ordini per tutti, in particolare per
Margherita.
Si era ormai a pochi giorni dal Natale, quando una sera,
approfittando della presenza dei genitori in casa, Margherita,
arrossendo e accennando a Francesco, seduto vicino a Tania,
disse: - Francesco ed io ci stiamo frequentando. -
Tania si voltò di scatto verso di lei, come se avesse ricevuto
una frustata in faccia, poi lentamente verso Francesco.
Guardò a lungo oltre la sua figura. Aveva gli occhi lucidi,
ma non disse nulla. Il cuore le stava scoppiando. Madre e
padre della ragazza non dimostrarono alcuna contrarietà, pur
non dimostrando alcun entusiasmo. A Mario, il fratello più
piccolo, glielo avrebbero comunicato più tardi, appena
rientrato dalla palestra.
Da quel Natale molti anni erano trascorsi. Franco, come lo
chiamavano ora, e Margherita si erano sposati, avevano
avuto due figli, un maschio ed una femmina, anche loro
ormai sposati con bambini. Anche Mario, il fratello di
Margherita e di Tania, si era sposato con una ragazza nativa
di Biella ed erano andati ad abitare in quella città, dove egli
aveva trovato subito lavoro. Anch’egli aveva avuto un figlio,
che si era sposato e che aveva una bambina.
I loro genitori, i coniugi Circello, ormai vecchi, erano morti
da alcuni anni. Mario aveva ereditato un appartamento nel
paese, che aveva subito venduto, non avendo alcun interesse
a stabilirsi ad Alcamo. Tania e Margherita avevano ereditato
un terreno, nella contrada Ponte dei Ricchi, verso Alcamo
Marina, sul quale il padre aveva fatto costruire due villette
abusivamente e dalle quali si godeva un panorama
fantastico, col mare del golfo di Castellammare, che lo
sguardo abbraccia da capo San Vito a punta Raisi,
l’aeroporto di Palermo, con le tonnare e l’isola di Ustica nel
mezzo, nei giorni senza nebbia.
La malattia di Tania con gli anni si era aggravata e malgrado
le cure e le apprensioni della sorella il suo carattere era
diventato sempre più scorbutico, diceva chi le stava attorno.
Margherita fin da ragazza aveva promesso alla madre che
avrebbe avuto sempre massima cura della sorella, e la
promessa l’aveva ripetuta in punto di morte della madre. Per
lei quella promessa aveva sempre avuto più valore di un
voto fatto alla Madonna dell’Alto.
Ma quel giorno proprio non se la sentì di far finta di niente.
Tania aveva su un vassoio un piatto con la minestra, un
bicchiere con l’aranciata, che a lei piaceva tanto, due panini
e una banana. Margherita glielo aveva posato davanti, sul
piano agganciato ai braccioli della sedia a rotelle.
Approfittando del fatto che nessuno la guardava Tania diede
un colpo maldestro al vassoio facendo versare il tutto sul
pavimento e sul tappeto. Dallo specchio Franco la osservava
senza essere visto e aveva seguito tutta la scena. Non ne poté
più e la sua collera deflagrò. Rivolto alla moglie pronunciò
frasi sconnesse, quasi senza senso logico. Concluse che
quella situazione non era più sopportabile, che qualcuno era
di troppo in casa: o lui o Tania, uno dei due doveva andare
via.
Margherita accorsa guardava esterrefatta ora il marito, ora la
sorella, ora il pavimento e il tappeto e non riuscì a dire una
parola, né di biasimo, né di scusa, né di comprensione. Poi,
procuratisi degli stracci in cucina, pulì il pavimento, portò
via il tappeto e si accinse a dare nuovamente da mangiare
alla sorella. Restarono in silenzio entrambe per tutto il resto
della giornata.
L’indomani mattina, quando tutti furono andati via,
finalmente Margherita, rompendo il silenzio, chiese:
- perché?
- Perché non ne posso più delle vostre ipocrisie. Qui mi
odiate tutti, incominciando da te e finendo alla scopa. -
- Vedi che sei sulla strada sbagliata. Qui ti vogliamo tutti
bene. -
- Sperando che io muoia presto, per poter vendere la villetta
di Alcamo Marina. -
- Sei proprio meschina e mi dispiace che sei combinata come
sei combinata, altrimenti ti avrei già detto di andartene. -
- Me ne andrò. Me ne andrò presto. Vedrai. Così non vi darò
più fastidio. Però finora i soldi della mia pensione e
dell’accompagnamento hanno fatto comodo a tutti. Ora
basta! -
Margherita si era resa conto di avere detto qualche parola in
più del necessario. Voleva dire qualcosa ancora per riparare
alla sferzata data alla sorella, ma non ebbe il coraggio di
aggiungere nulla.
Una settimana dopo rimase esterrefatta quando
un’autoambulanza si fermò davanti alla porta di casa e
qualcuno chiese della signorina Circello Tania. Tania, non si
sapeva come fosse riuscita a combinare il tutto, aveva deciso
di andar via da quella casa. Sopraggiunse Franco e dopo aver
capito per sommi capi di che si trattasse: - meglio così! -
disse, ed entrò in casa, senza voler vedere la cognata che
aveva chiesto di essere ricoverata presso la casa di riposo
“Villa Paradiso”, cedendo con regolare contratto la propria
pensione e la indennità di accompagnamento, che finora
aveva riscosso la sorella.
Sembrò che con quella decisione ogni problema fosse stato
risolto.
Alcuni giorni dopo questa fuga, come la definivano in
famiglia, Margherita, senza accennare nulla a nessuno, si
recò presso la casa di riposo in cui era stata ospitata Tania.
Fece del suo meglio per essere cordiale ma l’atteggiamento
della sorella fu gelido, asettico, ostile. Tuttavia Margherita
trovò il modo di rivolgerle la domanda che avrebbe voluto
rivolgerle da tempo, fin da quando era andata via.
- Perché tutto questo?
- Perché tu sei una ladra. - inveì Tania - Lo sei sempre stata!
- Io una ladra? - e cercò di sorridere, come se la sorella
avesse voluto dire una facezia.
- Prima mi hai rubato il fidanzato, ed ho sempre voluto
credere che l’hai fatto inconsapevolmente. Ti sei appropriata
della mia felicità senza neppure chiedere il permesso, dei
miei soldi e dei miei beni hai fatto quello che hai voluto. Ma
ora basta. Non sei tu e tuo marito e i tuoi figli a dire: - basta!
- Sono io che dico: - basta! - e ancora non hai visto nulla. Ve
ne pentirete tutti amaramente. -
Man mano che Tania si andava accalorando il suo corpo,
oltre che il suo spirito, sembrava prendere vigore. Anche
Margherita ne rimase meravigliata. Per un momento ebbe il
sospetto che la sorella avesse finto tutta la vita. Ma poi Tania
crollò. L’infermiera addetta dovette portarla via per
somministrarle il calmante che il medico le aveva prescritto
appena aveva messo piede nella casa di riposo.
Margherita fece ritorno a casa, ma non fece cenno a nessuno
della sua visita alla sorella.
Cinque giorni dopo l’assistente dell’ufficiale giudiziario le
notificò un atto extragiudiziario. La sorella, signorina
Circello Tania, revocava a lei il mandato di riscossione della
pensione, come revocava il mandato di accompagnamento,
come diffidava lei e tutta la sua famiglia dal mettere piede
nel terreno di sua proprietà nella contrada Ponte dei Ricchi,
ad Alcamo Marina. Chi aveva stilato l’atto evidentemente
era stato un avvocato. E dopo quarantotto ore si venne a
sapere che era stato l’avvocato Salerno.
Margherita ne soffrì, ma pensò che doveva trattarsi di ira
passeggera della sorella, che probabilmente dopo alcuni
giorni avrebbe sentito la mancanza dei suoi e sarebbe
rientrata in quella che tutti avevano ritenuto la sua casa.
Trascorsero i giorni. Trascorsero i mesi. Margherita non
aveva riscosso più la pensione di Tania né le somme relative
al di lei accompagnamento. Per il resto tutto era rimasto
immutato dal giorno della notifica dell’atto extragiudiziario.
Una volta Gina, la figlia di Margherita, si era recata a Villa
Paradiso, chiedendo notizie della zia e di poter parlare con
lei. La segretaria del direttore tornò mortificata dicendo che
la signorina non voleva incontrare nessuno. Gina sorrise,
ringraziò, raggiunse l’auto e andò via.
Da allora nessuno si interessò più della zia Tania.
Pensione ed accompagnamento erano cessati, è vero, ma era
cessato anche l’incubo dell’obbligo morale che qualcuno,
almeno uno, di famiglia costantemente dovesse essere
presente a casa per farle compagnia. Della diffida che
riguardava il passaggio sul terreno a mare non ci si fece
caso. Ci si rese conto della sua importanza quando si giunse
alla fine di maggio, quando si facevano le pulizie per
trascorre i mesi estivi nella villetta di Ponte dei Ricchi, ad
Alcamo Marina.
Si apprese che le chiavi del cancello e della villetta di
proprietà della zia Tania erano in possesso di Sasà Ragusa,
un nipote acquisito del fratello Mario, quello di Biella. Egli
aveva avuto disposizioni categoriche. Non doveva
permettere, nel modo più assoluto, che Margherita o persone
della sua famiglia attraversassero il terreno della zia Tania. E
naturalmente egli non poteva derogare a tale ordine. Quella
stagione estiva Tania era stata spesso al centro dei discorsi in
famiglia e nel vicinato, a causa di quel diritto di passaggio.
Fu necessario rivolgersi all’avvocato.
Una sera, sul finire di settembre, Franco con la moglie si
recarono da Soletta, l’avvocato che li aveva sempre salutati
quando li aveva incontrati per strada, e gli raccontarono per
filo e per segno la loro storia fin da quando erano stati poco
più che adolescenti. Con molta pazienza l’avvocato Soletta li
ascoltò. Li fece sfogare. Fece completare ad ognuno le frasi
iniziate che l’altro aveva interrotto con la preoccupazione di
correggerle e di dar loro il senso giusto. Alla fine chiese: - da
quanto tempo usate il cancello e la stradina per recarvi nel
vostro terreno? -
- da sempre - risposero entrambi contemporaneamente. -
- da quanti anni voglio sapere - insistette l’avvocato.
- da sempre - rispose caparbiamente Margherita, mentre
Franco, facendo un calcolo mentalmente, rispose: - da
ventisette, più o meno.
- Siete sicuri? – incalzò - abbiamo qualche testimone? -
- Sicurissimi, e testimoni a centinaia: tutti quelli che vuole!
- Ok, vi garantisco che possiamo dare battaglia con la
certezza di vincerla, se ciò che mi dite possiamo provarlo.
- Certo che possiamo provarlo. Domani stesso glieli posso
portare, i testimoni. - aggiunse Franco.
- Al momento opportuno … per ora dovete farmi avere il
titolo di proprietà del vostro terreno e, se ce l’avete, una
planimetria dei luoghi.
- Cioè?
- L’atto del notaio relativo al terreno.
- E poi, l’altra cosa? - fece la moglie.
- La pianta! - intervenne il marito.
- Ecco, la pianta, come dice suo marito, signora … -
concluse Soletta.
I coniugi Montecchia salutarono e andarono via, per quella
sera. Ma mentre scendevano le scale Franco si ricordò che
non avevano parlato di onorario e di spese e tornò su. Bussò
e, ricevuto il permesso di entrare, s’affacciò e chiese: - ma di
onorario non abbiamo parlato!
- Ma che vai a pensare. Poi se ne parla. Per ora vediamo di
impostare bene la causa. C’è sempre tempo. E poi non
dovete portarmi l’atto? Allora ne parleremo…
- Arrivederci e buona sera – disse, chiudendosi la porta alle
spalle, il Montecchia.
Margherita intanto l’aveva raggiunto. Insieme si voltarono e
ripresero la discesa delle scale.
Arrivarono a casa incerti se fossero soddisfatti o infelici.
Quella notte, in silenzio, ognuno ragionando con se stesso,
dormirono poco perché si addormentarono sul fare del
mattino.
L’ufficiale giudiziario giunse attorno alle dieci sui luoghi.
Ad attenderlo c’erano Sasà Ragusa, il nipote acquisito di
Mario, che aveva il possesso delle chiavi, l’avvocato Soletta
con i suoi assistiti, i coniugi Montecchia, e l’avvocato
Salerno, difensore di Circello Tania. Sarebbe dovuto
intervenire anche l’ingegnere Vincenti, al quale l’ufficiale
giudiziario avrebbe dovuto affidare la direzione dei lavori.
Ma per impegni già presi in precedenza costui non poté
essere presente.
La sua presenza era indispensabile e quindi l’accesso si
risolse con qualche battibecco tra le parti e gli avvocati
avversari, senza conclusioni di fatto. Le operazioni furono
quindi rinviate al mese successivo, con la speranza di tutti
che nel periodo intermedio si potesse trovare un accordo
soddisfacente tra i litiganti.
I più agguerriti erano stati i Montecchia: sia perché erano i
diretti interessati alle opere che dovevano essere eseguite, sia
perché volevano far capire a Tania Circello una volta per
tutte che il boccino nelle mani l’avevano loro. Tuttavia in
quella circostanza non poterono dimostrare nulla.
Il mese successivo, quando finalmente tutti poterono essere
presenti, marito e moglie non aprirono bocca. L’avvocato
Soletta aveva raccomandato loro di non parlare. C’era lui a
difenderli. E bisogna dire che seppe farlo molto bene.
L’avvocato Salerno, la sua assistita, la signora Tania
Circello, e Sasà Ragusa non furono presenti, secondo
disposizioni tattiche giuridiche consigliate da Salerno.
Tuttavia l’ufficiale giudiziario, nell’assenza di costoro, diede
ordine che si rompesse il lucchetto che serviva a tenere
chiuso il cancello e che fosse sostituito. Consegnò una delle
chiavi relative ai Montecchia e li reintegrò nel pieno e legale
diritto di passaggio sulla stradina che attraverso il terreno di
Tania conduceva nella parte retrostante la loro casa. Poi
diede disposizioni all’ingegnere Vincenti di far abbattere il
muretto lungo metri trentatré e novanta, come era previsto
nella sentenza, con manodopera di sua fiducia, rinviando le
operazioni per la chiusura del verbale ad una data
successiva.
Le spese per le opere da eseguire sarebbero state anticipate
dai coniugi Montecchia.
Quindi si recò presso la Villa Paradiso, ove era ospite la
signorina Tania. La trovò ricurva sulla sedia a rotelle, nel
pieno delle sue facoltà, e rivolto a lei: - la signorina Tania
Circello è lei?
- Sì -
- Io sono l’ufficiale giudiziario. Queste sono due chiavi del
lucchetto del cancello della sua proprietà nella contrada
Ponte dei Ricchi di Alcamo Marina. L’ho fatto sostituire,
come ha ordinato il Giudice. Una l’ho consegnata a sua
sorella Margherita....
- Mai! Mia sorella non deve passare. Non glielo permetterò
mai!
- Intanto io le sto dicendo che sua sorella ha il diritto di
passare e lei non può impedirglielo!
- Mai!
- Signorina, ne parli col suo avvocato. Per ora io la saluto.- E
così dicendo, con entrambe le mani le strinse leggermente la
sua, immobile e incartapecorita, nella quale la vecchietta
continuava a fissare le due chiavi, inebetita.
L’ufficiale giudiziario salutò gli altri con un cenno di mano e
se ne andò. Sfrattati
Giovanna Mariani era nata a Castelvetrano, ma da anni,
più di quaranta, abitava ad Alcamo, nel condominio della via
Degli Angeli al n.33, perché da oltre quaranta era stata
abbandonata dal marito per una ragazzina che lo aveva
trascinato con sé in Svizzera.
Da allora non lo aveva più visto. Aveva tirato su l’unico
figlio, nevrotico, con molti sacrifici, diceva lei, ma con
molto menefreghismo, dicevano i vicini di casa. Tanto che a
tutti dava l’impressione che avesse tirato su un bambino
viziato.
Col passare degli anni il ragazzo venne fuori con tutti i
difetti dell’adolescenza, e per di più accentuati, senza un
pizzico d’iniziativa o di entusiasmo per il suo futuro. All’età
di trentaquattro anni un Mariani, fratello della Giovanna, lo
aveva ficcato, quasi di forza, nel Banco di Sicilia, dove
qualcuno, che non era il direttore, gli aveva subito fatto
capire che malgrado l’influenza dello zio, medico e senatore,
avrebbe dovuto filare. Non per timore dei procedimenti
disciplinari, che non interessavano proprio a nessuno, ma
per il semplice fatto che egli doveva rigare dritto, come tutti
gli altri, o avrebbe subìto un procedimento particolare,
riservato ai furbi.
E in verità aveva capito subito l’antifona e aveva rigato
dritto. Qualche volta che se n’era dimenticato l’avevano
richiamato alla realtà ed aveva subito chiesto scusa a tutti.
Ma quella mattina, nel mezzo di novembre, perse
completamente il controllo di sé. Aveva appena finito di
telefonargli in ufficio, al cellulare, la signora Pollacchi,
abitante sullo stesso pianerottolo di casa di sua madre.
Dietro la porta della madre alcuni signori facevano un gran
baccano. Tra di loro, uno in particolare, basso, pienotto e
autoritario, insisteva a schiacciare il pulsante del
campanello, posto sul muro, ad un lato della porta, che
nessuno si decideva di aprire.
Tra il sommesso brusio generale dei colleghi si alzò dal suo
tavolo e, con tutta la collera che improvvisamente gli si era
sviluppata in corpo, scoppiò senza ritegno: - Li ammazzo
tutti, come è vero che mi chiamo Carlo Brunella. Il tempo di
fare la strada. Aspettatemi. Aspettatemi che vi faccio vedere
io chi è Carlo Brunella. -
E così dicendo si rivolgeva ora verso i suoi colleghi, che lo
guardavano sbalorditi, ora al di là dei vetri antiproiettile,
verso i clienti della banca, che lo guardavano ammutoliti e
meravigliati, incerti se biasimare un tal comportamento o
averne pietà.
Poi il silenzio divenne tombale. Una porta, alle sue spalle, si
aprì. Un uomo sulla cinquantina gli fece segno di venir
dentro. Carlo s’incamminò verso di lui con il petto in fuori,
la testa alta, le sopracciglia aggrottate, il muso allungato,
come per un grugnito, e sfidando tavoli e sedie che lo
separavano infilò la porta della stanza del direttore.
- Cosa è successo? - gli chiese questi, sedendosi.
- Nulla di particolare, ma di sicuro qualche pazzia oggi la
farò. -
- Una già l’hai fatta. Dimmi cosa è successo. -
- Nulla, le ho detto. - Poi dopo una breve pausa: - stanno
sfrattando mia madre, ma guai se si permettono. -
- Tu ne eri a conoscenza? -
- Sì e no. -
- Cioè? -
- Cioè … che a mia madre sono stati notificati prima la
convalida dello sfratto due anni or sono, poi l’atto di precetto
dell’avvocato, procuratore della proprietaria
dell’appartamento, e alcuni giorni addietro l’atto di avviso
con cui l’ufficiale giudiziario l’avvertiva che questa mattina
si sarebbe recato presso di lei per estrometterla
dall’abitazione da consegnare alla proprietaria.-
- La casa serve alla proprietaria? - quasi bisbigliò il direttore.
- Lei dice che la vuole libera e sgombra di persone e cose. -
- Ma la proprietaria deve pur concederti un po’ di tempo per
cercare un’altra abitazione per tua madre. La convalida dello
sfratto certamente è per finita locazione, vero? -
- Non proprio … - sussurrò il Brunella. Allora il direttore
capì. E capì anche dell’altro man mano che il colloquio si
andava snodando.
Venne fuori che la povera madre, ormai molto più vecchia di
quanto il certificato di nascita attestasse, per diverso tempo
aveva creduto di essere in regola con i pagamenti. Poi dopo
alcuni anni si era resa conto, anzi la citazione per la
convalida dello sfratto per morosità notificatale le aveva
fatto capire, che da oltre tre anni la proprietaria della casa
non riceveva la pigione che le era dovuta. Il denaro che
aveva dato e continuava a dare al figlio perché lo facesse
pervenire a lei, alla signora Francesca Brunetti, chissà quale
strada aveva inforcato e se n’era andato senza neppure
salutare.
Per molto tempo Carlo aveva fatto in modo che le notifiche
dirette alla madre fossero ricevute da lui o fossero depositate
presso la casa comunale perché in casa non si era trovato
nessuno a cui poterle consegnare. Dei tre anni di pigione che
mancavano all’appello qualche somma era stata versata
all’avvocato Meringhe, procuratore della signora Brunetti,
nella speranza di sanare almeno in parte la morosità. Ma
l’ordinanza da tempo era divenuta esecutiva e quel denaro,
versato di tanto in tanto, non era stato mai sufficiente ad
ammortizzare neppure le spese legali, che pur dovevano
essere pagate. Con il risultato che la signora Francesca da tre
anni non riceveva un centesimo di euro e non poteva
disporre della casa di sua proprietà, che la signora Giovanna
doveva essere sfrattata quella mattina, pur avendo ormai
versato delle somme di gran lunga superiori a quelle che
doveva alla signora Francesca per le pigioni, e che il figlio
Carlo dimostrava di avere soltanto atteggiamenti da pazzo. A
suo modo aveva ragione, perché sua madre non poteva
essere sfrattata per la leggerezza che egli aveva avuto nel
trattenere il denaro che gli aveva dato per farlo pervenire alla
Brunetti, e se l’era speso in un paio di viaggi all’estero, in
compagnia non si sa di chi, e in una settimana bianca a
Camigliatello, in Sila, ripromettendosi di farglielo avere in
un prossimo futuro. I soldi alla Brunetti li avrebbe dati lui,
ma lei doveva pur dargli il tempo necessario per racimolarlo.
Ora i nodi erano venuti al pettine e lui faceva il pazzo.
Il dottore Germani lo guardò da sotto in su, poi con una
leggera alzata di spalle gli fece segno con la mano di
ritornare al proprio posto di lavoro. Poi aggiunse, mentre
Brunella gli voltava le spalle per tornare al lavoro,: - Quando
avrai finito l’operazione che hai tra le mani, vai da tua
madre. Del tuo comportamento di oggi ne parleremo
domani. E chiudi la porta … - aggiunse infastidito.
Carlo uscì. Tirò dietro di sé la maniglia della porta, si diresse
al proprio tavolo, fece alcuni scarabocchi su di un foglio
posato su una carpetta aperta. Poi con stizza la chiuse e
senza salutare andò via.
La signora Pollacchi da circa un quarto d’ora sentiva
squillare il campanello di casa Mariani. Non se ne poteva
più. Chi insisteva tanto non doveva avere un elevato tasso di
educazione e sicuramente era carente di buon senso. Decise
di intervenire, ma quando si accingeva ad asciugarsi le mani
per andare a vedere un po’ che cosa stava succedendo sentì
squillare il campanello della propria abitazione.
- Quelli dei libri - pensò e andò ad aprire, pronta a dare
battaglia.
- Signora, buongiorno. Chiedo scusa. Sono l’ufficiale
giudiziario. Mi sa dire se la signora Mariani è in casa oppure
sia uscita, o se abbia traslocato? - le fu chiesto tutto d’un
fiato.
- Credo sia in casa e poiché è in precarie condizioni di salute
penso sia ancora a letto.
- Io ho bussato varie volte, ma non risponde, non dà segni di
vita.
- Non so cosa dirle. Se tornate più tardi probabilmente la
troverete a casa, se è uscita.
- Signora, purtroppo non è possibile. Come vede siamo
cinque persone impegnate in questa operazione: io, il mio
assistente, l’avvocato Meringhe, procuratore della signora
Brunetti, qui presente, e che lei conosce molto meglio di me,
proprietaria dell’appartamento abitato dalla signora Mariani,
qui a fianco al suo, e il fabbro. E come vede non ho fatto
intervenire la forza pubblica perché non la ritengo necessaria
in questa circostanza, almeno fino a questo momento.
- Capisco, ma non so cosa dire. - E la signora Pollacchi si
stringeva nelle spalle, impotente, quasi dicesse: - Ma che
vuole da me?
- Lo so. Io mi sono permesso di disturbare lei perché ho tutte
le buone intenzioni di dare una mano, nel limite delle mie
possibilità, alla signora Mariani. Ma questo è possibile solo
se la signora apre la porta e posso parlarle. Altrimenti dovrò
dare disposizioni al fabbro perché provveda a rompere la
serratura per poter entrare. E una volta entrato con la forza
non potrò più fermarmi; dovrò andare fino in fondo, fino alla
conclusione delle operazioni di sfratto. -
- Sfratto? Attendete un momento. Provo a telefonarle.
Potrebbe non aver sentito. Vediamo … - e così dicendo
andava componendo il numero di telefono della Mariani
sulla tastiera del proprio cellulare. Dopo alcuni secondi
Maria Pollacchi, allargando le braccia, - mi ha chiuso il
telefono - disse, e non parlò più. In quel momento venne
fuori Nicola Pollacchi, figlio di Maria, avvocato, che
esercitava da alcuni anni. Salutò l’ufficiale giudiziario, col
quale aveva buoni rapporti di lavoro, salutò il collega
Meringhe, con un cenno della mano salutò gli altri, poi tanto
per dire qualcosa chiese: - cosa è successo? Duro lavoro, eh,
ufficiale giudiziario! - Poi senza attendere risposta, come
colui che già conosce tutte le risposte alla propria domanda,
s’infilò nell’ascensore e andò via.
L’ufficiale giudiziario, dopo avere fatto squillare per l’ultima
volta il campanello della signora Mariani senza ricevere
risposta, rivolto al fabbro: - Aprite! - ordinò.
Il fabbro lo guardò chiedendogli con gli occhi se era proprio
necessario ricorrere a quell’ingrato compito, che fino a quel
momento aveva sperato di non dover neppure iniziare. Con
un cenno della testa l’ufficiale giudiziario gli fece segno di
iniziare. Anch’egli purtroppo era costretto a quel compito
ingrato.
Il fabbro tirò a sé la cassetta degli arnesi di lavoro e,
accostatosi alla porta, cominciò a lavorare. Col trapano forò
il cilindretto di ottone della serratura. Pulì il foro creato e
con una chiave casuale fece girare la toppa per aprire la
porta. Dopo l’ultima mandata la porta non s’aprì: era stata
bloccata anche con un chiavistello di ferro, dall’interno. Fu
quindi necessario scardinare la porta insieme col telaio che
la reggeva. Il rumore del trapano e ora anche quello dei colpi
di martello e degli altri arnesi fecero affacciare, incuriositi e
timorosi, quasi tutti i condòmini che in quel momento erano
in casa.
- Nessuna preoccupazione … Tribunale. - disse rivolto ad
essi l’ufficiale giudiziario. Ad uno ad uno rientrarono tutti
nelle proprie abitazioni.
Finalmente la porta fu scardinata, più che aperta. L’ufficiale
giudiziario entrò. Aprì alcune porte interne. Nella prima
stanza, dopo quella d’ingresso, c’era una gran confusione.
Una catasta di pacchetti di cartone pieni di masserizie varie,
libri ammonticchiati in un angolo, vecchie riviste, alcune
piante di fiori, mal curate, un tavolinetto rotto e pieno di
polvere. Nella successiva, la stanza da pranzo, vi era meno
disordine. Due poltrone in velluto verde, due candelieri
cromati in argento, una vetrinetta, chiusa a chiave, un buffet
e un contro-buffet, un tavolo rettangolare e alcune sedie
tappezzate in similpelle marrone. Dal tetto pendeva un
candelabro con diciotto luci disposte su due piani. Si
accingeva ad aprire un’altra porta quando sentì giungere dei
lamenti da una stanza posta in fondo al corridoio. Alle sue
spalle l’assistente intervenne: - la signora Mariani è qui. Si
lamenta … -
L’ufficiale giudiziario subito si diresse verso la stanza da cui
provenivano i lamenti. L’aprì. C’era buio, ma nella
penombra che si era creata vide sul letto la sagoma di una
donna sotto le coperte, che guaiva come un cagnolino
bastonato. Cercò l’interruttore della corrente elettrica. Lo
trovò. Alla luce della lampada si rese conto, ma già ne era
convinto, che Giovanna Mariani era a letto, probabilmente
ammalata, ma il crescere del volume dei suoi lamenti, sia in
intensità che in vigoria, gli fece venire il sospetto che la
Mariani in buona parte stesse recitando. Pregò la signora
Pollacchi di intervenire come persona che in quella
circostanza potesse meritare maggiore fiducia da parte della
esecutata e potesse esserle di un qualche aiuto, se ne avesse
avuto bisogno.
A lei infatti, aumentando ulteriormente il volume dei propri
lamenti, la Mariani consegnò un certificato medico, passato
immediatamente all’ufficiale giudiziario, da cui risultava che
Giovanna Mariani, di anni sessantasette, era affetta da
osteoporosi, da artrosi, da tachicardia e da altri non meglio
precisati sintomi di malanni.
Rivolto a lei, che continuava a lamentarsi, l’ufficiale
giudiziario, cercando di essere il più convincente possibile,
disse: - signora, purtroppo con questo certificato, così come
è impostato, io devo sfrattarla. Questi sono i sintomi che
hanno tutte le signore, o quasi tutte, della sua età. Lei è
trasportabile, se non può andar via con le sue gambe, e
quindi … io non posso farci nulla. Non posso esserle
d’aiuto. La signora Brunetti non è disposta a lasciarla ancora
nella sua casa, anche perché questo sfratto è stato
convalidato per morosità, e la proprietaria vuole consegnata
la casa oggi. Se lei riesce a farsi concedere alcuni giorni di
proroga da parte sua io le prometto che troverò il modo di
allungare … il brodo, come si suole dire. –
- Voglio il mio avvocato! - tra i lamenti, fu la risposta. Poi
poiché nessuno fu in grado di raggiungere telefonicamente
l’avvocato Porrillo, che lei aveva indicato, aggiunse: -
chiamate il mio medico, chiamate il mio medico … -
Sulla scorta dell’intestazione del certificato fu rintracciato
telefonicamente il dottore Bernardi, che poté intervenire
dopo mezz’ora. Al suo ingresso l’ufficiale giudiziario gli
chiese se la signora Mariani potesse essere trasportata
altrove o in ospedale.
- Ritengo di sì - fu la sua risposta - comunque ora la visito e
sarò più preciso. - Poi, visitatala, aggiunse: - Può essere
trasportata. Però è opportuno che sia trasportata in ospedale
per un elettrocardiogramma perché l’ho trovata molto
stressata, com’è naturale, data la circostanza.
Qualcuno telefonò al 118, anzi fu lo stesso dottore Bernardi
a farlo intervenire. Quattro uomini e una ragazza
sistemarono la Mariani su una sedia a rotelle, la spinsero
sull’ascensore e la portarono via, all’ospedale.
Fu il modo peggiore con cui la signora Mariani poteva
essere sfrattata. Non avrebbe mai più messo piede da
padrona in quella casa. Sarebbe tornata, quando sarebbe
tornata, e col permesso della Brunetti, solo per prendere le
sue cose e portarle via.
Completato l’inventario dei rimanenti beni, oltre quelli già
descritti, che si trovavano nell’appartamento, l’ufficiale
giudiziario li affidò alla Brunetti insieme col cagnolino
bianco e riccioluto che fu rinvenuto in cucina, affinché li
potesse consegnare, a semplice richiesta, agli aventi diritto.
Fece firmare ai presenti il verbale che aveva redatto. Firmò
anch’egli, raccolse le sue cose, salutò e se ne andò.
Lo sfratto Brunetti contro Mariani Giovanna era stato
eseguito.
Quando Carlo Brunella, dopo un’ora e mezza, da Palermo
giunse a casa di sua madre trovò la serratura sostituita e il
vuoto dinanzi a sé. Tutti erano andati via. La signora
Pollacchi gli comunicò che avrebbe trovato la madre presso
l’ospedale e che nessuno era stato in grado di poterla aiutare.
- Vedremo … - era stato il commento di Carlo. E andò via
infuriato. Senza salutare.
In ospedale trovò la madre, seduta su un lettino, che in
silenzio, con un fazzoletto di carta s’asciugava le lacrime.
Vedendo il figlio scoppiò in pianto. Egli cercò di consolarla,
ma Giovanna non sentiva ciò che le diceva.
- Vedrai. Torneremo nella nostra casa. Te lo prometto. -
Ma Giovanna sapeva che le promesse di Carlo non
bisognava prenderle in considerazione nemmeno quando
dipendevano dalle sue possibilità. Sarebbe stato assurdo
tenerne conto quando dipendevano, oltre che dal suo
desiderio, anche dalla volontà degli altri. Perciò gli disse:-
noi non torneremo più in quella casa. La colpa è nostra e tu
sai perché. Ora che la signora Brunetti ha visto come le hai
ridotto il bagno non vorrà più sentir parlare di noi. Te lo
dicevo io di non rompere i sanitari, di non distruggere il
pavimento, di non rompere le piastrelle, di non danneggiare
le porte… -
- Ma è stata lei a mandarti la citazione per lo sfratto.
- Perché da tre anni non riceveva un centesimo di affitto…
Carlo non disse più una parola. Sapeva che la colpa era sua e
che l’avvocato Porrillo lo aveva consigliato male quando gli
aveva suggerito di procurarsi un certificato medico per sua
madre, in cui si dichiarasse che la stessa era ammalata
intrasportabile, di farla mettere a letto e che non si alzasse
dal letto neppure se avesse sentito andar giù la porta di casa.
Certamente l’ufficiale giudiziario avrebbe desistito dal
procedere non trovando alcuno in casa.
Madre e figlio avevano seguito il consiglio dell’avvocato.
Egli li aveva rassicurati che lo sfratto non sarebbe avvenuto
e che Carlo poteva tranquillamente recarsi in ufficio il
giorno dello sfratto: non sarebbe successo nulla. Intanto, a
conguaglio e a saldo degli onorari a lui spettanti, aveva
preteso e aveva ottenuto il versamento della somma di
novecento euro, in contanti, dalla signora Giovanna, la sera
precedente.
- E invece eccoci qua, fuori di casa, in ospedale, senza
sapere dove andare, coperti dalla vergogna. - aggiunse
Giovanna per tutti e due, come se quei ricordi fossero stati
espressi ad alta voce da entrambi.
Poi in modo risoluto Carlo, dopo aver pensato a lungo,
rivolto a sua madre disse: - per ora me ne vado. Qualcosa
farò. Ritornerò più tardi. - E andò via.
In tribunale le udienze erano ormai terminate. L’avvocato
Porrillo era andato via. Carlo lo raggiunse mentre
posteggiava l’auto davanti alla sua abitazione.
- Avvocato Porrillo, a lei devo parlare - gli disse da lontano,
mentre gli si avvicinava con passo affrettato.
- Alle diciassette sarò allo studio. Ora ho un po’ di fretta. -
- Io più di lei. Quindi mi fa la cortesia di spiegarmi ora, e
dico ora, perché mia madre è stata sfrattata. E’ rimasta a
letto, secondo il suo consiglio. Le hanno buttato giù la porta.
E’ ricoverata in ospedale e quando sarà dimessa sarà in
mezzo alla strada. -
- Non so cosa dirti. Avvicinati nel pomeriggio presso lo
studio e ne parleremo. -
Prima che Porrillo potesse aggiungere altro un pugno lo
raggiunse in fronte, tra gli occhi, e, come un vitello di primo
latte, cadde riverso sul cofano dell’autovettura.
Quando si riprese Carlo era scomparso.
Nel tardo pomeriggio il campanello di casa Brunetti si
mise a squillare. Al citofono rispose Flavia, la minore delle
figliole della Brunetti. Al suo: - chi è? - una voce rispose:
- Carlo Brunella. Apri!
- Io non apro a nessuno …
- Passami tua madre.
- Un momento …
Poco dopo la signora Brunetti era al citofono.
- Signor Brunella, io non ho nulla da dirle. Solo voglio
puntualizzare che la colpa è sua e di sua madre. Intanto me
l’avete distrutta, la casa. Per ottenerne nuovamente il
possesso mi avete fatto penare quindici anni. Per questo
motivo le mie figlie non hanno potuto ottenere delle borse di
studio: il reddito di questa casa faceva superare il minimo
consentito per la nostra famiglia. Non avete avuto né pietà
né buon senso quando è morto mio marito, quando siamo
rimaste tre donne sole in questa casa e avevamo bisogno di
vendere quella dove abitavate voi per risolvere i problemi e
certe circostanze che si accanivano contro di noi. Anche
l’affitto, quel poco che avreste dovuto farci avere, sono tre
anni che non si vede un centesimo. Mentre proprio lei,
signor Carlo, si concede auto di lusso e vacanze, che non
potrebbe e non dovrebbe permettersi, a spese della mia
famiglia.-
- Auto e vacanze mie sono affari che non la riguardano…..
- E invece mi riguardano. E molto, per giunta, perché se le
permette a spese mie.
- Comunque poche chiacchiere. Mia madre deve tornare a
casa sua, e subito.
- Si rivolga al tribunale. Io non posso far nulla. - E così
dicendo chiuse il citofono e la conversazione.
A quel punto il campanello di casa con insistenza riprese a
squillare ora a tratti, ora brevi, ora prolungati, poi in modo
continuo. Quando smetteva momentaneamente si udivano
giù, per strada, calci e pugni contro il portone d’ingresso del
condominio e grida sconnesse di voci molteplici.
Poi si udì la sirena della volante della polizia. Quando si
dileguò non si udì più nulla: se l’erano portato.
Le chiavi
No. Non poteva continuare così.
Gli passavano a mezzo metro dalla porta di casa, correndo
con le auto, col rischio che qualcuno qualche volta ci
restasse morto ammazzato, senza avere il tempo di dire
neppure: - ahhh …
Ma doveva finire questa storia. Aspanu Tumbarello aveva
vinto la causa in primo grado e per ora doveva passare, ma
gli altri, quale diritto avevano di passargli sullo stomaco?
Così Ciccio Corsini decise che in un modo o nell’altro
doveva pur finire questa baraonda.
Un lunedì mattina, all’alba, si appostò dietro l’angolo della
casa di campagna con un nerbo di bue a portata di mano,
nascosto in mezzo alle fascine di legna, in attesa che
comparisse il primo, chiunque esso fosse, per spiegargli nel
modo giusto che di là non si doveva passare. Ma era rimasto
accovacciato dietro il muro della casa fino al tramonto del
sole senza scorgere anima viva, in quella giornata fredda di
fine novembre. Quando fece ritorno al paese la sera, mentre
cenava, gli venne il dubbio che lo avessero visto da lontano
e che per timore nessuno si fosse azzardato a passargli
davanti. Ma poi si rese conto che era stato un caso, solo un
caso, che nessuno di coloro che gli interessavano si fosse
recato nelle campagne quel giorno. Dopo una giornata,
un’intera giornata, passata inutilmente dietro la sua casa di
campagna, si sentiva svuotato. Era deluso. Non poteva
sobbarcarsi nuovamente ad un’altra giornata come quella.
Sarebbe divenuto pazzo restando immobile, senza svolgere
alcuna attività, e il terreno aveva bisogno di cure e c’era
tanto da fare.
E poi se qualcuno si fosse presentato? Cosa gli avrebbe
detto? Cosa gli avrebbe fatto? E con quali conseguenze?
Parlandone con la moglie giunsero alla conclusione di
consultarsi con l’avvocato Mencasi. Gli avvocati trovano
sempre la soluzione ai problemi. E appena finì di cenare si
recò presso lo studio dell’avvocato Mencasi, ma non lo
trovò: era fuori paese per una riunione molto importante e
non sarebbe rientrato per la sera, gli riferì la segretaria con
molto garbo e con altrettanta gentilezza.
La mattina seguente lo attese al bar di piazza Ciullo per
offrirgli il caffè. L’avvocato Mencasi gli disse subito che la
soluzione per quel problema c’era, ma che era necessario un
certo studio e una certa impostazione per non sbagliare:
perché, si sa, in queste cose talvolta basta un nonnulla, una
parola in più o in meno o fuori posto, e tutto va a rotoli.
Quindi gli diede appuntamento per il pomeriggio presso il
suo studio.
Nel pomeriggio, quando fu il suo turno, Ciccio Corsini si
levò dalla sedia dell’anticamera ed entrò nella stanza in cui
l’avvocato Mencasi riceveva i clienti. Alle sue spalle una
immensa libreria riempiva la parete. In essa non vi era un
buco disponibile per infilarci neppure un paio di forbici per
potare. A Ciccio sembrò impossibile che un uomo potesse,
non dico studiare, ma almeno avere il tempo e la pazienza di
leggere tutti quei libri.
- Veniamo a noi … - disse l’avvocato. - Io, per quanto mi hai
detto stamattina, mi sono studiata tutta la questione. Intanto
dobbiamo premettere che il Giudice, interpretando in un
certo modo alcuni articoli del codice civile, nella causa che
Tumbarello ci ha intentato gli ha dato ragione, almeno in
primo grado. Voleva il diritto di passaggio davanti alla casa
e, grazie anche alle testimonianze incerte di tuo compare
Lillo e di tuo cugino Vito, il Giudice gli ha dato ragione. Ma
non tutto è perduto. -
- Intanto - scattò Ciccio Corsini - Aspanu Tumbarello passa
e spassa con tutta la famiglia senza neppure salutare, d’estate
sollevando un mare di polvere e d’inverno facendo i fossi
con le ruote del furgone. Poi ci sono tutti i suoi cognati, che
hanno i terreni ancora più in là del suo, che pur avendo il
passaggio comodo da un’altra parte, continuano a passare
davanti a casa mia, di proposito, dicono, perché ne hanno
diritto e perché non vogliono perderlo.-
- Al Tumbarello non puoi impedire di passare. Quindi mettiti
l’anima in pace. Per gli altri ho la soluzione. E’ questione di
spese. -
- Avvocato, la soddisfazione non ha prezzo. Quindi facciamo
tutto ciò che è necessario fare!- esclamò risoluto Ciccio
Corsini.
- Allora per questa sera abbiamo finito. Domani preparerò il
verbale di offerta reale per l’ufficiale giudiziario. Domani
sera a quest’ora mi porterai due chiavi, una per il lucchetto
della catena da porre all’inizio della stradina e l’altra per il
lucchetto della catena che sarà posta alla fine. Con
cinquecento euro, per le spese. -
Ciccio aveva detto che la soddisfazione non ha prezzo.
Avrebbe voluto dire qualcosa, ma si rese conto che non
poteva obiettare nulla, salvo a fare qualche pazzia col fucile
a canne mozze e con la conseguenza che tutti sarebbero
passati dalla stradina, eccetto lui, destinato in tal caso a
godersi l’ombra perenne di una cella; lui che era abituato al
sole, al vento, all’acqua, ma non all’aria stantia.
L’indomani, per non sbagliare, si recò da Mencasi con due
lucchetti nuovi, ciascuno con tre chiavi. Sul tavolo posò il
denaro. Sul denaro posò i lucchetti.
L’avvocato trasse fuori da un cassetto della scrivania due
fogli scritti al computer, con la penna fece un segno in calce
ad uno di essi e poi:
- Firma qui. - gli disse, porgendogli la penna. Corsini firmò.
Poi Mencasi tirò a sé i fogli, poi i lucchetti, poi il denaro.
Senza contarlo lo unì ai fogli con una graffetta e sganciata
una chiave da ciascun lucchetto, consegnò le altre insieme
con i lucchetti a Corsini.
- Io cosa devo fare? - chiese q7u6e sti.
- Nulla, per ora. Domani procurati due catene lunghe quant’è
larga la strada e quattro paletti in ferro. In questi giorni
contatterò l’ufficiale giudiziario competente per
l’operazione. Fra qualche giorno fatti vedere e ti farò sapere
qualcosa. -
Ciccio salutò e andò via. A casa Martina, la moglie, gli
chiese come era andata. Era andata che l’avvocato s’era
fottuti cinquecento euro e che egli ancora non era convinto
che sarebbero serviti a qualcosa. Ciò che non digeriva in
particolare era il fatto che Aspanu Tumbarello sarebbe
comunque passato davanti a casa sua, a dispetto. Si
consolava però che almeno tutti gli altri, ed erano una
diecina, con tutte le loro famiglie, non sarebbero passati più
di là.
- Aspanu non deve passare! - andò su tutte le furie Martina.
- Vaglielo a dire tu all’avvocato. Anzi al Giudice. Dice
l’avvocato che la sentenza parla chiaro: Aspanu passa. - le
gridò in faccia Ciccio.
Martina, con gli occhi iniettati di sangue, avrebbe voluto
scagliarsi sul marito e malmenarlo perché la colpa era sua se
avevano perso la causa. Era un incapace. Glielo aveva detto
prima che incominciasse la lite che Mencasi non era un
avvocato che vinceva le cause perché non aveva appoggi e
collegamenti con i giudici. Ci sarebbe voluto Giuliotti.
- Quello sì che è un avvocato con i contracazzi. Non perde
una causa. Ha un cognato e un cugino della moglie giudici,
un altro cognato avvocato; e poi è uno che si sa muovere.
Questo Mencasi è onesto ma non quaglia, non è concreto-.
- Ormai siamo nel ballo e dobbiamo ballare - sbottò il marito
- e ora basta! - Si alzò dalla sedia e andò a rintanarsi nel
bagno per chiudere la discussione. E la discussione
realmente si chiuse. Infatti per quella sera non si parlò più né
dell’avvocato, né della lite, né di altro.
Il venerdì sera Ciccio Corsini, indossato il vestito della
domenica, si recò dall’avvocato Mencasi. Questi gli disse
che aveva preso appuntamento per lui con l’ufficiale
giudiziario per il lunedì mattina seguente, alle nove.
- Alle nove in punto sarai al tribunale di Alcamo. Chiederai
dell’ufficiale giudiziario, dottore Giannò. Dovrai
accompagnarlo qui, a Calatafimi-Segesta, nella contrada
Pantano, presso Tumbarello, per procedere all’offerta reale.
- Avvocato, lei mi deve evitare di incontrare Aspanu
Tumbarello. -
- Tu non incontrerai nessuno. Devi solo accompagnare il
dottore Giannò da Tumbarello perché non conosce la
contrada. Io ho udienza al tribunale di Trapani e pure io non
saprei dove andare. A te tocca. Non preoccuparti. L’ufficiale
giudiziario sa quello che deve fare. Tu devi solo
accompagnarlo. Coraggio.-
- Non è questione di coraggio. Temo di non sapermi tenere
dal fare qualche fesseria …
- Andiamo, via. Tieniti calmo. C’è chi lavora per noi. Sii
puntuale. - e così dicendo lo accompagnò alla porta,
dandogli due leggere pacche sulla spalla.
Il lunedì Corsini fu puntuale, come era sempre stato in vita
sua. Si presentò all’ufficiale giudiziario. Dopo venti minuti
erano in viaggio verso Calatafimi-Segesta. Ogni tanto
qualche buca nell’asfalto faceva sobbalzare l’auto del
Corsini, nella quale viaggiavano scambiandosi qualche
parola di tanto in tanto. Prima di giungere alle case di
Sirignano svoltarono a destra, verso la contrada Sasi.
Attraversarono la campagna, verde in quella stagione, ricca
di vigneti, con le foglie ormai di color rame, e di pascoli, in
mezzo ai quali, qua e là si scorgevano in lontananza delle
macchie bianche: mandrie di pecore, ciascuna col proprio
pastore. Attraversarono il paesino di contrada Sasi, nato
dopo il terremoto del sessantotto, con i contributi dello stato,
appendice del centro di Calatafimi, che negli ultimi anni al
proprio toponimo aveva aggiunto quello di Segesta. A destra
e a sinistra erano allineate le case bianche, quasi tutte col
piano terra adibito a magazzino e un piano soprastante per
l’abitazione. Tuttavia anche qui si notavano varie costruzioni
che non dovevano essere state immuni dal germe
dell’abusivismo.
Giunti a Calatafimi lo costeggiarono. Lontano si stagliava
nel cielo ceruleo del mattino il monumento di Pianto
Romano, tomba dei garibaldini caduti sul colle nel 1860,
durante la spedizione dei Mille, quella spedizione che forse
sarebbe stato meglio se non ci fosse mai stata per la Sicilia e
per tutto il Meridione .
Tra fossi, pozzanghere, canne battenti sul parabrezza
dell’auto, finalmente si immisero sulla strada asfaltata, che
dopo alcuni chilometri li condusse davanti al cancello della
proprietà di Aspanu Tumbarello. Una catena con lucchetto
teneva ben chiuso il cancello, dal quale, all’interno, si
dipartiva una stradina che dopo circa cento metri, facendo
arco verso sinistra, scompariva alla vista dietro una
collinetta. Esperì vari tentativi l’ufficiale giudiziario per
richiamare l’attenzione di qualcuno che eventualmente
potesse trovarsi non visto al di là del cancello. Tutto fu vano.
La disperazione era dipinta sul volto di Corsini, che
timidamente disse: - e ora che si fa? -
- Niente. Io do atto nel verbale che abbiamo trovato chiuso,
che quindi non ho potuto consegnare le due chiavi che
l’avvocato Mencasi mi ha fornito, lo firmo e lei mi farà la
cortesia di riaccompagnarmi ad Alcamo, in tribunale. -
- Ma così io non risolvo un bel niente. La prego, dottore, mi
aiuti. Non mi faccia commettere qualche pazzia. Glielo
chiedo per carità, per il bene che vuole ai suoi figli: mi
faccia godere la mia famiglia. Mi aiuti. Mi dica cosa posso
fare io e la farò. La prego di non preoccuparsi per le spese.
Sono disposto a qualsiasi spesa, ma lei mi deve aiutare. - E
quasi si metteva a piangere per il nervosismo che gli si era
accumulato dentro.
- Signor Corsini, il mio lavoro sarebbe finito qui. Questo
verbale- e così dicendo gli mostrava i due fogli che il Corsini
aveva visto quando aveva portato le chiavi e i cinquecento
euro dall’avvocato Mencasi- ha un valore giuridico e servirà
perché il Giudice possa emettere un provvedimento a suo
favore. -
- Ma intanto mi passeranno tutti sulla pancia. E il giudice
farà passare quattro anni, se tutto va bene, prima che prenda
una decisione. -
- Tuttavia se lei sa dove possiamo incontrare il signor
Tumbarello possiamo tentare, se lei è disposto ad
accompagnarmi - disse il dottore Giannò.
- A sua completa disposizione. Lei ordini ed io eseguo. -
Un sorriso sfuggì dalle labbra dell’ufficiale giudiziario,
mentre l’auto si metteva in movimento. Giunsero alle prime
case del paese, appollaiate sulla costa della montagna. Una
strada stretta e lunga li condusse quasi dall’altra parte. Il
dottore Giannò fece squillare varie volte il campanello
dell’abitazione di Aspanu Tumbarello, nella via Tenente
Viviana n.23. Nessuno rispose. Sconsolato chiese a Corsini
di accompagnarlo in tutti i luoghi del paese ove lui riteneva
potesse trovarsi il Tumbarello.
Fecero il giro di alcuni parenti, chiesero informazioni ad
amici, entrarono nei bar. Nulla e nessuno.
Tornarono nella via Tenente Viviana n. 23, dove abitava la
moglie del Tumbarello, fittiziamente separata dal marito.
Dalla stradina in pendio saliva un’auto nera con sull’antenna
della radio un voluminoso fiocco bianco di tulle. Qualcuno
aveva deciso di sposarsi. Al balcone della moglie di Aspanu
Tumbarello una donna sulla quarantina era affacciata e
osservava il corteo di macchine che seguiva la sposa. Al
sopraggiungere dell’ufficiale giudiziario il suo sguardo si
incontrò con quello di lui e benché non conoscesse il dottore
Giannò immediatamente rientrò in casa, mentre questi
rivolto a lei gridava: - A lei, signora, a lei devo parlare… -
La donna incurante chiuse la porta dietro di sé, senza aver
visto passare la sposa sotto il suo balcone, sforzandosi di non
vedere l’ufficiale giudiziario e di non ascoltare ciò che egli
le andava dicendo mentre avanzava verso di lei.
Il dottore Giannò fece squillare varie volte il campanello. La
donna non comparve. Intanto la sposa con il corteo di
macchine erano passati oltre e scomparvero all’angolo della
strada. L’ufficiale giudiziario, esasperato, pigiò a lungo,
ininterrottamente, il pulsante del campanello, che
dall’interno si sentiva squillare. Una vicina si affacciò al
balcone accanto, guardò, ma non disse nulla.
Intanto in fondo alla strada, là dove era scomparso il corteo
della sposa, e la strada s’incurvava leggermente, un uomo
con baffetti e cappello, sulla cinquantina, furtivamente si
affacciò con la testa a spiare cosa stava succedendo nel
luogo dov’era l’ufficiale giudiziario, e, come se fosse stato
scoperto, subito si tirò indietro, nascondendosi. L’ufficiale
giudiziario smise si far suonare il campanello. Si accostò
all’altro lato del muro e lungo di esso, perché la curva con le
abitazioni coprisse il suo avvicinarsi, a passo lesto, si diresse
verso l’angolo della strada, dove aveva visto scomparire la
testa con baffi e cappello. Sulla strada che intersecava la via
Tenente Viviana vi erano delle auto posteggiate sui due lati,
vuote. Sulla strada nessuno. Guardò un po’ più in là.
L’officina di un meccanico era aperta. Qualcuno davanti al
cofano aperto di un’auto stava lavorando. Si avvicinò. Il
meccanico era intento a smontare un pezzo sul motore, un
garzone lo assisteva, due uomini guardavano. Uno di essi era
l’uomo con baffi e cappello, che aveva spiato nella via
Tenente Viviana. Gli si avvicinò chiedendo a tutti: - Chi di
voi è Tumbarello? -
- Io - rispose l’uomo con i baffi.
- Gaspare, vero? -
- Sì -
- Venga, venga - gli disse con tono autorevole mentre si
allontanavano entrambi dall’officina. - Che senso ha giocare
al gatto col topo? Mi fa perdere soltanto tempo. Lo sa che
prima o poi la dovevo trovare da qualche parte. -
Aspanu Tumbarello era rimasto intontito. Ma poi si riprese.
- Ma lei chi è? Che vuole da me? -
- Qui ci sono due chiavi per lei. Io sono l’ufficiale
giudiziario del tribunale di Alcamo. Le chiavi sono dei
lucchetti delle catene che Corsini sta mettendo sulla stradina
nella contrada Pantano. Firmi qui per accettazione.- e così
dicendo gli mise la penna in mano e il verbale che nel
frattempo aveva completato.
Ancora stordito e non ancora ripresosi del tutto Tumbarello
firmò. Poi rianimandosi:
- Io accetto, ma con riserva. Se il mio avvocato dice che non
devo accettarle gliele riporto in tribunale domani. -
- Il suo avvocato chi è? -
- Armato. -
- Francesco Armato? -
- Sì -
- Allora questa sera quando va a trovarlo gli porti i saluti
miei. -
- Lei come si chiama? -
- Giannò, l’ufficiale giudiziario. Lo trova scritto qui sul
timbro; vede? - e così dicendo gli andava mostrando il
timbro apposto sulla copia che gli aveva rilasciata, gli strinse
la mano e se ne andò.
- Arrivederci! - aggiunse mentre si allontanava lasciando
Tumbarello fermo nel mezzo della strada,
intento a guardare la copia del verbale che gli era rimasta in
mano con le chiavi.
Corsini, fermo in macchina, non aveva potuto seguire gli
avvenimenti. Aveva creduto che il dottore Giannò fosse stato
in casa del Tumbarello, a parlare con la moglie, cercando di
convincerla a ritirarsi le chiavi. Quando lo vide comparire
rimase col fiato sospeso.
- Tutto fatto. - Gli disse costui, aprendo lo sportello del lato
del passeggero e sedendosi in macchina.
Corsini lo guardò senza aver capito. Non osava chiedere
notizie per non farsene dare alcuna negativa. L’ufficiale
giudiziario lo guardò a sua volta: - Il signor Corsini è stato
servito. Tumbarello s’è prese le chiavi. -
Ciccio non credeva alle sue orecchie. L’avvocato Mencasi e
lui avevano avuto ragione. Sua moglie torto. Finalmente
poteva piazzarsi in mezzo alla strada del Pantano e far
tornare tutti indietro, o quasi tutti. Quell’ufficiale
giudiziario, un metro e sessanta di cristiano, con una penna e
due fogli di carta, gli aveva tolto un sacco di gente da sopra
le scatole. Finalmente!
Mise in moto e partì.
Mentre la macchina, sobbalzando allegramente sulla strada
sconnessa, viaggiava verso l’uscita del paese, Corsini,
rivolto al dottore Giannò, con la gioia e la soddisfazione che
veniva fuori da tutti i pori, disse:
- Ora mi dica lei cosa le devo e come posso disobbligarmi
nei suoi confronti. Tutto quello che vuole: la soddisfazione
non ha prezzo. -
- Mi riporti ad Alcamo sano e salvo e non faccia pazzie! -
rispose l’ufficiale giudiziario, mentre il motore dell’auto
continuava a cantare riattraversando la strada tra le case
della contrada Sasi per fare ritorno ad Alcamo.
Contrabbando
Andrea, al tempo della guerra mondiale, la seconda,
quando di fame e di contrabbando c'era tanto in giro, andava
una mattina nella nebbia spingendo una vecchia bici
sgangherata con un carico sul portabagagli posteriore: un
recipiente in terracotta con il tappo, coperto da un vecchio
cappotto ormai logoro, legato con una cordicella al collo del
recipiente.
Molte cose, specialmente alimentari, non potevano entrare o
uscire dal territorio comunale senza una specifica bolletta di
accompagnamento dopo aver pagato la relativa tassa di
importazione o di esportazione.
Ma di tutto si trasportava, con mille sotterfugi, eludendo la
vigilanza e i controlli degli uomini del dazio.
In questo clima Andrea quella mattina si recava in
campagna. Ad un tratto da dietro i cespugli che
fiancheggiavano la strada sterrata comparvero due figure che
gli intimarono di fermarsi. Istintivamente fu tentato di
fuggire, ma poi dopo un attimo di esitazione si fermò. I due
lo raggiunsero: erano quelli del dazio.
- Cosa trasporti?
- Merda.
Uno dei due, quello che doveva essere il capo, senza
aggiungere una parola e indispettito dalla risposta, si
avvicinò al recipiente. Sciolse la cordicella che teneva il
vecchio cappotto stretto al collo del recipiente, sollevò il
tappo e, quasi automaticamente, vi infilò la mano con
l'indice teso. La trasse bagnata.
- Cos'è? olio, vino?
- Merda! - rispose Andrea senza scomporsi.
Fu solo allora che l'uomo dalla mano bagnata portò l'indice
al naso. La puzza gli dilatò le narici.
- Merda! merda davvero! che schifo! - esclamò, disgustato.
Asciugò velocemente la mano al vecchio cappotto e si
allontanò dicendo al compagno: - Andiamo! Questa me la
pagherà. Prima o poi lo fotteremo.
E anche quella mattina Andrea poté proseguire con le
bottiglie d'olio, ben tappate, immerse nella merda. Era
l'unico modo per poter sopravvivere a quella maledetta
guerra, che pareva non volesse finire mai. Buck
Buck guaiva da tre giorni nel fondo del burrone.
Benché avesse una zampa fratturata aveva fatto più volte il
giro attorno alla parete che lo circondava. Aveva cercato una
via di scampo ma non l’aveva trovata.
Eppure Buck il cirneco non si arrendeva. Si sentiva venir
meno, ma non voleva morire. Si sdraiò sotto il sole cocente e
stette in silenzio. Lassù, in alto, tanto in alto che sembravano
delle stelle spente, vaganti per il cielo, le rondini.
Non riusciva a capire come avevano fatto gli uomini a
uscirne. Le pareti scendevano quasi a strapiombo nella cava,
perché di cava di pietra si trattava: questo era evidente.
Buck desiderò essere una rondine. Avrebbe solcato i cieli,
sarebbe volato via da quella prigione senza scampo, si
sarebbe sfamato con gli insetti che vagavano nell’aria.
Il sole gli dava fastidio e chiuse gli occhi. Non sentiva alcun
dolore alla zampa e neppure lo stomaco gli faceva male.
Poi s’addormentò e non si svegliò più. Gnazio
quello del pizzo
Se non lo conoscete è perché non vi è stato mai presentato.
Una bella fortuna! Ma senz’altro lo avrete incontrato tante
volte per strada, passeggiando con i vostri intimi o recandovi
al bar con i vostri amici.
Persona abbastanza conosciuta in città, vi può esser capitato
di vederlo in compagnia di altri che hanno gli stessi
atteggiamenti. Non è più giovane, ma non può nemmeno
essere detto vecchio. E’ più vicino ai quaranta che ai
cinquanta. Di denti originali ne ha solo cinque, gli altri sono
stati rimpiazzati. Se vi capiterà di dare una sbirciatina sul
sedile che è al suo fianco mentre guida la propria auto
constaterete di persona che è sempre occupato da un qualche
involtino o da un sacchetto di carta con della frutta, a
seconda delle giornate e delle stagioni.
Talvolta però ha mal di denti: vi scorgerete solo una diecina
di scatolini di pillole tutte varie e tutte già provate, nell’ansia
di eliminare il dolore.
Comunque sarete certi che non soffre quando lo vedrete
masticare o mordere un panino strappandolo con i denti, così
come usano fare i cani per strappare un pezzo di stoffa: con
una zampa tengono a terra lo straccio e con i denti lo tirano e
dimenano la testa per aria, guaendo.
No, no. Voi state pensando a quel tale che era seduto con voi
tempo addietro allo stesso tavolo, a pranzo. No, ve
l’assicuro: vi state sbagliando. Non è lui.
Ma non agitatevi. Prima o poi l’avrete incontrato. E se non
l’avete incontrato vuol dire che il caso non è stato benigno
con voi e avrete perduto uno spunto di spettacolo vivente.
Ebbene, una mattina, qualche tempo addietro, in un’ora
non più fredda e non ancora calda, ero al mercatino del
pesce, giù, in un angolo della cittadina dove, pur essendo nel
mezzo dell’abitato, si sa che si è in periferia. Infatti al di là
del mercatino vi abita solo gente povera, che ha timore di
avvicinarsi a quel pesce e deve accontentarsi, gran
privilegio, di quello che transita a buon mercato sotto i
balconi delle case su un carretto spinto da un vecchietto
smilzo e matto, per chi non lo conosce, nel tentativo
continuo di allontanare le mosche dal pesce e da sé, con le
mani e con le braccia e, di tanto in tanto, con bruschi scatti
del capo.
Ma le mosche ormai vi hanno fatto l’abitudine e, malgrado
la buona volontà del vecchio e la sua insistenza, non si
muovono. Anzi da quando egli ha aderito al suggerimento di
alcune donne di coprire le cassette del pesce con una
reticella le mosche s’infilano nelle cassette, sotto la reticella,
e talvolta bisogna che egli le prenda col pollice e l’indice per
strapparle dal pesce. Il vecchio però sa bene che nessuno
dell’ufficio sanitario abita in quel quartiere, altrimenti
qualcuno si sarebbe accorto, ma sarebbe sempre molto
difficile da provare, che il sangue delle mosche ammazzate
molto spesso è appiccicato con qualche aluccia proprio sul
pesce più vistoso.
Ma di questi pericoli non corre il vecchio: medici, avvocati,
giudici, impiegati, gente cosiddetta per bene, che ha i soldi,
abitano da tutt’altra parte.
Con la sua gente anche il vecchio può permettersi talvolta di
alzare la voce: tanto non succederà mai niente e in fondo gli
vogliono bene perché anch’egli è uno di loro, benché sia il
solo a detenere, in quell’angolo di paese, il monopolio del
pesce che non può più essere conservato nei frigoriferi della
pescheria.
Comunque quella mattina di luglio al mercatino del pesce
incontrai Ignazio, conosciuto come Gnazio l’esattore del
pizzo, intento a fare la spesa per la famiglia.
Per accertarsi che il pesce fosse fresco egli non si limitava ad
osservarlo. Gli vidi strappare la testa ad un calamaretto,
sciacquarlo in una vaschetta con l’acqua e masticarlo crudo.
La stessa sorte toccò a due altri tipi di pesce molto piccoli e
ad una piccola triglia dopo averla spinata con un’unghia.
Era solito così, ho saputo dopo, fare colazione ogni mattina.
Ma non sempre col pesce. Talvolta con la frutta, tal altra con
la verdura, altra ancora con la carne. Sì, anche con la carne.
Perché molto spesso capitava che gli vendessero carne molto
dura mentre in famiglia se non era tenera non la si digeriva
ed egli purtroppo doveva assaggiare un pezzetto di quella
che gli dovevano vendere.
Tutti i commercianti di cui era cliente sapevano questa storia
e tutti ormai si erano assuefatti a questa sua abitudine. Anzi i
più svegli, per non fargli toccare tutta la merce, prendevano
essi stessi ciò che egli voleva assaggiare e glielo nettavano e
glielo porgevano dopo averlo accuratamente lavato, se era il
caso. Egli teneva in gran conto queste piccole gentilezze che
gli si facevano e sapeva ricordarsene. A queste persone egli
concedeva sempre un periodo più lungo che ad altre per il
pagamento del pizzo, o una rateizzazione dello stesso. Molto
spesso, grazie poi a questi suoi favori, il suo conto risultava
già pagato e la cosa, benché ogni volta non lo sorprendesse e
gli facesse dare in rimostranze, non gli dispiaceva.
Quella mattina non so se mi divertissi o mi stomacassi a
guardarlo. Fatto è che ingoiata la triglia e pulitesi le mani col
fazzoletto tolto dalla tasca posteriore dei pantaloni fece un
cenno del capo come per dire a se stesso che il pesce non lo
convinceva.
- Se lo mangi tutto ti do un premio, stamattina.
Rivolto all’esattore era un giovane di circa vent’anni che io
non conoscevo e che non avevo mai visto dietro quella
bancarella. Neppure l’esattore pareva conoscesse quel
giovane. Io a quelle parole, pronunziate con tono troppo
forte per non attirare l’attenzione di cento occhi, volgevo i
miei altrove.
- E tu chi sei? - fece Gnazio l’esattore.
- Sono cazzi che non ti riguardano! - rispose con viso
stravolto il giovane.
Gnazio fece l’atto di avviarsi contro il giovane come per
minacciarlo. Sentiva in sé la potenza e la forza; e l’ira gli
rigonfiava le arterie del collo.
Nessuno degli astanti osò fare un gesto o aggiungere una
parola. Tutti avevano un minuto da perdere per curiosare e
per sentire cosa si sarebbero detti il giovane e l’esattore.
- Che è successo? - chiedeva sottovoce un tale che era alle
mie spalle, come se domandasse a tutti e a nessuno.
Nessuno gli rispose.
Tutti vedemmo una cosa orribile, inaspettata, improvvisa.
Una cassetta piena di polipi roteò per un attimo in aria,
stretta tra due mani; s’abbassò violentemente sul capo del
giovane, che, rimasto immobile per un istante, come se
aspettasse quella mossa, scartò di lato come un gatto
selvatico allungando contemporaneamente una mano verso
l’addome dell’esattore, che scivolò tra i polipi sparsi per
terra.
Un urlo feroce scosse il mercatino del pesce.
L’esattore restò immobile lungo disteso, in un prolungato
lamento, mentre un rivolo di sangue si allontanava da lui sul
selciato.
Il giovane guardò stupito per un attimo la folla.
- Mi ha rovinato! – gridò - mi ha rovinato! - E cominciò a
correre, giù, per le scale, senza una meta.
Nessuno parlò. Nessuno lo fermò. Saro
L'uomo si fermò.
C'era buio. Solo la luce di un lampione pubblico, in fondo
alla strada, che oscillava nel vento della sera, né fredda né
calda, di ottobre.
Davanti a lui la vecchia casa, che era stata dei nonni, i
Capizzi, poi di suo padre. Ora di nessuno, quasi, perché era
stata abbandonata in attesa di tempi migliori per
ristrutturarla.
Nel buio anche la casa era nera, e il portoncino e le finestre,
ormai corpo unico con i muri. Sulla destra i resti di quella
che era stata l'abitazione di una zia di suo padre. Di essa
restava solo un muro diroccato che fiancheggiava la strada.
All'interno si indovinava l'ombra del vecchio mandorlo,
immobile e silenzioso.
Sulla sinistra un muretto basso in pietra delimitava il terreno
che circondava la casa; anch'esso qua e là diroccato.
Si tirò sul muretto e saltò giù, dall’altra parte, nel terreno.
Dopo qualche minuto fu di ritorno, scavalcò nuovamente il
muretto, s'avvicinò al vecchio portoncino, introdusse una
vecchia chiave arrugginita. Dopo alcuni tentativi finalmente
aprì, diede uno sguardo a destra e a sinistra, nella strada;
entrò; richiuse.
Otto mesi che correva, da subito dopo Pasqua, e già
s'avvicinava Natale. Sarebbe stato il secondo Natale dalla
morte di suo padre. Tutti sapevano che era stato un
incidente, un maledetto incidente d'auto per Nicola Capizzi.
Ma Saro non ne era stato mai convinto e aveva voluto
sapere.
La polizia giudiziaria e il medico legale avevano deciso:
decesso istantaneo per imperizia nella guida. Un imberbe
Sostituto Procuratore aveva scarabocchiato alcune sigle su
dei fogli volanti. Il caso era stato dichiarato chiuso e
archiviato.
Saro aveva finto di credere. Anzi era stato lui a convincere la
madre che le auto purtroppo combinano brutti scherzi. Sono
belle, utili, confortevoli, ma certe volte tradiscono e allora
non c'è nulla da fare; è il destino.
E il destino così aveva voluto.
Ma egli non credeva al destino e non si era dato pace. Aveva
voluto sapere. E aveva saputo.
Una sera, rincasando più tardi del solito, fece in modo che
Leo, il figlio della signora Dora, gli offrisse un passaggio
con la sua auto. Non rifiutò per non far dispiacere all'amico,
ma, disse, avrebbe preferito fare quattro passi. Aprì lo
sportello e si accomodò.
- A dire il vero non è che abbia sonno, stasera - aggiunse,
mentre si accomodava meglio sul sedile anteriore, riservato
al passeggero.
- Se vuoi andiamo a fare un giro largo, ma non a piedi … -
rispose Leo. E mentre parlava mise in moto la piccola
utilitaria, ancora odorante di nuovo, e partì.
Parlarono di studi e di ragazze. Poi Saro propose di allungare
verso la campagna. Dopo qualche chilometro Leo svoltò per
una strada asfaltata di fresco e accelerò.
- Benzina ce n'è - disse.
Ma avvertì che qualcosa di duro gli era penetrato fin dentro
le costole di destra e capì. Capì di avere sbagliato tutto
quella sera. Di essersi sentito troppo sicuro. Cercò di reagire
scherzosamente:
- Non fare lo stronzo, Saro; chi vuoi spaventare con questo
pezzo di ferro?
- Voglio metterti alla prova. Voglio vedere se hai coraggio.
Ma non fare fesserie, è carica. Pensa a guidare. Se superi la
prova sarai ricco e presto -.
Leo non sapeva come interpretare il tutto. Per un attimo
volle convincersi che l'amico volesse davvero metterlo alla
prova per poi proporgli qualcosa di molto rischioso; anche se
di Saro aveva l'opinione, come del resto tutti quelli che lo
conoscevano, che fosse un ottimo ragazzo, magari un po' più
buono di quanto fosse necessario.
- Chi la fa l'aspetti! E, quando succede, senza lagnarsi -
ammonì in tono scherzoso Leo.
- Giusto. Per ora vediamo se la superi tu questa prova …
Così dicendo spinse ancora un poco la pistola tra le costole
dell'amico.
- Va bene - e si rese conto che non riusciva a togliere il piede
dall'acceleratore, come bloccato da un qualcosa che non
aveva nulla in comune con lo scherzo.
Proseguirono ancora senza parlare per alcuni chilometri.
- La prossima a destra. Vai piano …
Come se quelle parole avessero sbloccato il sistema nervoso
di Leo i piedi gli ridivennero sciolti, la destra scalò la
marcia, la sinistra accompagnò lo sterzo nella curva.
- Più piano.
- Più piano di così … si muore.
Si sentì più sicuro. Avvertiva che nella voce di Saro non
c'era odio. Forse Saro stava mettendo alla prova le proprie
capacità e ci stava riuscendo perché aveva la voce pacata,
ferma. Anche la sua mano non tremava, sintomo di
eccezionale autocontrollo. Però non bisognava fare
movimenti bruschi. Se la pistola era davvero carica un colpo
poteva accidentalmente partire. Poteva guidare tranquillo.
Egli non c'entrava e Saro non sapeva. Forse voleva sapere.
- Fermati! - ordinò Saro con voce fatta più decisa.
Leo accostò. Davanti a loro si apriva uno spiazzo. Spense il
motore. Rimase con le mani ferme sullo sterzo e s'accorse
che in cielo c'era la luna.
- Metti le mani dietro la nuca e scendi piano senza voltarti.
- Ora lo scherzo sta diventando pesante … - si lamentò Leo,
mentre si tirava giù dall’auto.
- Fai il bravo; fino in fondo. Sta' calmo e fa' quello che ti
dico io.
Quasi di scatto Saro attraversò il sedile sotto lo sterzo e
scivolò a terra alle spalle di Leo, che la canna della pistola
ora la sentì incollata alla schiena, proprio sulla colonna
vertebrale; e lo spingeva.
Senza parlare Saro lo fece dirigere tra due filari di ulivi
giganteschi, in mezzo ai quali, alta, dominava la luna. Dopo
circa duecento metri raggiunsero la bocca di un pozzo,
delimitata da un muretto in pietra, alto mezzo metro. Era
scoperto.
- Fermati e siediti!
- Ora basta! - rispose indispettito Leo, facendo capire che
ormai si stava scocciando e che non era più disposto ad
assecondare l'amico.
Nella sua voce però Saro avvertì un tremolio e per un attimo
ebbe paura anche lui.
- Fino in fondo.
Così dicendo lo spinse sull'orlo del pozzo e con la pistola lo
costrinse a voltarsi e a sedersi. Puntandogli l'arma e
indietreggiando si allontanò di due passi: - Se ti muovi
sparo! Le mani sempre dietro la testa! -
Leo si rese conto che sentiva freddo, aveva i brividi, come se
all'improvviso fosse sopraggiunta la febbre. Stringeva le
ginocchia una contro l'altra perché non tremassero.
- E chi si muove? - disse, quasi scherzando.
- Tu sei il migliore amico mio; vero?
- Certo; ma tu non sei neppure il peggiore amico mio, se mi
fai questi scherzi.
- Lo scherzo ancora non è cominciato. Allora … dov'eri la
sera dell'antivigilia di Natale?
Leo sentì il vuoto sotto i suoi piedi e dentro la testa. Doveva
controllarsi. Poteva perdere l'equilibrio e rovesciarsi nel
pozzo. Aggredire Saro era impensabile.
- A Milano, da mia sorella - rispose il più presto che poté.
- Ho controllato. La vigilia … eri a Milano. L'antivigilia no!
dov'eri?
- A Milano!
- Cerca di capirmi. - riprese suadente Saro. - Qui, in paese,
ad Alcamo, dov'eri? In quale contrada? Mi hai capito ora?
- Ti dico che ero a …
- Basta! - gridò Saro, senza preoccuparsi se qualcuno potesse
o volesse sentirlo. Poi continuò pacato: - Con chi eri allora?
- Solo.
- Senti, Leo. Voglio sapere com'è andata. Può darsi che ci sia
qualche speranza per te. Ma voglio sapere tutto.
- Io non c'entro …
Saro restò in silenzio, in attesa che Leo continuasse. E Leo
dopo qualche attimo di pausa aggiunse:
- Io ho sempre voluto bene a voi; a te, a tuo padre, alla tua
famiglia …
Se invece del chiarore della luna ci fosse stato quello del
sole Leo avrebbe visto che il viso dell'amico era diventato
paonazzo dalla bile e dall’odio e che il gesto di volergli
fracassare il cranio con la pistola ne era la conseguenza.
L'ira di Saro scoppiò. D'altronde attendere la confessione di
Leo significava perdere ancora tempo e correre ulteriori
inutili rischi. E comunque non era necessaria.
- Tu sei stato sempre un verme. La tua auto, quella carriola
vecchia che hai dato in permuta a maggio, quando ti hanno
regalato questa nuova, la sera dell'antivigilia di Natale
perché si trovava in campagna, da mio padre?
- Non so nulla …
Improvviso Saro fece un passo avanti e colpì Leo con un
calcio in uno stinco. Leo istintivamente scattò in piedi come
per rispondere all’aggressione di Saro, ma questi fece un
passo indietro e puntandogli la pistola in faccia: - Sta' calmo
e siediti…
Leo si rimise lentamente a sedere.
- Con una gamba nel pozzo! - scandì Saro con tono sfottente.
Leo ormai aveva capito che non c'era più alcuna speranza,
ma se voleva tenerne vivo qualche barlume, anche uno solo,
doveva assecondare Saro, in attesa.
Fece quindi passare una gamba al di là del muretto, che si
trovò penzolante nel vuoto, intrecciò le dita delle mani e le
posò sulla testa.
- Riprendiamo; e veloci, che si fa tardi …
- Puoi anche ammazzarmi, ma non so nulla.
- Lo farò subito se mi fai perdere la calma.
- Mi puoi ammazzare.
- Allora parlo io. Il pomeriggio dell'antivigilia di Natale tu
sei andato a cercare mio padre, in campagna. Nessuno ti ha
visto; o almeno così hai creduto tu. Ma io ho visto le
impronte della tua auto davanti a casa mia, in campagna, a
Gammara. Le avevo fotografate nel cervello. Per maggiore
sicurezza le ho fotografate di fatto mentre mio padre era
ancora disteso morto sul letto, in mezzo a casa. La
provenienza l'ho cercata per molto tempo. L'ho cercata
dappertutto. Non pensavo che fosse tanto vicina. Né potevo
immaginare che fossero le impronte dell'auto di una carogna
che ancora asserisce di essere il mio migliore amico.
Il giorno in cui mi hai chiesto di farti compagnia per
depositare l'auto da Occhivirdi un lampo mi ha avvampato il
cervello. Scendendo dall'auto notai le gomme. Avevano il
battistrada che cercavo. Non potevo crederci. Ritornai dopo
due giorni. Rividi quelle gomme. Le fotografai. Ho fatto
anche degli ingrandimenti. Ve n'era una differente dalle altre
e fu la prova del nove: le impronte erano quelle.
- E con questo cosa vuoi provare?
- Che tu sei stato a cercare mio padre. Lo hai negato e quindi
sai. Ora parla!
- Io dovevo solo dirgli che doveva recarsi subito alle case di
Sirignano. La frase che dovevo dire era: "ricotta o non
ricotta c'è sempre la pagnotta". Questo dovevo dire, io.
Appena glielo dissi tuo padre immediatamente si mise in
auto e partì. Non so più niente. Io seppi della disgrazia
quando tornai da Milano, a Capodanno. In una busta, sul
tavolo, tornando a casa avevo trovato un biglietto d'aereo
intestato a nome mio di andata e ritorno da Milano. Mia
madre disse che l'aveva trovato in una busta sotto la porta di
casa. Non sapevo nulla ma capii che quella sera stessa
dovevo partire. E partii -.
Leo si fermò sperando che la spiegazione fosse stata
sufficiente per scagionarlo da ogni responsabilità.
- E poi? - riprese incalzante Saro.
- Poi …, poi tornai a Capodanno.
- E poi?
- Nulla. Non so più nulla. Te lo giuro.
- L'auto chi l'ha pagata? Quindici giorni prima della morte di
mio padre mi avevi confidato che non avevi una lira. Tre
mesi dopo l'auto nuova.
- Mi hanno detto che il prezzo era buono. Senza interessi.
Senza cambiali. Senza scadenze. Insomma qualcuno mi
disse che se non avessi avuto i soldi per pagarla non dovevo
preoccuparmi, perché nessuno mi avrebbe cercato e perché
l'amico si riconosce al bisogno ed è per sempre.
- Occhivirdi! - interruppe Saro.
- Occhivirdi … - ammise Leo. E approfittando di un attimo
in cui Saro aveva sollevato gli occhi verso la luna, più chiara
che mai in quell'immenso buio sulla terra e nel cuore, tentò
uno scatto. Ma, nell'appoggiare le mani sul muretto del
pozzo, un calcinaccio si sgretolò sotto la pressione. Perse
l'equilibrio. Saro scattò in avanti e allungò con violenza una
pedata. Colpì con la pianta della scarpa un fianco di Leo, che
non riuscì ad afferrarla.
Poi tornò all’auto. Si mise alla guida e partì. La lasciò in
periferia nel paese. Si mise a letto, ma quella notte non riuscì
a prendere sonno.
Un urlo disperato fu l'ultima cosa che Saro ora ricordava di
lui; e un tonfo.
Fissava il nero uniforme di quella casa e nel ricordo ancora
non riusciva a distinguere se provava odio o pietà per quel
traditore. Di certo non provava rimorso. Nessuno aveva più
sentito parlare di lui. Qualcuno disse di averlo intravisto in
America, in compagnia di una mulatta. Altri che era stato
vittima della lupara bianca. I parenti pensarono che un
giorno, all'improvviso, sarebbe tornato. Chi sperava di più
era Dora, sua madre; ma nel cuore lei aveva il presentimento
che Leo era morto; nessuno sapeva dove, né perché. Da anni,
ogni domenica, dopo la messa, si recava al cimitero, a far
visita alla tomba del marito, morto di cancro da oltre dieci
anni. Ora avrebbe avuto un motivo in più.
Lucio e Saro si conoscevano da quattro anni. Entrambi si
erano iscritti nella facoltà di Giurisprudenza, lo stesso
giorno, e il numero di matricola di Lucio seguiva quello di
Saro.
Avevano avuto un alterco rivendicando ognuno il diritto di
precedenza per la presentazione della domanda di iscrizione,
davanti allo sportello della segreteria. Poi avevano concluso
col darsi la precedenza l'un l'altro. Si era iscritto per primo
Saro, ma aveva dovuto offrire da bere a Lucio per la
precedenza accordatagli.
Dapprima fu conoscenza, simpatica conoscenza. Si rividero
dopo un mese. Fu amicizia e cordiale amicizia. L'esuberanza
di Lucio si confaceva perfettamente con la riservatezza di
Saro. Lucio era un buon parlatore, Saro un buon ascoltatore.
Talvolta Lucio restava a Palermo, ospite nella casa che Saro
aveva preso in affitto per gli studi, e dormiva e mangiava
insieme con lui.
Entrambi seguivano le lezioni, si scambiavano gli appunti,
preparavano le stesse materie per gli esami, si direbbe che
prendevano gli stessi voti. Erano stati piuttosto regolari nel
superare gli esami previsti dal loro piano di studi.
All'inizio del quarto anno Saro disdisse l'affitto dell'alloggio
a Palermo. Avrebbe continuato gli studi senza frequentare le
lezioni. Ciò avvenne subito dopo la morte del padre. Lucio
aveva insistito perché Saro continuasse a frequentare le
lezioni, ma poi aveva capito, o almeno pensò di avere capito,
e si arrese. Malgrado ogni insistenza di Lucio, col quale si
incontrava talvolta, Saro non si presentò più agli esami, ma
l'amicizia si rafforzò.
Tra amici le confidenze avvengono spontanee. Nessuno
forzò mai l'altro a parlare. Lucio aveva intuito che un grosso
problema opprimeva l'amico e che la morte del padre ne era
la causa. Quando superava un esame era Saro il primo a cui
comunicava l'esito e in tal modo era giunto quasi al termine
di tutti gli esami. Gliene restavano due complementari, che
sicuramente avrebbe superato entro il mese di giugno; e la
tesi di laurea, che pure era a buon punto.
- Peccato! - disse una sera, contento per se stesso, ma
dispiaciuto per l'amico, - avremmo potuto preparare insieme
la tesi.
Non si attendeva alcuna risposta. Saro invece rispose:
- Sbrigati a laurearti. Se mi serve un avvocato so a chi
rivolgermi. Io ormai mi dedicherò alla conduzione dei
terreni di famiglia. Mi rendo conto che me la cavo
discretamente …
Il discorso sembrò finire lì. Poi Saro, accostata l’auto, di cui
era alla guida, lungo il marciapiede della strada, deserta a
quell’ora, riprese:
- E' vero che se ne avrò bisogno mi difenderai?
- Ma non dire cazzate! Comunque, avvocato o non avvocato,
sai che sono a tua completa disposizione …
- Sono siciliano e ho imparato che qui, in Sicilia, la
prepotenza è sinonimo di mafia. Se la subisci sei un
coglione. Se la eserciti sei un mafioso, anche quando la tua è
rivendicazione … Molti, che da fuori Sicilia vengono
sbattuti qui dalla buona o dalla mala sorte, ritengono che i
siciliani siano tutti, nessuno escluso, delinquenti e mafiosi.
Questi soggetti non hanno neppure la capacità di distinguere
tra persone oneste, delinquenti scalcagnati e mafiosi di
rango. E non capiscono neppure se il proprio comportamento
sia mafioseggiante …
Sentiva che si andava accaldando. Se ne accorse anche
Lucio.
- Senti, Saro. - Lo interruppe Lucio - E' inutile che ti scaldi,
come al solito. Non risolverai tu la questione meridionale e
tanto meno quella della Sicilia …
- Quattro sbarbatelli giunti dal nord credono di poter
raddrizzare le zampe ai cani. - Continuò Saro - Non perché
noi siciliani siamo da paragonare ai cani, ma perché
raddrizzare le zampe ai cani, tu mi capisci, è pressoché
impossibile, salvo a volerne cambiare la natura. Natura che
nel siciliano è fondamentalmente buona, generosa, altruista,
quasi sempre disinteressata.
- Beh, sul disinteressata avrei qualche riserva …
Saro, quasi senza ascoltarlo, continuò:
- Chi viene in Sicilia per giudicare, o per indagare, avrebbe
bisogno di un lungo periodo di quarantena, possibilmente
diviso tra i quartieri più malfamati di Palermo e gli androni
dell'Ucciardone; non in qualità di detenuto, ma in qualità di
osservatore e vivendo gli stessi problemi di coloro che
vivono a Ballarò, alla Vucciria, al Capo e all'Ucciardone
appunto. Solo allora, forse, sarebbe in grado di distinguere
tra ladri senza colpa, delinquenti senza testa e mafiosi
spudorati e cinici. Ma lo stato non si preoccupa di far
frequentare loro neppure un corso accelerato di psicologia
generale. Con l'assurda conseguenza che questi tali,
nell'intento di voler aiutare il popolo siciliano, avendone la
possibilità, si comportano come si comporta un mafioso:
impongono la loro autorità, senza un minimo di logica. Con
la forza della violenza. Non violenza fisica. Ma giuridica e
costituzionalmente riconosciuta.-
Lucio stava a guardarlo chiedendosi dove volesse andare a
parare l'amico, il quale, ripreso fiato, continuò: - Il pubblico
ministero accusa perché quello - dice - è il suo dovere e il
giudice per le indagini preliminari colpevolizza col
paraocchi del codice penale. Non possono tenere conto delle
cause di un reato. Come i militari: con l'ottusità propria della
vita militare, che ha per regola unica l'obbedienza
incondizionata, ovunque e sempre. Ma il siciliano, in
generale, non è ottuso. Non è mafioso. Non è delinquente! -
proseguì Saro, mentre Lucio lo stava a guardare annoiato.
- Qualcuno commisera il siciliano, ma sicuramente il
siciliano non sa che farsene della pietà degli altri ed è molto
geloso del suo diritto, benché molto spesso il suo diritto non
sia scritto nei codici: egli pretende unicamente rispetto -
aggiunse Lucio, tanto per dire qualcosa, nella speranza che
Saro chiudesse la sua arringa.
Invece Saro riprese con maggior foga: - Il codice sancisce il
diritto del più forte; di colui che ha fatto proprio il potere e
che quindi ha avuto la possibilità di legiferare e di
normalizzare la vita della società ad esclusivo proprio
tornaconto. -
Sembrò avere esaurito tutte le cartucce. Invece riprese con
passione: - Vivere in Sicilia è tra le cose più belle che
possano capitare ad un uomo, purché egli abbia almeno
accettato, dico accettato, di trascorrervi la propria esistenza.
E per la natura che lo circonda e per gli esseri umani in
mezzo ai quali vive, tenendo presente che se il vivere in
qualsiasi paradiso terrestre non è frutto di scelta propria il
vivere stesso diventa un inferno; non solo in Sicilia.
Se poi la malvagità di alcuni siciliani, molto pochi in verità,
è tale da risultare particolare e specifica rispetto a quella che
si nota presso altri luoghi d'Italia e del mondo, ciò non può
indurre chicchessia a ritenere la parola siciliano sinonimo di
mafioso. La mafia esiste. Ma la Sicilia non è la mafia -.
Lucio, palesemente annoiato, lo interruppe: - Senti, Saro. Mi
hai rotto le scatole: tu, la mafia, la Sicilia, la Sardegna, la
Calabria e chi minchia ti sta a cuore ... -
Ma Saro, quasi inebriato dal proprio pensiero e dalla propria
oratoria, proseguì: - La mafia è la parte emergente di un
iceberg. Sotto il livello dell'acqua vi è tutto il popolo
siciliano; quel popolo che da millenni è schiacciato da una
minuscola parte di siciliani e non siciliani; che hanno
legiferato e hanno reso normale la vita di centinaia di
generazioni, fatta soltanto di sofferenza e di sottomissione.
Chi giudica dall'esterno non riesce neppure a scorgere i
problemi che si nascondono in quella parte di iceberg che è
sotto, negli abissi del mare. Quella parte nascosta e
silenziosa sarebbe capace di risolvere i propri problemi se
solo riuscisse ad emergere un istante per prendere una
boccata d'aria e un po' di calore, di quel sole che appartiene a
tutti. Vedreste quell'iceberg capovolgersi e quella parte
emergente, che oggi si chiama mafia, sparire negli abissi e
sciogliersi per sempre. Ma questo calore tarda ad arrivare.
Le acque non si riscalderanno mai e tutto conserverà lo
status quo. -
Saro sembrò stanco. Finalmente aveva finito di sproloquiare,
pensò Lucio. Invece, dopo una breve pausa, riprese: - ma né
lo Stato, e tantomeno uno Stato in combutta con i mafiosi,
permetterà mai al popolo siciliano di essere intraprendente.
Le leggi che vengono emanate non sono tali, e non sono
volute tali, da favorirne lo sviluppo e ogni iniziativa è
destinata a morire prima che sia concepita, a favore dei
pochi, dei cinici. Chi non conosce il siciliano dice che è
"lagnusu". Ma così non è. Il siciliano non vuole lavorare per
chi lo vuole sfruttare. Il siciliano è nato libero e libero vuole
restare, sottoposto soltanto a leggi giuste. Dategli lavoro a
cottimo e sarà capace di lavorare ventiquattrore al giorno.
Proponetegli di prodigarsi per chi ha più bisogno di lui e lo
scoprirete capace di sacrificare anche la vita per gente che
neppure conosce. E lo chiamano mafioso. -
- Ma dimmi. Cosa vuoi dimostrare con tutto questo
panegirico? Per caso hai deciso di darti alla politica e intendi
fare qualche prova di comizio con me? - lo interruppe Lucio.
- No, Stronzo. Voglio dimostrarti che al di sopra di te e di
me c'è solo Dio. Gli altri sono merda; puzzolente per giunta,
quando vogliono atteggiarsi a giudici del popolo siciliano, il
quale ha sempre subìto il potere della mafia: reale, politica,
religiosa. Ora anche il potere di coloro che dovrebbero
combatterla, dei padroni dei tribunali. Questi poi sono gli
stronzi e i disonesti per eccellenza. Coloro che prima o poi
prenderanno il posto degli attuali mafiosi e saranno ancor
più spietati di questi.
E ora fammi la cortesia. Vai a fare in culo anche tu, insieme
con loro - concluse Saro.
- In culo ci vai a fare tu e tutti quelli come te! - rispose
Lucio, ringraziando il cielo che Saro avesse posto un punto
al suo discorso, anzi al suo sproloquio. E, prima che egli
potesse ricominciare, aprì lo sportello, scese e, senza
aggiungere una parola, si allontanò in direzione della propria
auto.
Saro restò seduto al volante della sua. Chiuse gli occhi,
stanco. Mille pensieri gli attraversavano la mente. Pensava a
suo padre, a Leo, a Lucio, a Ilenia, la sua ragazza, a sua
sorella Amalia, a sua madre, ridotta già vecchia a
cinquant'anni; e infine pensò a Occhivirdi.
Molto tempo doveva essere passato quando riaprì gli occhi.
Si guardò attorno. Solo un gatto, accovacciato sul cofano
dell'auto, davanti al parabrezza, lo fissava tranquillo. Mise in
moto. Il gatto saltò a terra e l'auto si mise in movimento.
Occhivirdi, un uomo sui trentotto anni, era seduto con le
gambe distese sotto la scrivania e fissava il muro di fronte
quando Saro entrò nell'autosalone. Tirò a sé le gambe e rizzò
il busto sulla sedia.
Conosceva Saro Capizzi di vista. Ricordò di averlo visto un
paio di volte nel proprio locale. Era un ragazzo a posto:
almeno così dicevano quelli che lo conoscevano.
Con la mano destra aperta si diede una stiratina ai lunghi
baffi e con gli occhi accompagnò il cliente fino al proprio
tavolo.
- In che cosa posso essere utile? - disse.
- Cerco un'auto.
- Tutte le marche e tutti i modelli che vuole, sia nuove che
usate. Dipende solo da quanto vuole spendere. - E mentre
parlava Occhivirdi incominciò ad aprire dei dépliants,
posandoli aperti uno sull'altro, mostrandoli tutti, ma senza
che se ne potesse osservare uno.
Saro lo lasciò fare mentre con lo sguardo cercava. Cercava
attorno. Ma più che per trovare cercava di indovinare…
Doveva essere lì, all'angolo della stanza, a due metri da lui.
Cominciò a valutare i vari modelli delle varie marche di
autovetture, mentre Occhivirdi gli faceva notare i pregi di
questa o di quella, come si sarebbe potuto risparmiare
qualche milione, gli optionals, ciò che era di serie e ciò che
era facoltativo.
Squillò il telefono. Occhivirdi prese la cornetta e ascoltò.
Non disse nulla. Dopo pochi secondi la posò, turbato; chiese
scusa al cliente e, allontanandosi in modo affrettato, disse: -
lei continui pure; io mi assento cinque minuti contati. Sto
tornando. -
Saro sollevò gli occhi lentamente e non lo vide uscire. Sentì
il rumore di un motore d'auto che veniva acceso e subito
dopo lo stridio delle ruote sull'asfalto.
Si diresse all'angolo della stanza, aprì lo schedario, cercò
"Miccoli Leonardo". Nulla. Cercò freneticamente per
qualche minuto. Niente. Poi quasi per caso lesse "Crispotti
Dorotea". Era andato già oltre, ma tornò indietro. Dora si
chiamava la madre di Leo e Crispotti, ne aveva una vaga
sensazione, doveva essere il suo cognome. In un attimo
controllò numero di targa, marca, tipo, data di
immatricolazione, intestataria, data di nascita. Sul retro, a
matita, il numero di un assegno bancario e la cifra. Sotto :
"NINO BONCORE", pure a matita.
La depose e chiuse il cassetto in metallo. Lentamente si
diresse verso la vetrata di ingresso e attese. Dopo alcuni
minuti Occhivirdi era già di ritorno.
- Ci sono stronzi in giro che non sanno come passare il loro
tempo. Comunque lei ha deciso qualcosa? -
- Qualche idea va maturando, ma niente di preciso ancora. Ci
rivedremo. - Così dicendo allungò la mano per salutare.
Occhivirdi gliela strinse e: - Arrivederci! Arrivederci! -
rispose.
Saro si accomodò lentamente sul sedile della sua auto, mise
in moto e partì. Andò senza una meta, molto lentamente.
Quando si fermò era in uno spiazzo, davanti alla Funtanazza,
una vecchia fontana saracena, in mezzo ad alti alberi di pino
e di cipresso, che per secoli insieme con l'edera l'avevano
soffocata, nel mezzo della montagna.
Quell'Occhivirdi doveva essere uno che si faceva proprio gli
affari suoi. Vendeva auto e non faceva domande.
Sicuramente non sapeva, o si rifiutava di sapere, perché
Nino Boncore aveva pagato l'auto di Crispotti Dorotea,
madre di Leo. Per lui importante era vendere e che qualcuno
pagasse. Del perché … no comment.
Aveva fatto molta fatica Saro per controllarsi dinanzi a lui,
dopo aver letto la scheda. Lo stratagemma era riuscito. Ora
si mordeva il labbro inferiore, quasi da farselo sanguinare,
ma doveva controllarsi e doveva ragionare.
Nino Boncore era stato amico di suo padre. Gli aveva
portato rispetto, non gli aveva fatto mai uno sgarbo e non ne
aveva ricevuti. Eppure Nino Boncore aveva ammazzato, o
aveva fatto ammazzare, suo padre. Ne era certo: il
responsabile era lui e soltanto lui.
Da parecchi mesi non si dava pace, Saro.
Leo aveva ricevuto ordini e non aveva detto da chi. Poi il
tonfo nel pozzo aveva tolto ogni possibilità di saperlo da lui.
Occhivirdi era una traccia, una buona traccia, ma non aveva
avuto mai relazioni con suo padre. La scheda avrebbe potuto
parlare ancora. Lo aveva pensato fin dai primi giorni, dopo
la scomparsa di Leo. Aveva escogitato mille stratagemmi per
giungere a quella scheda; alla fine aveva optato per il più
semplice. Lucio aveva telefonato mentre egli era
nell'autosalone e il nome di Nino Boncore era saltato fuori,
quasi inaspettatamente.
- Ma perché Nino Boncore? - si chiedeva. Il cervello se lo
sentiva scoppiare alla ricerca di una risposta a quel perché.
Una cosa era certa: Nino Boncore era condannato, era un
cadavere ambulante. Ma bisognava fingere per non
compromettere tutto e per non restare fottuto..
Avviò il motore e discese in paese.
Una domenica, una di quelle domeniche siciliane, calde e
quasi estive, Lucio, di buon mattino, era venuto, invitato, a
trovare Saro.
Ilenia, la ragazza di Saro, li attendeva già da mezz'ora
quando passarono a prenderla insieme con Amalia, sorella di
Saro.
Tutti indossavano jeans e maglietta. Giacche e giubbotti
furono accatastati sul pianale dell'auto, sotto il lunotto
posteriore. Si diressero verso il mare. Pranzarono in una
trattoria, né bene né male. Poi Saro, senza dire nulla, li fece
rientrare tutti in auto e ritornò al paese. Lo costeggiò, svoltò
per una stradina sterrata e s'inerpicò sulla montagna.
Lo lasciarono fare. Le buche e i sobbalzi dell'auto aiutarono
la digestione, tra le risate di tutti; e quando furono in cima un
panorama immenso e splendido era sotto i loro occhi. La
stradina percorsa era scomparsa sotto la fitta boscaglia,
immobile e quieta. Lontano il paese mostrava appena i suoi
vicoli che si indovinavano tra il procedere parallelo delle
case, piccole case, che un masso lasciato rotolare lungo il
pendio sembrava potesse facilmente schiacciare. Poi,
degradando dolcemente, la campagna, spartita in forme
geometriche e di vari colori, giungeva al mare, lì dove il
riverbero del sole disegnava una strada luminosa pura,
immensa e dritta verso l'orizzonte.
Saro invitò tutti a seguirlo per una breve scalata a piedi,
ancora più su. Ilenia e Amalia preferirono restare a
chiacchierare tra gli alberi, nei pressi dell'auto. Lucio, pur
lamentandosi, seguì l'amico che già s'inerpicava. Salirono
per circa mezz'ora, seguendo le piste tracciate dal passaggio
degli animali selvatici, in mezzo alla sterpaglia.
Saro era venuto fin quassù solo una volta, quand'era ragazzo,
insieme col padre, in una giornata di caccia. Ora su tutta la
montagna era vietato cacciare, perché zona demaniale e
protetta, e solo le guardie forestali raramente arrivavano fin
quassù. Allora il padre gli aveva mostrato una sorgente che
formava un minuscolo lago nella roccia per poi inabissarsi
nelle viscere della terra. La trovò. Il laghetto gli sembrò
molto più piccolo, ma era come una volta. Sulla destra, a
pochi metri, la parete rocciosa si ergeva quasi a picco. Lassù,
gli aveva detto suo padre, un tale si era nascosto per ben tre
anni, senza che la polizia riuscisse a scovarlo. Volle vedere il
nascondiglio. Aiutato da Lucio s'arrampicò sulla parete.
Trovò degli spuntoni che lo agevolarono nella scalata. A
cinque metri d'altezza trovò un piccolo spiazzo, quasi piano,
che conduceva in una crepa, larga meno di un metro. Vi
entrò. La crepa si allargava all'interno fino a raggiungere la
larghezza di circa tre metri. Era alta oltre due. Nell'insieme
una comoda stanza. Ridiscese quasi senza fatica e subito.
- Lucio! - disse - non parlare con nessuno di questo posto. E'
unico, in caso di bisogno. Si chiama "la sorgiva". -
Lucio non rispose. Raggiunsero senza fretta le ragazze e
tornarono in paese.
All'interno della vecchia casa di Gammàra Saro attese
immobile alcuni minuti. Poi con una piccola torcia elettrica
si aiutò a cercare la porta di uno stanzino. L'aprì e, come
aveva desiderato, trovò il lettino completo di materasso,
lenzuola e coperte. Vi era anche un bidone d'acqua di venti
litri. Fu come se sua madre e sua sorella lo abbracciassero.
Non piangeva, ma una guancia, si rese conto, ebbe un
sussulto di commozione: non lo avevano dimenticato. Si
tolse le scarpe e, vestito, così com'era, si infilò sotto le
coperte. Si sforzò di pensare, ma s'addormentò subito.
All'alba lo svegliarono i rumori dei trattori e dei camions che
si recavano al lavoro. Richiuse gli occhi sforzandosi di
riprendere sonno, ma non vi riuscì.
La luce intanto penetrava pungente da alcune fessure tra le
tegole, in alto, e da un finestrino, pure in alto, chiuso
malamente da uno sportello in legno. Fino allo sportello
saliva una cordicella che, tirata, faceva scattare una molla e
lo apriva. Ma Saro non l'aprì. La penombra gli permetteva di
distinguere ogni cosa nello stanzino. Accanto al letto un
comodino. Più in là un piccolo armadio e una sedia. Sulla
sua testa, attaccato al muro, un Crocifisso minuscolo e
l'immagine della Madonna dei Miracoli.
Lentamente si tolse le coperte di dosso, infilò le scarpe ed
entrò nella stanza attigua. In un angolo un vecchio trattore
arrugginito; appesi alle pareti alcuni arnesi da lavoro
appartenuti a suo nonno e mai usati da suo padre. Lontano
dalla porta d'ingresso tre fusti in plastica, pieni d'acqua,
coperti da una larga tavola.
In quella che era stata la cucina trovò un fornello, una
bombola di gas, alcuni piatti, delle posate, alcuni pacchi di
pasta, alcune bottiglie di vino, olio, sale, aceto, caffè,
zucchero e alcuni pacchi di fette di pane biscottato.
Non comunicava con sua madre e sua sorella da otto mesi;
da quando aveva detto a tutti che partiva per la Germania.
Solo sua madre, la signora Letizia, non aveva creduto alla
sua partenza per la Germania. - Questa Germania è troppo
vicina; sarei meno angosciata se fosse più lontana! - gli
aveva detto abbracciandolo e piangendo.
Cinque giorni dopo, alle quattro del mattino, tre camionette
della polizia avevano circondato la casa della signora
Letizia, gliel'avevano perquisita da cima a fondo senza darle
alcuna spiegazione. Le avevano chiesto dove fosse Saro.
- A Bonn, in Germania! - avevano risposto madre e figlia
contemporaneamente.
- L'indirizzo non ce l'ha mandato ancora - aveva aggiunto
Amalia.
Poi se n'erano andati senza dare spiegazioni e senza salutare.
La notizia della perquisizione in casa di sua madre e che egli
presumibilmente era ricercato Saro l'apprese da un trafiletto
posto nella pagina della cronaca della provincia di Trapani, a
Messina, mentre sorseggiava il caffè in un bar nei pressi del
porto. Non ne era rimasto sorpreso e poi, come era già nei
programmi, tornò indietro. Salì su un autobus per Catania e
da Catania a Palermo, sempre in autobus, per eludere la
vigilanza della polizia e dei carabinieri. Con un autobus
cittadino si recò a Monreale. Attese Lucio nei pressi
dell'abitazione e quando, a ora di pranzo, questi con la sua
utilitaria di piccola cilindrata fece rientro a casa, senza
parlare, col cenno di una mano, come se facesse autostop, gli
chiese un passaggio.
Lucio accostò l'autovettura al marciapiede, lo fece salire, lo
abbracciò e non disse nulla. Neppure Saro parlò. Poi
lentamente l'autovettura si mise in movimento, passò dinanzi
al Duomo e fece ritorno a Palermo.
Nella via Giovanni da Procida, una traversina della via
Roma, Lucio da tempo aveva preso in affitto un
appartamentino, nei pressi della facoltà di Giurisprudenza,
dove spesso restava a dormire. Qui fermò l'autovettura, tolse
due chiavi da quelle appese al cruscotto e le diede a Saro
insieme con mezzo chilo di pane, che aveva sul sedile
posteriore.
- A più tardi - gli disse, abbracciandolo.
Saro, quasi automaticamente, scese dall'autovettura, aprì il
portoncino, salì al primo piano, aprì la porta d'ingresso,
richiuse, si guardò attorno, raggiunse una sedia presso il
tavolo al centro della stanza, si sedette, incrociò le braccia
sul tavolo e su queste posò la fronte.
Tre mesi aveva trascorso nella via Giovanni da Procida, a
Palermo. Lucio andava a trovarlo una volta la settimana con
le provviste alimentari necessarie, qualche giornale e
qualche libro. Non fumavano, né l’uno né l’altro.
Alla fine Saro decise di spostarsi. L'aria afosa della città
cominciava a diventare irrespirabile. Prese le poche cose che
portava con sé. Caricò tutto, con qualche coperta e alcuni
sacchi di plastica, sull'autovettura di Lucio e insieme con lui
andarono ad Alcamo, in una sera senza luna, col cielo
trapunto da una miriade di stelle. Costeggiarono il paese.
Salirono sul monte Bonifato e, nello stesso luogo in cui
alcuni mesi prima erano venuti in compagnia di Amalia e di
Ilenia, si fermarono.
- Scarichiamo tutto qui. Tu vattene. Ci penso io a portare
tutto alla Sorgiva - disse Saro.
- Ok! - rispose Lucio, quando ebbero finito di scaricare; - ci
vedremo fra una settimana.
Si abbracciarono. Non dissero più nulla. Nel silenzio della
pineta udirono soltanto i loro respiri affannosi. Chiunque li
avesse minacciati in quel momento sarebbe stato strozzato
senza una parola.
Era chiaro che Amalia e sua madre - pensò - erano venute
qui, a dare una sistemata alla meno peggio. Ad esse Saro non
aveva né telefonato né aveva mandato notizie mai. Lucio, di
sua iniziativa, alcuni giorni dopo che l'amico si era stabilito a
Palermo aveva incontrato Amalia, a sua insaputa, un sabato
sera mentre faceva rientro a casa. Le aveva detto di non
preoccuparsi per Saro, di non attendere notizie e che finché
non ne avevano sarebbero state soltanto buone notizie. Né
dovevano mai telefonargli. L'aveva salutata ed era quasi
fuggito, senza darle alcuna possibilità di fare domande.
Poi più nulla.
Nei primi giorni le donne si erano insospettite. Si erano fatte
mille domande senza riuscire a darsi una spiegazione, una
sola. Poi la signora Letizia aveva incominciato a intravedere
una parvenza di spiegazione. Dapprima, non seppe mai
perché, incominciò a collegare la morte del marito, benché
accidentale, con la fuga improvvisa del figlio. In seguito si
fece sempre più strada il sospetto che la scomparsa di Leo
doveva essere collegata alla fuga di Saro, ma non trovò un
filo logico che congiungesse anche uno solo degli
avvenimenti all'altro. Poi ne fu certa, benché la logica non le
desse una mano. Non comunicò mai i suoi sospetti ad
Amalia. Una sera, però, mentre cenavano, entrambe
pensierose, la signora Letizia disse alla figlia: - per tutti Saro
è in Germania, anche per me e per te. Finché non accadrà
qualcosa in paese vuol dire che è al sicuro …
Amalia guardò la madre sbalordita, ma non capì. Nel suo
sguardo c'erano mille domande, ma non fece neppure una.
Avrebbe voluto chiedere, sapere, ma il viso della madre era
impenetrabile, più ermetico d'una cassaforte con apertura a
combinazione. Provò tanta pietà per quella vedova
disgraziata, tanto odio per il fratello che era fuggito e non
aveva dato alcuna spiegazione e anche per quello stupido di
Lucio, che le aveva parlato camminandole al fianco,
all'improvviso, quel sabato sera e si era allontanato quasi
prima che l'avesse riconosciuto. Col passare dei giorni però
si disse che l'unica stupida era lei, che non riusciva a capire.
Tra le mille supposizioni che aveva fatto sicuramente c'era
quella giusta, ma non riusciva a focalizzarla. Con la madre
era impossibile parlare di Saro. Si chiudeva in un mutismo
ermetico e dava l'impressione che dopo il marito supponesse
chiuso in una tomba anche il figlio. Agli estranei che le
chiedevano notizie di lui rispondeva invariabilmente: - sta
bene, lavora … Ma in cuor suo ogni sera attendeva con gli
occhi rivolti alla porta d'ingresso e in piena notte, quando
tutto taceva, poneva attenzione a ogni più leggero rumore e
il cuore le sussultava per l'ansia nell'attesa, là dove altri cuori
avrebbero avuto sussulti di paura. Ma quel figlio, lo sentiva,
pur tanto vicino, non poteva che essere lontano e ne aveva
tanta pietà per i giorni neri che intravedeva per lui; eppure,
anche questo sentiva nel più profondo delle viscere, ne era
tanto orgogliosa e non lo avrebbe barattato col mondo intero.
Un giorno, sul finire del mese di agosto, poco prima di
mezzogiorno, bussarono alla porta. Aprì la signora Letizia.
Si trovò dinanzi Pietro, un uomo sui cinquant'anni con una
cassetta di pomodori tra le mani.
- Mi dica dove la devo posare - le disse; e senza attendere di
essere invitato ad entrare si incamminò nell'ingresso, posò la
cassetta per terra e: - siete sola? - chiese.
- Si.
- Vi devo parlare e me ne devo scappare; chiudete la porta.
Questa mattina, all'alba, quando sono arrivato nella mia
campagna ho notato sullo stradale una camionetta dei
carabinieri. Non ci ho fatto molto caso. Poi, mentre mi
preparavo a raccogliere il pomodoro, a distanza, vicino alla
vostra casa di campagna, a Sirignano, ho visto due
cacciatori. Sapete, da poco si è aperta la caccia. Però subito
mi hanno dato l'impressione che non andavano a caccia.
Sembrava che cercassero qualcosa o qualcuno; tanto che
hanno fatto il giro attorno alla vostra casa almeno tre o
quattro volte mentre li guardavo io, con gli occhi tra le
tapparelle delle persiane di casa mia. Credo non si fossero
accorti del mio arrivo. Poi hanno fatto un giro largo largo col
fucile sulla spalla e si sono diretti verso la camionetta dei
carabinieri. Vi sono saliti e tutti se ne sono andati. Penso che
dovevano essere tutti carabinieri. Spero che non vi siate
offesa se mi sono permesso. Non so neppure io perché sono
venuto a dirvi queste cose e comunque … non vi sto dicendo
niente. Non ditemi nulla e non domandatemi nulla: mi ha
fatto piacere rivedervi. Saluti da parte di mia moglie e fatemi
l'onore di assaggiare questo pomodoro, che è veramente una
squisitezza, quest'anno.
- Grazie, Pietro. Ricambiate i saluti a vostra moglie e ditele
che le sono tanto grata per il pomodoro. -
Fece appena in tempo a toccare la mano di Pietro in segno di
saluto ché questi era già fuori dalla porta, diretto verso il suo
furgoncino.
Pietro era alto un metro e mezzo appena. Quando parlava
riusciva a non farsi interrompere mai e tra una parola e l'altra
non si percepivano intervalli. Parlava soltanto quando
riteneva interessante ciò che doveva dire. In genere era un
uomo silenzioso, ascoltava a lungo, anche i discorsi inutili.
Buon osservatore, difficilmente gli sfuggiva ciò che
accadeva intorno a lui e per sua natura era portato a
collegare atteggiamenti e parole delle persone anche a
distanza di molto tempo. Per questo era stata persona
apprezzata dal marito della signora Letizia e per questo la
signora Letizia stessa lo aveva sempre apprezzato. Era la
prima volta che si presentava in casa sua dopo la morte del
marito. Quel pomodoro, la signora Letizia l'aveva capito
subito, non c'entrava affatto con quella visita. La moglie di
Pietro non ne sapeva nulla e sicuramente non avrebbe mai
saputo nulla del vero motivo di quella visita. Pietro era stato
chiaro. Lei si sentiva impotente. Si augurava soltanto che
Saro fosse lontano; lontano da Alcamo e particolarmente da
Sirignano.
La vecchia casa di Gammàra era stata sequestrata dallo
Stato da almeno trent’anni, quando proprietario
dell'immobile era ancora Nicola Capizzi, suo suocero,
implicato nel processo dei centosessantadue, a Catanzaro.
Il vecchio, riconosciuto innocente, era stato assolto. Presto
però era morto d'infarto. Lo stato ormai sembrava si fosse
dimenticato di avere sequestrato quella casa col terreno
circostante e tutti in paese attribuivano, come avevano
sempre attribuito, la proprietà ai Capizzi. I Capizzi non
s’erano data mai cura di richiederne il dissequestro. Ma
nessuno ci andava più. Solo Saro, ragazzotto, da solo, c'era
andato qualche volta.
Anche la signora Letizia se ne ricordò e alcune sere dopo la
visita di Pietro, mentre Amalia era fuori casa con le amiche,
volle fare una passeggiata. Da molto tempo non guidava più.
Però salì sull'auto di Saro, mise in moto e partì. Quando
giunse nei pressi della casa di Gammara rallentò, osservò i
dintorni; poi proseguì ancora e a cinquanta metri svoltò sulla
sinistra, in una stradina in terra battuta, della quale non
aveva conosciuto mai l'esistenza. Si fermò. Scese
dall'autovettura. Si diresse verso la vecchia casa dei Capizzi
e senza voltarsi infilò la chiave nella toppa, aprì la porta,
entrò e richiuse immediatamente.
Si meravigliò di non avere paura, ma si preoccupò di sentirsi
troppo sicura. Tuttavia accese una torcia elettrica e si mise al
lavoro. S'aiutò con una vecchia scopa a pulire lo stanzino e
la vecchia cucina. Con un vecchio secchio attinse l'acqua
dalla cisterna e lavò quanto trovò di lavabile. Sistemò ciò
che poté sistemare. Mentalmente prese un appunto di ciò che
era ancora necessario. Con molta cautela aprì il portoncino
d'ingresso, diede uno sguardo attorno. Richiuse e se ne andò.
Tre sere dopo ripeté l'operazione. Pasta, acqua, vino, pane
biscottato, una bombola di gas, due lenzuola, due coperte e
quant'altro occorreva scaricò nei pressi della porta
d'ingresso, a ridosso di un grosso masso di pietra.
S'allontanò per lasciare l'autovettura sulla stradina in terra
battuta e ritornò. Mise tutto in casa; preparò il letto, ordinò i
viveri in due stipetti pensili, i detersivi in una bacinella,
spolverò il fornello, il tavolo e le due sedie ancora utili, poi,
dato un ultimo sguardo a tutto al lume della torcia, la spense,
la posò sul tavolo e si avviò per uscire.
Aveva impiegato poco tempo questa volta. Aveva fatto tutto
ciò che doveva fare quasi senza accorgersene. Ad un tratto: -
Il cuscino! - si disse, battendosi una mano sulla fronte. Poi,
dopo un attimo: - ma c'è abituato, non l'ha voluto mai! - Al
buio diede un ultimo sguardo. Non scorgeva nulla, ma vide
ogni cosa al suo posto. Si rese conto che le tremavano le
mani e una certa debolezza avvertì anche nelle gambe: aveva
paura. Riappariva quella maledetta paura che l'aveva presa
quando aveva saputo dell'incidente di suo marito. Ma non
era della stessa natura; o forse sì. Anche allora aveva avuto
paura: non per se stessa, che era pronta anche a morire, ma
per i suoi ragazzi. Sì, era proprio la stessa maledetta paura.
Se qualcuno l'avesse vista e fosse andato a riferire. Con le
sue mani stava tendendo la trappola per il suo bambino, per
il suo "piccirigdru". E si mise a piangere. Per un attimo
pensò di disfare il letto, rompere tutto, portar via tutto. Poi
si ricompose. Il suo fisico era diventato energico e il suo
spirito aveva ripreso vigore. Aprì il portoncino, uscì, richiuse
e se ne andò, senza voltarsi indietro.
L'acqua già abbastanza fresca di ottobre gli schiarì la vista
e le idee. Saro fece colazione a base di pane biscottato, sale,
olio e aceto. Da tanto che non faceva colazione. Gli sembrò
quasi un giorno di festa. Per diversi giorni attese che
qualcuno venisse a cercarlo, ma fu solo con i suoi
pensieri. Anche Lucio s'era dovuto allontanare perché varie
volte s'era reso conto che veniva seguito nei propri
movimenti. Non avrebbe saputo dire da chi. Ma era certo
che veniva seguito e ne aveva fatto cenno a Saro.
- Non tornare più qui! - gli aveva detto Saro - non mi
troveresti e ti esporresti inutilmente al pericolo. La sorgiva
non è più sicura e poi comincia l'inverno. Ti ringrazio di
tutto, ma non tornare più. -
Lo abbracciò forte forte e lo spinse nell'abitacolo dell'auto. E
poiché l'amico non si decideva a metterla in moto: - vattene! -
gli gridò - vattene! -
Quella notte e l'indomani riordinò le idee e quando nella
pineta non si scorgeva più a cinque metri di distanza per le
tenebre incominciò a scendere verso il paese, con le poche
cose ancora utili nel borsone che aveva a tracolla. Lo
costeggiò, si diresse verso la vecchia casa di Gammàra e
qui stabilì la sua nuova residenza, sconosciuta a tutti e
certamente momentanea. La vita condotta in quel modo gli
sembrò inutile. Avrebbe voluto parlare con qualcuno, fare
tante domande, ma si rendeva conto che vagava solo nel
vuoto.
Una sera, alcuni giorni dopo che aveva preso possesso della
vecchia casa di Gammàra, mentre era sdraiato sul letto tutto
vestito, sentì la chiave che apriva il portoncino d'ingresso.
Avrebbe voluto nascondersi, ma non si mosse. Nell'ombra
qualcuno si diresse al centro della stanza e con voce appena
percettibile chiamava: - Saro, Saro …
Riconobbe la voce. Era sua madre. Con un balzo fu tra le
braccia di lei e senza che una sola parola fosse pronunciata
scoppiarono in lacrime entrambi mentre la signora Letizia lo
copriva di baci.
- Vieni - disse Saro, e la trascinò a sedersi al suo fianco, sul
materassino.
- Perché? - chiese la madre - Perché? Tuo padre aveva fatto
ogni sforzo per tenerti lontano dal suo mestiere e dai suoi
affari. Mi resti solo tu, colonna della mia casa. Amalia è
ingenua e ha idee moderne, da ragazza.
- E' il destino … - rispose Saro, lasciandosi stringere la mano
- una cosa voglio sapere. Boncore … che affari ha avuto con
mio padre?
- Cose vecchie, senza significato …
- Dimmele.
- Per quale motivo?
- Tu, dimmele - incalzò Saro.
- Cose di poca importanza. Una volta, appena sposata,
Boncore incontrandomi mentre uscivo dalla macelleria ebbe
a dirmi: "la carne ve l'hanno data buona? Altrimenti posso
provvedere io". Mi misi a ridere e me ne andai. Qualche
giorno dopo, a tavola, riferii ingenuamente la cosa a tuo
padre. Egli non mi rispose. Mi resi conto però che era
rimasto turbato. Solo allora capii la battuta rivoltami da
Boncore e pure io ne restai turbata. Non ne parlammo più e
non si ripeté più.
Alcuni mesi dopo qualcuno diede fuoco alla casa che i
Boncore avevano in campagna. Io lo seppi dalle vicine.
Quando lo riferii a tuo padre mi rispose: "non succede nulla
per nulla". - Ma perché mi fai parlare di queste stupidaggini
che non ci riguardano? Tu, piuttosto, dove sei stato? Come
hai mangiato? Perché te ne sei andato? Perché ti cercano?
- Papà e Boncore erano buoni conoscenti, quasi amici -
riprese Saro, non avendo neppure ascoltato le domande della
madre.
- Amici … - riprese la signora Letizia - direi che fingevano
di esserlo e Boncore faceva di tutto per avvicinarsi a tuo
padre, ma io mi rendevo conto che tuo padre non lo
sopportava e anzi cercava di evitarlo, come se la sua
vicinanza avesse potuto nuocergli. Io stessa non l'ho potuto
mai digerire. Neppure quando insieme con la moglie venne a
farci visita per la morte di tuo padre e aveva già partecipato
al funerale con una grande corona di fiori. Te la ricordi? -
- Si, me la ricordo … - rispose il giovane.
- Ora dicono che è partito. E' andato a trovare sua figlia, a
Milano.
- Ad Arcore, vuoi dire …
- A Milano, dicono … poi per me Milano, Arcore, Varese o
che so io è sempre la stessa cosa. Insomma, da sua figlia,
quella che si è sposata con quel continentale … -
- Ad Arcore è. - Poi passando ad altro discorso: - Amalia
come va negli studi? -
- Si impegna … Ma tu perché ti nascondi? Boncore, tuo
padre …, perché fai tante domande?
Ma in quel momento un lampo balenò nel cervello della
donna e venticinque anni delle vicende della sua famiglia le
apparvero nitidi e contemporaneamente dinanzi. Suo marito
probabilmente non era morto soltanto per incidente. Quella
casa di campagna non era stata bruciata per nulla, come
aveva detto suo marito, e la partenza di Boncore, la
scomparsa di quel Leo, amico di suo figlio, e la scomparsa
di suo figlio stesso, non le sembrarono più tanto casuali.
Tutto, lo intuiva, aveva un nesso. Dei singhiozzi, mal
trattenuti, le serrarono la gola. Si sentì distrutta perché a
causa sua tutta la sua famiglia si stava distruggendo. Meglio
sarebbe stato se un infarto l'avesse fatta crepare prima che
fosse partita da casa nella speranza di rivedere il figlio, quel
figlio che ora lei stessa con le sue chiacchiere stava
spingendo verso la rovina. Solo una possibilità aveva di
salvarlo: uscire da quella casa maledetta, andare dai
carabinieri e denunciare le intenzioni del figlio. Solo così lo
avrebbe salvato. E ci avrebbe pensato.
Saro intanto taceva e, stretta ancor più a sé la madre, attirò la
testa di lei sulla sua spalla mentre con le labbra le sfiorava i
capelli.
- Ilenia che dice? - chiese poi quasi controvoglia.
- Dice che non la pensi, che non le vuoi bene, che ti sei preso
gioco di lei.
- E tu dille che non è vero, che non ho tempo per scriverle,
che a Natale tornerò.
- No a Natale, figlio mio. Andiamo via ora da qui, a casa
nostra. Andiamo … non pensare più a niente. Quel che è
stato è stato. Fammi contenta, fallo per tua sorella, fallo per
Ilenia, povera ragazza; ti adora e tu sparisci senza dirle nulla.
Torniamo a casa, figlio mio, torniamo … -
- Non posso, mamma. Devo partire. Devo andare in
Germania, a Bonn. Ho lasciato degli affari in sospeso. Vado
a sistemarli e per Natale, te lo prometto, ritornerò. Volevo
vederti: sono tornato, ma ora devo andare. Forse domani
stesso partirò.
- Ma allora perché ti nascondi?
- Nessuno deve sapere. Nessuno. Neppure tu. E questa sera
noi non ci siamo visti.-
La signora Letizia invece avrebbe voluto sapere, avrebbe
voluto fare tante altre domande, ma si rese conto che suo
figlio era molto cresciuto in quegli otto mesi e in lui rivide il
carattere del marito, risoluto e impenetrabile. Fu debole e
quasi si lasciò spingere verso il portoncino d'ingresso
quando il figlio l'accompagnò all'uscita.
Prima che Saro potesse aprire il portoncino gli fece un'ultima
domanda: - Leo e Boncore che c'entrano?
- Non so nulla! - fu la risposta. L'abbracciò. La baciò, aprì la
porta e la signora Letizia si trovò in mezzo alla strada. Con
la testa che le scoppiava per il martellare del sangue alle
tempie tornò a casa.
Mezz'ora dopo Amalia rientrò accompagnata in auto da
amici. La madre disse di essere stanca e andò a letto. Ma non
poté dormire. Quel letto non era stato mai così scomodo. Si
girava e si rigirava. Chiudeva gli occhi per favorire il sonno,
ma non poteva e forse non voleva dormire. Due volte nella
notte fu tentata di rivestirsi e recarsi alla stazione dei
carabinieri. Avrebbe trovato qualcuno che l'avrebbe aiutata a
fermare suo figlio. Ma i carabinieri sicuramente lo avrebbero
arrestato. Lo avrebbero costretto a parlare e forse a dire ciò
che non sapevano. Varie volte evitò di rigirarsi nel letto in
piena notte, per non svegliare Amalia, che dormiva al suo
fianco, nel timore che anche lei potesse capire il suo
tormento. Amalia doveva restarne fuori, a tutti i costi. Non
doveva venire a conoscenza di nulla. Avrebbe perso la pace
anche lei.
E se invece Saro doveva realmente tornare in Germania? E
se aveva fatto quelle domande su Boncore, a cui lei
ingenuamente aveva dato tutte quelle risposte, soltanto per
curiosità? E se voleva mettere alla prova la fedeltà di Ilenia?
Tutto può succedere nella testa di un ragazzo. Forse era lei
che creava tutti quei fantasmi che non avevano motivo di
esistere.
Vagò in lungo e in largo con le supposizioni. Alle prime luci
dell'alba si addormentò.
Saro dormì fino a tardi. Quando si svegliò aveva già
deciso. Sarebbe partito quella sera stessa. Denaro liquido ne
aveva ancora molto in tasca. Prima di fuggire aveva fatto
una buona provvista, in previsione dei tempi lunghi che lo
attendevano, lontano da casa e da tutti. Con sé aveva le cose
strettamente necessarie, nel borsone a tracolla. La barba
ormai incolta gli era cresciuta e quasi aveva trasformato il
suo viso.
Quando la luce del sole non ci fu più e gli parve di non udire
più rumori per la strada aprì piano il vecchio portoncino,
diede uno sguardo cauto su tutta la strada, il solito lampione
ondeggiava al vento della sera. Uscì. Richiuse. Lasciò la
chiave al solito posto e s'avviò verso il mare. Avrebbe
camminato spedito perché la strada sarebbe stata tutta in
discesa. Non sapeva ancora come sarebbe arrivato a
Palermo. Non avrebbe chiesto certamente un passaggio a
qualcuno. In meno di mezz'ora si trovò allo svincolo che
immette sull'autostrada Palermo-Mazara del Vallo. Decise di
imboccare l'autostrada. A trecento metri trovò un'area di
sosta, la Costa Gaia. Un camion stava per partire e il
camionista, dopo averlo squadrato dalla testa ai piedi, fu ben
lieto di avere compagnia fino a Palermo.
Saro gli disse che veniva da Custonaci; che nei pressi dello
svincolo per Castellammare del Golfo si era bruciata la
guarnizione della testata della sua auto e che doveva
necessariamente arrivare a Palermo, dove abitava con i
genitori. Poi chiuse gli occhi fingendo di dormire.
A Palermo girovagò fino all'alba. Si munì del biglietto per la
nave che lo avrebbe portato a Napoli e partì.
Il treno poi lo portò a Milano.
A Milano prese alloggio in una piccola pensione ove fin dal
primo giorno notò un traffico ininterrotto di uomini e di
donne per le scale, malmesse e buie anche in pieno giorno.
La cameretta prendeva luce da una finestra alta e stretta che
dava su un cortile. Provò a guardare nel cortile, ma notò che
tutte le finestre, anguste come la sua, erano chiuse. Guardò
in alto, cercò il cielo, ma non lo vide: una nebbia grigiastra
rendeva uniforme quel rettangolo in alto posato a mo' di
coperchio sul cortile. Richiuse. Indossò un giubbotto in pelle
nera e un copricapo in lana, pure nero, e uscì. Anche fuori
notò un brulicare di individui per le strade, di tutte le razze,
vestiti ognuno nei modi più diversi, decisi, e incuranti gli uni
degli altri. Gli piacque quel modo di andare e andò anche lui,
uno tra tanti, sconosciuto tra gli sconosciuti.
Per vari giorni, conciato in quel modo, che neppure sua
madre lo avrebbe riconosciuto in pieno giorno, e con mezzi
diversi, si recò ad Arcore. Avrebbe dovuto avere pazienza e
costanza. La fortuna sarebbe venuta. Inforcato un paio di
occhiali scuri girovagava tutto il giorno. La vita qui non era
frenetica come a Milano benché l'aria che si respirava non
fosse differente. Scrutava tutti i visi che incontrava. Si
fermava dinanzi a ogni vetrina, ficcava gli occhi dentro i
negozi, talvolta vi entrava per chiedere informazioni su un
oggetto visto in vetrina. Lentamente e giorno dopo giorno
aveva percorso tutte le strade della cittadina. A distanza
talvolta leggeva i cognomi sui pulsanti dei campanelli.
Erano quindici giorni che frequentava Arcore. Alcuni visi gli
erano diventati quasi familiari e quando li incontrava era
costretto a fingersi interessato a qualcosa per non farsi
notare. Un tardo pomeriggio di sabato di metà novembre era
entrato in un supermercato. Mentre camminava stancamente
tra i vari reparti notò un viso già visto, a lui familiare.
Sì, era Marisa, una ragazza sui venticinque anni, la figlia di
Nino Boncore. Poco distante da lei un uomo, che spingeva
una carrozzella con un neonato, e un bambino di tre o
quattro anni che toccava tutti gli articoli e pretendeva che
fossero acquistati dal padre. Attorno a loro una marea di
gente che andava, veniva, si fermava, osservava, prendeva
qualcosa, la metteva nel carrello, poi ripensandoci la
riposava nello scaffale dov'era sempre stata. Anche egli
spingeva un carrello. Si finse interessato ad un articolo che
in quel momento neppure vedeva mentre dava le spalle a
Marisa e a suo marito, che passarono oltre senza notarlo, né
l'avrebbero riconosciuto, sia per come era camuffato sia
perché tra di loro non c'era mai stata confidenza. Si
conoscevano di vista, così come si conoscono tanti in una
cittadina di cinquantamila abitanti.
Si allontanò da loro ma li seguì con gli occhi per tutta la
sera. Comprò anche lui qualcosa. Pagò ad una delle tante
casse in servizio e restò a girovagare attorno al
supermercato. Quando Marisa e suo marito, tirandosi dietro
spesa e bambini, andarono via, li seguì ad una certa distanza.
Non credeva che sarebbe stato così fortunato. Il gruppo si
fermò di lì a poco. Anch'egli si fermò, interessato a delle
scarpe per donna esposte in una vetrina.
Caricarono la spesa sull'auto ferma lungo il marciapiede,
fecero accomodare il bambino più grandicello sul sedile
posteriore e si fermarono per qualche minuto a confabulare
tra loro.
Certamente, pensò Saro, ora avrebbero messo la carrozzella
nel cofano e se ne sarebbero andati chissà dove; né lui
avrebbe avuto modo di poterli seguire. Poteva però prendere
un appunto del numero di targa e lo fece scrivendoselo sulla
mano.
Marisa invece spingendo la carrozzella si allontanò
proseguendo sul marciapiede mentre il marito, entrato in
auto, mise in moto e fatte un paio di manovre se ne andò col
figlioletto più grande. Saro controllò nuovamente il numero
di targa, osservò meglio marca, tipo e colore dell'auto e si
mosse a distanza dietro Marisa. La fortuna era decisamente
dalla sua parte. Sicuramente gli stava facilitando tutto. Ora
poteva seguire la compaesana anche più da lontano.
Camminarono per circa trecento metri; poi Marisa svoltò a
destra e proseguì fino al primo incrocio. Sembrò dovesse
svoltare a sinistra; invece quando il semaforo diede la luce
verde proseguì dritta, per poi svoltare a sinistra dopo circa
cento metri, all'incrocio successivo.
Saro si affrettò tra la rada gente per non perderla di vista e
mentre anche lui svoltava l'angolo, ora a passo sostenuto, la
compaesana, spingendo la carrozzella, entrava in un andito
antico ma dal portone in legno ancora robusto. A lui sembrò
che si fosse accorta di essere seguita perché dopo essere
entrata si affacciò a guardare proprio verso di lui prima di
chiudere.
Lo stabile era un vecchio palazzo, la strada poco illuminata e
non molto larga. Saro rallentò il passo, anzi pensò se non
sarebbe stato più opportuno tornare indietro. Ma proseguì.
La Ford Focus ormai vecchia, ma lucida di vernice recente,
era posteggiata sotto il palazzo, lungo il marciapiede, tra
altre rade macchine allineate.
S'allontanò. Mangiò una pizza e rientrò a Milano. Le
macchine sfrecciavano per le strade illuminate. Nei pressi
della stazione ferroviaria entrò in un cinema e finalmente si
riposò. Quando rientrò nella cameretta della pensione era
notte inoltrata. Nella camera attigua alla sua un gran rumore
e le voci di due ragazze facevano gran baldoria.
La domenica, attorno alle dieci, Saro era ancora a letto,
bussarono alla sua porta. Ebbe un sussulto, ma poi
sforzandosi di presentarsi nel modo più naturale possibile,
andò ad aprire.
- Chiedo scusa se vi ho disturbato. Avete fiammiferi o un
accendino da prestarmi, per cortesia? Sono qui, nella camera
accanto. Mi chiamo Delia … - e tese la mano per presentarsi.
- Piacere! - le rispose Saro mentre gliela stringeva. Poi
rientrò, cercò nelle tasche del giubbotto e le consegnò una
scatola di cerini, che portava sempre con sé, benché non
fumasse, e, mentre le osservava il seno seminudo sotto la
vestaglia cascante da una spalla, aggiunse: - potete tenerli.
Mi scuso se non vi ho invitata ad entrare.
- Scusato. Grazie - rispose Delia - ve li riporterò fra poco.
E se ne andò.
Saro la seguì con gli occhi nella camera, posta di fronte a
quella in cui vi era stato il baccano la notte precedente. Poi
richiuse la porta e si sdraiò nuovamente sul letto. Rimase
con lo sguardo rivolto alla porta. Quella ragazza poteva
avere un paio d'anni più di lui. Certamente doveva aver fatto
più di qualche concessione - pensò il giovane. - Era ancora
bella, ma nel viso si leggeva una grande malinconia, se non
tristezza. Nella lunga vestaglia rosa, stretta sui fianchi, si
indovinavano tutte le forme del corpo. Non era più alta di un
metro e settanta e, benché si fosse presentata ancora
spettinata, nei suoi movimenti non si notava nulla che
potesse definirsi volgare, benché fosse evidente l’attività che
svolgeva …
Sul comodino vi era una bottiglia di acqua minerale, quasi
piena. La prese e bevve. In lontananza suonavano delle
campane o forse un disco ne riproduceva il suono. Pensò alla
chiesa del Sacro Cuore a quell'ora di domenica nel suo
paese, ai suoi amici, alle ragazze…
Bussarono nuovamente.
- Vengo - rispose; ed aprì.
- Sono io di nuovo. Le ho portato i cerini e il caffè. Lo
prendiamo insieme? Io non l'ho preso ancora. -
E mentre Saro le faceva spazio per farla passare lei gli mise
in mano un vassoio di lamiera con sopra dei tovaglioli di
carta, due tazzine, dei biscotti e alcune bustine di zucchero.
Poi chinatasi afferrò la caffettiera, che aveva posato a terra,
la portò dentro mentre con la sinistra teneva chiusa la
vestaglia sul petto.
Saro con una leggera gomitata richiuse la porta e posò il
vassoio sul tavolo, all'angolo della stanza.
- Abbiamo una sola sedia; - disse - sedete voi. Io resto in
piedi, o, meglio, mi siedo sul letto. - E mentre parlava si
trovò già seduto.
Delia, versato il caffè nelle tazzine, aggiunse lo zucchero, si
avvicinò a Saro, gliene porse una. Poi tornata presso il
tavolo prese l'altra tazzina e la sedia e si avvicinò a Saro
sedendoglisi di fronte.
- I biscotti - disse, alzandosi quasi di scatto per andare a
prenderli.
- Io non ne voglio - fece Saro.
- Io neanche - disse Delia. Nel movimento che aveva fatto
per alzarsi un lembo della vestaglia le era scivolato tra le
gambe, mentre l'altro le cadeva da un lato, lasciandone una
quasi interamente scoperta fino all’inguine. Una vampata di
fuoco investì Saro, dai piedi alla testa. La coscia era bianca,
appena velata di rosa, fin quasi al pube, dove riusciva a
penetrare l'occhio di lui. Il viso di Delia, ora che si era
nuovamente seduta, era più composto, benché i capelli
fossero ancora in parte spettinati. Anzi l'averli raggruppati
con un fermaglio sulla testa dava al viso e al collo un certo
fascino che la faceva desiderare di più.
Lei se ne accorse e Saro si rese conto che Delia s'era accorta
dell'improvviso suo mutamento. Bevvero il caffè. Poi egli
prese la tazzina dalle mani di Delia e insieme con la sua la
posò sul vassoio.
- Una sigaretta non posso offrirvela - le disse, allargando le
braccia.
- No, non fumo - rispose Delia.
- Allora siamo in due, non fumo neanche io.
Prese delicatamente per un gomito Delia e la fece sedere sul
letto, mentre lei si lasciava guidare. Prese posto al suo fianco
e le posò una mano all'interno della gamba destra, rimasta
completamente nuda. Sentì sotto la mano, e gli arrivò fino al
cervello, una sensazione che non sentiva da molto tempo. La
pelle vellutata scivolava come una piuma sotto la mano.
Sentiva le pulsazioni del sangue di lei che, con ritmo uguale,
gli attraversavano tutto il corpo, come scosse elettriche al
rallentatore.
Lei non si oppose. Anzi, abbandonata la presa sulla vestaglia
che svogliatamente teneva aderente all'addome, gli passò la
sinistra tra la barba e i folti capelli.
Con la destra Saro le prese la testa e l'attirò a sé, per baciarla.
Ma Delia schivò le sue labbra lasciandosi baciare sulle
guance e sul collo. Con le labbra egli le carezzò il lobo
dell'orecchio sinistro e mentre, spingendola dolcemente, la
riversava sul letto si rese conto che aveva i seni scoperti e
turgidi. Con entrambe le mani scostò completamente la
vestaglia e si distese su di lei. Un fuoco gli avvampava le
membra. Quel corpo, malgrado la delicatezza della pelle, era
come una colonna di granito, stretta sui fianchi. Lo coprì di
baci e di carezze in ogni sua parte. Le succhiò, prima
delicatamente poi con più energia e a ripetizione, prima l'uno
e poi l'altro capezzolo e poi di nuovo i lobi delle orecchie e
di nuovo l'uno e l'altro capezzolo, mentre lei lo carezzava
dolcemente dietro la nuca e gli premeva la testa contro il
proprio seno, contro l'addome, contro il pube, ancora coperto
da slip.
Poi lo fermò. Si distese meglio nel letto.
Egli le tolse completamente vestaglia e slip, mentre con una
mano lei gli sbottonava la giacca del pigiama e gliela
toglieva. Con un solo movimento anch'egli si tolse pantaloni
e mutande e le fu sopra, nudo completamente, come lei.
I loro corpi si fusero. Le loro anime deflagrarono
ripetutamente all'unisono come fuochi d'artificio. Poi non
percepirono più nulla.
L'indomani Saro uscì per tempo dalla pensione. Si recò
presso una ditta noleggiatrice di auto e noleggiò una Fiat
Uno. Si recò ad Arcore. Cercò la casa di Marisa e si appostò
a distanza. Quando usciva qualcuno dal portone posava sul
naso il binocolo e guardava. Rimase lì tutto quel giorno e
anche i giorni appresso senza giungere ad alcun risultato
concreto. Talvolta era uscita Marisa, sola, per poi rientrare
dopo qualche ora. La mattina alle sette usciva regolarmente
il marito, probabilmente per andare al lavoro, e rientrava alle
cinque del pomeriggio. Ma non vide uscire la persona che lui
attendeva. Cominciò a perdere l'entusiasmo del primo giorno
di attesa, se non le speranze. Il giovedì pomeriggio però,
dopo pranzo, avvenne qualcosa di nuovo. Dal portone del
condominio venne fuori un individuo in cappotto, cappello
grigio e ombrello appeso al braccio, benché in cielo non vi
fosse neppure una nuvola. Camminava quasi addossato al
muro.
Saro inforcò il binocolo e subito riconobbe chi cercava. Nino
Boncore alloggiava lì, ma usciva di rado, quasi mai. Scese
dall'auto, la chiuse e lo seguì, alla lontana. Lo vide entrare in
un bar, poi da un tabaccaio, poi presso un'edicola. Infine,
dopo un largo giro, lo vide rientrare a casa.
Ora doveva programmare le proprie mosse, Saro.
Quella sera rientrò più presto del solito alla pensione. Per le
scale incontrò Delia in compagnia di un tale che pareva suo
padre. Accennò ad un saluto, ma Delia non gli rispose. Entrò
in camera sua. Prese carta e penna e cominciò a tracciare sul
foglio strade che si incrociavano, piccoli rettangoli, dei
cerchi, degli asterischi… Alla fine, dopo alcune ore, giunse
alla conclusione che aveva bisogno di aiuto. Non aveva idea
della persona a cui potesse rivolgersi. Oltre alla macchina a
noleggio gli serviva un'altra auto. Non la pistola; né un fucile
a canne mozze. Ma un'altra auto, per un lavoro pulito. Ma
non un'auto normale, regolare. Decise che quella sera
qualche ora l'avrebbe trascorsa con Delia. Perciò, dopo le
due di notte, quando il traffico per le scale si era ormai
calmato, bussò alla porta di lei. Delia venne ad aprire.
- Noi non ci siamo mai conosciuti - gli disse subito.
- Ok; però, se permetti, anch'io sono un cliente - ribatté.
- E' tardi. Ma, per i rapporti di buon vicinato, entra.
Saro entrò. La porta si richiuse alle sue spalle. Lo squallore
regnava sovrano in quella stanza. Il letto disfatto e le
lenzuola macchiate. Sul tavolo alcuni piatti sporchi e delle
bucce di frutta già nere, una sedia su un piccolo divano dalla
pelle color tabacco, sgualcita, e in un angolo alcune
bacinelle con acqua. Un piccolo armadio con gli sportelli
cadenti e un comodino mancante di un cassetto
completavano la scena.
Saro ebbe voglia di andarsene, ma si fece forza e restò. Tolse
la sedia dal divano e sprofondò in esso. Accortosi che Delia
cominciava a spogliarsi: - lascia stare - le disse - sono venuto
per farti un po' di compagnia. Naturalmente pagherò prima
di andarmene.
Delia un po' si sentì offesa, ma non disse nulla. Poi rispose: -
l’altra domenica volevo sentirmi diversa da tutti gli altri
giorni, era il mio giorno libero e ho voluto viverlo
liberamente. E' stato per questo che, quando tu me l’hai
offerto, ho rifiutato il tuo denaro e ho provato un immenso
piacere, come da tempo non provavo. Gli altri giorni le mie
prestazioni sono lavoro, duro lavoro, nauseante, umiliante,
quasi mai gratificante. Il sabato sera rendo il conto e se non
ho prodotto abbastanza mi resta poco anche per vivere. Hai
scelto male la tua compagnia questa sera. Non sono la Delia
della domenica, quando benché stanca e distrutta, mi sento
libera, finalmente libera di disporre di me stessa per una
giornata.
- Capisco … - la interruppe Saro.
- Ho i miei dubbi, - rispose Delia - voi uomini siete tutti
uguali, ma anche le donne vi somigliano.
- E' questo il mondo … - aggiunse Saro - non lo abbiamo
creato noi e non saremo noi capaci di cambiarlo. Piuttosto
dimmi: se uno avesse bisogno di una macchina, di una
macchina particolare, diciamo così, tu mi capisci, si potrebbe
averla? Pagando, s'intende …
- Ci sono buone possibilità …
- Una risposta sicura quando potrai darmela?
- Domenica.
- A domenica, allora.
Saro si alzò, mise una mano in tasca, trasse un biglietto da
cinquanta euro e lo posò sul tavolo.
- Va bene? - chiese, rivolto a Delia.
- No, aspetta! - Delia frugò nella sua borsa, pescò un
biglietto da venti e glielo porse. Poi si avvicinò e lo baciò
sulla guancia. Poi prese un fazzoletto e gli pulì la guancia del
rossetto che vi aveva impresso.
- Buona notte! - gli disse.
- Buona notte! - rispose Saro. E se ne andò.
La domenica mattina, di buon'ora, era appena l'alba, Delia
bussò alla porta di Saro. Dovette bussare una seconda volta e
più energicamente perché questi sentisse. Non era ben
sveglio neppure quando andò ad aprire. La intravide appena
nella penombra; non le disse nulla, lasciò la porta aperta e se
ne tornò a letto.
Delia entrò, richiuse la porta alle sue spalle, si fece scivolare
di dosso la nuova vestaglia di seta e si sdraiò accanto a Saro,
sotto le coperte, stringendosi a lui. Anzi, tirandosi un po' su
fece in modo che i seni si stampassero sulla faccia di lui.
Saro continuò a tenere gli occhi chiusi, come se dormisse,
ma con la lingua cercò un capezzolo e con la bocca, tirando
a mo' di ventosa, incominciò a leccarlo e a succhiarlo.
Delia glielo porgeva come ad un neonato. Poi pian piano lo
spogliò, lo carezzò, lo baciò fin nelle parti più intime. Saro
la penetrò finalmente, nella vagina, quando fu lei ad
assumere la direzione dell'amplesso.
Egli ebbe la sensazione che da un momento all'altro dovesse
avere un arresto cardiaco. Fu solo ridotto nell'incapacità di
intendere e di volere. Poi si addormentarono entrambi.
Era quasi mezzogiorno quando si svegliarono.
- Tu che vuoi? - chiese piano Saro.
- Sono venuta a portarti i documenti dell'auto.
- Già; e dove sono?
- Sul tavolo - rispose Delia e, vedendo che Saro metteva i
piedi a terra, aggiunse: - in camera mia ho le chiavi. Costo:
tremila euro.
Saro non disse nulla. Da una tasca del borsone tirò fuori sei
biglietti da cinquecento euro e li posò sul tavolo, a fianco dei
documenti. Poi rivolto a Delia: - ci sono altre spese?
- Sì. Però vieni qui -.
Saro si avvicinò al letto e mentre Delia sollevava le coperte
scivolò al suo fianco.
- Un'altra galoppata! - gli sussurrò all'orecchio, mentre col
pube cercava il suo pene.
Senza preamboli, questa volta, Saro la cavalcò con tutte le
forze che aveva, senza carezze e nel modo più rude e
selvaggio che poté. Giacque sfinito.
Delia sembrò soddisfatta. Poi, lasciandolo solo, venne fuori
dal letto, indossò la vestaglia, intascò il denaro per l'auto e
senza parlare andò via lasciando la porta accostata. Poco
dopo tornò. Posò le chiavi sul tavolo, vicino ai documenti.
Poi aggiunse: - Troverai l'auto svoltando la prima a sinistra,
a venti metri dall'angolo, sulla destra. Guarda la targa.
Corrisponde a quella del libretto di circolazione.
Naturalmente non è regolare. Ma è difficile che anche la
polizia se ne accorga. Tu però evita la polizia. Ti saluto,
signor mio sconosciuto. Non ci rivedremo più. Buona
fortuna a te e a me. Cambio anch'io città questa sera. Ti
ricorderò per un po'. -
Saro la guardò sbalordito mentre si chiudeva la porta alle spalle.
- Buona fortuna … - poi mormorò quasi a se stesso, volendo
coinvolgere in quell'augurio anche Delia, che probabilmente
Delia non era. Non la rivide più.
Era giornata di derby, quella domenica, a Milano. Alle due
del pomeriggio le strade erano deserte. Non circolavano
auto; erano spariti i pedoni; solo un autobus, lontano,
superava un incrocio, senza fretta.
Saro svoltò l'angolo, individuò l'auto, l'aprì, diede uno
sguardo attorno, infilò la chiave nel cruscotto e partì. Quella
Croma era davvero un portento. Si spinse fino a piazza
Duomo. Poi si diresse verso Arcore. Lungo la strada trovò
un distributore automatico e fece benzina. Provò la ripresa,
la velocità, i freni, la frizione; controllò l'acqua del radiatore,
la pressione delle gomme. Quasi non guardò gli interni.
Incontrò una pattuglia di carabinieri in motocicletta, fermi
sul ciglio della strada, intenti a chiacchierare e a gesticolare
animatamente tra loro. Passò oltre senza guardarli. Ad
Arcore fece un giro per le vie cittadine molto lentamente.
Posteggiò l'auto a circa cento metri dalla casa di Marisa. La
chiuse a chiave e tornò a Milano.
Chiuso nella sua camera riprese gli appunti dei giorni
precedenti. Li esaminò. Alcuni li distrusse, altri li mise da
parte. Ora avrebbe dovuto usare molta cautela e avere molta
determinazione.
L'indomani prese a noleggio un'autovettura e si diresse
nuovamente ad Arcore. Trovò un posteggio a poca distanza
dalla Croma depositata il giorno precedente e attese tutto il
giorno.
Ripeté l'operazione anche il giorno dopo. Nulla. La sera,
rientrava. In certi momenti modificava i suoi programmi. Poi
ritornava su quelli iniziali.
Il terzo giorno fu ad Arcore prima che iniziasse il brulicare
della gente per le strade. Posteggiò l'auto presa a noleggio
nei pressi della Croma, in attesa, sicuramente inutile anche
quel giorno. Invece mentre buttava l'involucro di carta di una
caramella fuori dal finestrino notò che qualcuno era venuto
fuori dal portone d'ingresso del condominio dove abitava
Marisa. Dapprima vide il cappello e la testa che superavano
il tetto delle macchine in sosta, poi, quando l'uomo dal
marciapiedi scese per strada, vide il cappotto di Nino
Boncore che con passo lento e il sacchetto delle immondizie
in mano si dirigeva verso un cassonetto.
Inforcò gli occhiali, sistemò il berretto di lana sulla testa,
divenuto ormai un indumento abituale, e con passo affrettato
si diresse verso la Croma. Mise in moto e partì lentamente.
Boncore, liberatosi del sacchetto, proseguì ancora a passo
lento. All'incrocio avrebbe attraversato la strada se non
avesse proseguito sul marciapiede, svoltando a sinistra, caso
improbabile.
Dalla direzione che aveva preso verso il ciglio del
marciapiede era chiaro che avrebbe attraversato verso destra.
Infatti guardò a sinistra, a destra, di fronte e non scorgendo
alcun pericolo si accinse ad attraversare.
Saro accelerò. Prima che Boncore fosse sull'altro
marciapiede gli fu addosso.
Boncore si accorse tardi del sopraggiungere della Croma,
accelerò il passo, poi, perso il controllo dei propri
movimenti, fece per tornare indietro, ma restò piantato in
mezzo alla strada con le mani in alto. Cercò di evitare l'urto
mentre un urlo terribile fece eco al botto.
Boncore volò in alto, per circa dieci metri, rotolando
nell'aria. Ricadde come un fagotto avvolto nel suo cappotto
lungo il marciapiede, al di là dell'incrocio. Saro guardò nello
specchietto retrovisore. Gli parve che qualcuno si fosse
affacciato al balcone. Proseguì accelerando di più. Svoltò a
sinistra, poi a destra. Tra due auto, all'angolo della strada,
posteggiò la Croma, tolse le chiavi e se ne andò. All'angolo
svoltò a sinistra. Si tolse il berretto, gli occhiali, i guanti e
anche il giubbotto mentre affrettava il passo. Al primo
incrocio svoltò a destra. Diede uno sguardo all'orologio da
polso: erano le sette e dieci. Davanti ad un bar stava per
fermarsi, ma poi proseguì, quasi scontrandosi con due operai
che ne venivano fuori. Non li guardò e tirò dritto. Il sangue
freddo che aveva avuto fino a quel momento lo stava
abbandonando. Sentì freddo ma non indossò il giubbotto che
con la destra teneva sopra la spalla. Passando accanto ad un
cassonetto per le immondizie vi lasciò cadere gli occhiali, i
guanti, il berretto e proseguì. Camminò per circa mezz'ora;
poi senza rendersene conto si trovò sul treno che lo riportava
a Milano.
Disdisse la pensione. Raccolse le poche cose. Da un barbiere
si fece radere completamente la barba e tagliare i capelli
ormai lunghi e incolti. Si guardò allo specchio. Si fece un
sorriso. Pagò e col treno tornò ad Arcore. Recuperò la
macchina in sosta presa a noleggio, fece ritorno a Milano e,
depositatala, prima che fosse sera partì per Bonn.
Aveva sufficiente denaro per arrivare a Natale. Varcata la
frontiera aprì il giornale comprato a Milano, alla stazione
ferroviaria. Un trafiletto dava notizia della morte di quel
siciliano, nativo di Alcamo, venuto a trovare la figlia a
Milano e che un pirata della strada aveva investito con
un'auto, la mattina.
Nessuno aveva visto l'incidente. Soltanto una vecchietta
aveva riferito alla polizia che aveva visto, mentre si
allontanava, una macchina bianca. Ma non si aveva notizia
né della marca né della targa. La polizia aveva aperto le
indagini, ma probabilmente, concludeva il giornalista, quel
caso sarebbe rimasto "uno dei tanti", e col tempo sarebbe
stato archiviato.
Depose il giornale e s'addormentò.
A Bonn suo cugino Maurizio lo ragguagliò su alcune
notizie giuntegli dal paese. Saro fu poco interessato a tutte,
ma gli disse che da vari mesi era in Germania, qua e là per
varie città, e che da quando era partito non si era più sentito
con i suoi, né aveva intenzione di farsi sentire. Maurizio
disapprovò la sua condotta ma non si immischiò nelle
faccende di lui. Gli disse che volentieri lo avrebbe avuto suo
ospite per tutto il tempo che sarebbe rimasto in Germania.
- Solo una settimana resterò a Bonn, poi ho intenzione di
recarmi a Ginevra, un po' per turismo e un po' per affari. Per
Natale penso di rientrare ad Alcamo.
- La casa è tua, puoi restare quanto ti pare - continuò
Maurizio.
Quella settimana trascorse presto, in compagnia ora di
Maurizio, ora di altri compaesani, felici di averlo rivisto. Un
tale gli riferì che qualche giorno prima era stato rinvenuto il
cadavere di Leo in un pozzo, verso la Falconara, e non si era
capito se era stato omicidio o suicidio; ma tutto faceva
pensare ad un omicidio: mancava però il movente.
- Altro che America … - aveva commentato chi riferiva.
Saro non fece domande, ma se ne mostrò dispiaciuto.
Poi era partito e a Ginevra, fatta amicizia con due calabresi,
andò un paio di volte a sciare. Passò il tempo totalmente in
vacanza, in modo quasi spensierato. La domenica mattina
antecedente il Natale telefonò a sua madre. Rispose Amalia
che non ne aveva riconosciuta la voce.
- Finalmente! - lo rimproverò la sorella - pensavamo ti fossi
dimenticato di noi. La mamma la stai portando alla tomba.
Sei un ingrato. Ci hai lasciate sole, in balia dei quattro venti.
E sei un gran farabutto nei confronti di quella ragazza … Io
al suo posto ti avrei già mandato a quel paese …-
Saro la lasciò gridare e sfogare. Poi con calma le disse: - dì
alla mamma di preparare cose buone per Natale e di invitare
Ilenia e la sua famiglia. Saremo insieme, tutti.
- Tu non dici davvero… - fece incredula Amalia. Poi riprese:
- ma la mamma, la conosci, non vorrà certamente. Dopo la
morte di papà … e poi la cosa neppure a me pare ben fatta
… e i genitori di Ilenia cosa diranno?
- Tu dille che ho telefonato io e che ti ho detto questo. Poi
come vorrà fare farà. Fra qualche giorno mi farò risentire.
- Non dovrebbe tardare. Al cimitero è andata. Appena ritorna
glielo dirò. Tu, come stai? - Avrebbe voluto fare altre
domande, ma non le fece.
- Bene. Molto bene. Diglielo alla mamma e anche a Ilenia.
- Non preoccuparti. Glielo dirò.
Poi si era chiusa la conversazione. L'indomani Saro comprò
un anello d'oro con uno zaffiro per Ilenia, un braccialetto,
pure in oro, per Amalia e un Crocifisso in madreperla per
sua madre. Un tagliacarte in argento con l'impugnatura in
madreperla fu il regalo di Natale per Lucio. Il martedì ripartì,
in treno. Il mercoledì sera giunse a Palermo. Telefonò a
Lucio, che stava cenando. Sua madre glielo passò al
telefono.
- Sono alla stazione centrale, sotto i portici, di fronte alla via
Roma. Ti aspetto.
- Ok, sto arrivando.
Lucio non finì di cenare, malgrado le insistenze di sua
madre, e volò. Si abbracciarono senza parlare, senza fare
domande, come una volta. Poi chiese: - dove?
- A casa mia, da mia madre.
Montarono in auto e in meno di un'ora furono ad Alcamo.
Prima di rientrare Saro volle fare il giro per le vie del paese.
Alle dieci di sera poca gente ormai circolava per le strade.
Rivide con piacere visi a lui noti, benché dai nomi
sconosciuti. Riconobbe le auto di molte persone a lui pure
ben note.
Benché la temperatura fosse rigida aprì il finestrino e respirò
a pieni polmoni, come se fosse la prima volta che respirasse,
dopo un lungo periodo in apnea.
Quando la notizia si diffuse in paese pochi capirono.
Poi, un discorso tira l’altro, qualcuno cominciò a fare delle
supposizioni. Quelle supposizioni cominciarono a divenire
ipotesi e tesi. Poi certezze. Quelle tesi e quelle certezze col
tempo diventarono verità. Ma verità che si basavano su
supposizioni. Tuttavia si ebbe l’impressione che tutti
avessero capito. Le persone che lo conoscevano
cominciarono a salutarlo con deferenza. Coloro che non lo
conoscevano lo cercarono con le scuse più banali. Tutti lo
stimavano.
Dapprima Saro non volle dare peso alle manifestazioni di
deferenza nei suoi confronti, anzi si sforzò di non volersi
rendere conto di nulla. Tutti lo salutavano ed egli
rispondeva cordialmente. Volle attribuire tutto ciò al fatto
che era mancato per molti mesi da Alcamo. Però doveva
necessariamente constatare che era eccessiva la deferenza
nei suoi confronti. Si meravigliava maggiormente quando il
saluto glielo rivolgevano persone fino ad allora a lui
sconosciute. Persone che egli aveva sempre ritenuto superbe
perché socialmente altolocate o economicamente potenti,
persone di cui aveva sentito sempre parlare con rispetto e
ritenute molto influenti, pure se non particolarmente
appariscenti.
Qualcuno gli parlò di suo padre. Della persona rispettabile
che era stato. Che quella disgrazia con la macchina proprio
non ci voleva. Ma che egli, Saro Capizzi, non sarebbe stato
meno degno di lui o meno rispettato, perché, egli certamente
se ne rendeva conto, la gente capisce e sa apprezzare le
qualità di un uomo, pure quando nessuno gliele stampa sui
certificati di nascita e di residenza.
Saro cominciò a darsi qualche spiegazione a discorsi del
genere, e riusciva a darsene anche sua madre quando le
venivano riferiti da conoscenti. Saro si teneva muto. Quei
discorsi voleva far capire che non lo interessavano affatto.
Ma poi dovette ammettere a se stesso e convincersi che
molti avevano capito. Dapprima si sentì orgoglioso. Poi ebbe
paura.
- Ma paura di che? - si disse qualche mese dopo il suo
rientro, una mattina, mentre con gli occhi chiusi faceva finta
di dormire, disteso nel letto. E si alzò.
La signora Letizia aveva gioito enormemente
quell’antivigilia di Natale vedendosi balzare tra le braccia il
figlio, di ritorno dalla Germania. Giorno dopo giorno la sua
gioia era aumentata e sembrava non dovesse avere limiti.
Saro era rispettato e riverito più di quanto lei stessa avesse
potuto desiderare. Ma col tempo anche lei cominciò ad aver
paura della immensa riverenza che veniva attribuita al figlio.
Poi anche in lei nacquero dei sospetti. Col tempo i sospetti
divennero certezze. Con la riverenza e la rispettabilità che
venivano riconosciute a suo figlio le certezze divennero
verità. Suo figlio sicuramente era ritenuto un assassino. Era
una verità che nessuno pronunciava. La povera donna lo
leggeva sui visi della gente quando si soffermava a salutarla
o a farle un complimento su quei due figli, davvero due figli
d’oro colato, specialmente il maschio.
La donna si stringeva nelle spalle e ringraziava, ma dentro
avvertiva un tremore indicibile, che la faceva soffrire per
tutto il giorno, fino alla sera, quando il sonno finalmente
chiudeva le porte ai pensieri più disparati, che tuttavia
talvolta trovavano il modo di intrufolarsi anche nei sogni per
poi dileguarsi nel nulla, così come erano venuti.
Ma col passare dei mesi la vita aveva ripreso a trascorrere
tranquilla, senza problemi. Ed anche la signora Letizia aveva
deciso che doveva tranquillizzarsi; e si tranquillizzò. E si
tenne muta anche lei.
Saro si era dedicato alla conduzione dei campi, quasi
abbandonati nel periodo che egli era stato lontano. Ora erano
tutta un’altra cosa: un giardino erano. Approfittando di
alcune leggi emanate dalla regione e dallo stato aveva
espiantato alcune centinaia di alberi per immetterne altri di
altro genere o di altra specie. Aveva distrutto immense
piantagioni di vigneto, condotte in modo antiquato, per fare
dei reimpianti con varietà maggiormente richieste dal
mercato, con sistemi meno costosi per la conduzione e più
redditizi nella produzione. Insomma la stima che gli veniva
attribuita se l’era guadagnata.
D’accordo con la madre e con la sorella aveva venduto
alcune case, compresa la vecchia casa di Gammara,
dissequestrata su suo interessamento, che servivano solo a
far pagare inutili ed esose tasse. Aveva venduto dei terreni
che quando le annate risultavano buone era già tanto se non
ci si rimetteva di tasca.
Invece aveva comprato altri terreni che limitavano con quelli
di sua proprietà a Siringano. Con gli anni la contrada
sembrava fosse divenuta tutta di proprietà dei Capizzi. In
primavera inoltrata, guardando dall’alto di una delle due
collinette che delimitavano la tenuta, si aveva l’impressione
di una grande scacchiera, divisa a rettangoli ampi e a
quadrati immensi e perfetti, verdi, neri, marrone o rossastri,
cangianti in colori tenui o marcati, a seconda del periodo
della lavorazione e della varietà delle piantagioni.
Pietraie che non avevano mai dato frutto, neppure erba per le
capre, ora davano uve profumatissime e vini di ottima
qualità, con altissima gradazione. Erano le uve meglio
pagate della zona, tutte destinate a raggiungere, sotto forma
di mosto, il Piemonte, dove i vini venivano tagliati con altri
vini meridionali, più pubblicizzati e più richiesti dal mercato.
Quattro anni ormai erano trascorsi da quando Saro Capizzi
aveva fatto ritorno dalla Germania. Amalia si era diplomata
e avrebbe voluto insegnare ai bambini delle scuole
elementari, ma, da quando si era diplomata lei, concorsi non
ne erano stati più banditi, perché, si era fatto sapere in tutti i
modi, c’era esubero di insegnanti, esubero di diplomati,
esubero di laureati: però i governi programmavano e
incentivavano la prosecuzione degli studi fino almeno al
conseguimento del diploma per tutti. Si volevano operai
diplomati, finché ce n’era bisogno.
Si era invece laureato in Giurisprudenza Lucio. In breve
aveva conseguito l’abilitazione all’esercizio della
professione di avvocato e quindi ora era l’avvocato Lucio
Monelli, con studio a Palermo, in un vecchio stabile della
via Roma, non lontano da quella casa presa in affitto,
durante gli studi universitari, nella via Giovanni Da Procida.
Aveva preso moglie. Ma non aveva avuto molta fantasia.
Aveva fatto la corte ad Amalia, la sorella di Saro. Amalia
non si era fatta pregare troppo. Aveva acconsentito presto.
Da un anno circa si erano sposati. Lucio si era introdotto
discretamente nell’ambiente di lavoro. Gli erano state
affidate le pratiche legali di due importanti Istituti Bancari e
tutto faceva pensare che il futuro sarebbe stato promettente e
generoso. Amalia aveva rinunciato quasi definitivamente
all’insegnamento e dava una mano, che col tempo si andava
rendendo indispensabile, al marito sia nello studio che
presso i vari uffici pubblici. Anzi era più conosciuta lei che
il marito, negli uffici del Tribunale, del Comune, della
Provincia e della Regione. Molto spesso quando Lucio
voleva farsi strada nei vari uffici ed aveva premura doveva
farsi accompagnare dalla moglie, che conosceva le entrate e
le uscite, diceva lei.
Saro diceva che lo spirito dei Capizzi finalmente si era
risvegliato in lei. Lucio invece sosteneva, a quattr’occhi con
Amalia, che era stato lui a mettere in moto quel macchinario
sornione che era stata sempre sua moglie, mentre lei
affermava che era il suo spirito di iniziativa che la faceva
agire, spirito che prima di allora nessuno aveva saputo e
voluto prendere in considerazione.
Saro continuava a promettere a Ilenia che si sarebbero
sposati: tempo libero permettendo. Pur nondimeno
convivevano e programmavano che presto avrebbero avuto
un bambino.
Ma una mattina quando fuori era buio e in cielo ancora
brillavano le stelle si sentì bussare alla porta d’ingresso…….
Finalmente varcò la soglia di quella maledetta porta. Stette
un attimo a guardare dinanzi a sé. Un attimo più intenso di
un secolo.
Il mare a venti passi libero e sconfinato, trapunto di
minuscole onde che brillavano al sole vespertino, chiazzato
qua e là da immense ombre e frizzante di spume vicine e
lontane.
Dodici anni e dieci giorni l’avevano invecchiato. Quel mare
l’aveva ascoltato senza poterlo vedere. Finalmente era suo.
Avrebbe potuto tuffarsi, riempirsi la bocca di acqua acre e
salata e spruzzarla lontano.
Aveva deciso.
Cominciò a correre disseminando qua e là i pochi panni che
aveva indosso. L’acqua era tiepida e lo circondò da tutte le
parti. Dodici anni e dieci giorni se li sentiva scivolare di
dosso; se ne andavano, non li aveva mai vissuti. La paura e il
tormento di non sopravvivere glieli avevano triplicati, con la
speranza costante che qualcosa potesse avvenire per porre
fine a quella angoscia. Ed ora eccolo qui, libero di nuotare a
grandi bracciate, proprio come quando era adolescente,
sospeso nell’acqua, libero di andare giù, fin sulla sabbia
sott’acqua a raccogliere una conchiglia e risalire in
superficie, come un ragazzino. Miriadi di pesciolini
attraversavano la sua strada ed era ben contento di
gareggiare con loro, che spaventati, fuggivano a stormi.
Osservava con piacere il lento ritmato andare delle meduse,
che tanta paura gli incutevano quando era bambino.
Risalì ancora una volta in superficie per respirare. Solo
allora si accorse che un buon tratto di mare lo separava dalla
riva e volle tornare. Ma dovette nuotare con calma e solo con
le braccia. Un dolore gli aveva avvinghiato i muscoli di una
coscia, un dolore causato da crampi, come li chiamava
Ilenia.
Già. Ilenia. Chissà dov’era a quell’ora. Ora lavorava, gli
aveva scritto circa due anni addietro. Non aveva mai capito
con precisione che lavoro facesse, ma lavorava perché in
casa veniva a mancare anche il pane, gli aveva scritto. Sul
treno che lo riportava in città furono questi i pensieri che lo
tennero occupato per la durata di tutto il viaggio.
Eppure, pensava, di soldi ne aveva accumulati un bel po’. Le
centinaia di assegni a vuoto, che aveva appena finito di
pagare con la reclusione, avevano fruttato centinaia di
migliaia di euro che non potevano essersene andati in dodici
anni.
Pochi anni, gli sembrarono. Per chi è in galera sono tanti.
Eppure ora gli sembravano pochi. Facciamo un po’ i conti! -
si disse. - Dovevano essere quasi quattrocentomila euro
quelli che erano stati messi al sicuro …
Poi andò con il ricordo a sua madre, morta dopo due anni dal
suo arresto. Un groppo in gola gli fece quasi mancare il
respiro. Forse la colpa di quella morte era stata anche sua. In
quegli anni di detenzione tutti i beni se li era portati il vento,
gli aveva scritto una volta sua madre. Si era salvata soltanto
la casa in cui abitava. Era assorto in questi pensieri quando il
treno s’arrestò, quasi bruscamente. Una giovane donna, già
pronta per scendere, gli cadde addosso. Arrossendo si scusò.
Saro restò un attimo con lo sguardo fisso nei suoi occhi,
estraniato. Non si era neppure accorto che lo circondavano
una ventina di persone.
- E’ Alcamo? - chiese, sforzandosi di sorridere.
- Sì, scendiamo già - gli risposero alcune voci, infastidite, al
di sopra della sua testa.
Quando scese alla stazione era già buio da un pezzo, ma
ancora un gran via vai si avvertiva al di là di un muretto e di
tanto in tanto il rombo delle auto. La sua cittadina era
tranquilla. Si guardò attorno cercando qualche volto
conosciuto, ma tutti gli sembrarono stranieri, venuti chissà
da dove.
Non c’era nessuno ad aspettarlo. Aveva voluto giungere di
sorpresa, dopo la grazia che gli era stata concessa per la
buona condotta avuta in prigione. Chissà quanta festa gli
avrebbero fatta parenti ed amici. Eppure aveva ben visto
scritto, a caratteri alti un metro, “ALCAMO”, sul cartello,
alla stazione. Tornò a leggere da un’altra parte: “Alcamo”.
Era lui lo straniero. Non riconosceva nessuno e nessuno lo
riconosceva. Anche il paese, a ben guardarlo, sembrava un
altro. Camminando verso casa guardava in lontananza
palazzi che ricordava di non aver mai visti. I grattacieli si
perdevano lassù, tra le stelle.
In dodici anni quante cose erano cambiate! Solo i nomi delle
strade che conducevano a casa sua, quella che aveva fatto
costruire a nome di Ilenia, prima del suo arresto, erano
rimasti quelli di quando era ragazzino lui. Nessuno s’era
presa la responsabilità di mettere da parte quei nomi illustri,
oppure a nessuno gliene fregava niente. Aveva già superata
la via Foscolo. La prossima, la via Leopardi, sarebbe stata
quella di casa sua.
A dire il vero, non si aspettava grandi accoglienze da parte di
Ilenia, la sua compagna. In dodici anni le vicissitudini di
altri detenuti avevano smorzato molto del suo entusiasmo
sulla bontà e sulla fedeltà degli amici e del prossimo in
generale, ma sperava di trovarla in casa. Al citofono non
rispose alcuno. Tornò a fare squillare il campanello. Ma non
era uno squillo. Un carillon diffondeva per le stanze un
brano di Rossini per alcuni secondi. Un occhio, al di sopra
del citofono, lo guardava nell’oscurità. Si sentì stanco.
Seduto su un gradino davanti al cancello della villetta si
addormentò.
Una voce lo svegliò di soprassalto. Capì che lo
scacciavano. Lentamente si sollevò e nell’oscurità fissò bene
chi lo scacciava. Un uomo e una donna erano davanti a lui,
stretti uno all’altra.
- Lucio - gridò - Ilenia!
- Fratello mio; tu, senza avvisare… saremmo venuti a
prenderti … - diceva, abbracciandolo, il vecchio amico con
cui si erano trattati come fratelli in passato.
Ilenia posò la guancia sulla sua spalla e pianse, senza dire
parola. Lucio, aperto il cancello, li precedette in tutte le
stanze. Aveva mille cose da dirgli, mille cose da mostrargli,
mille cose rinnovate e tutte belle e di qualità, che egli stesso
aveva provveduto a comprare, alcune con i risparmi messi a
disposizione da Ilenia nell’arco degli anni e alcune erano
state regali suoi alla padrona di casa.
Dopo alcuni preamboli andò via.
Ilenia gli chiese se aveva cenato. Saro rispose che aveva
mangiato qualcosa in treno e che non aveva fame.
Ilenia, che in passato era stata più che una compagna per lui,
anche se ancora non l’aveva sposata, accusava stanchezza e
pesantezza alla testa: andò subito a letto.
Saro si infilò sotto la doccia. Poi cercò nell’armadio un paio
di pantaloni, una camicia, un giubbotto in pelle non più di
moda e, col cuore più nero della notte, ritornò fuori, al di là
del cancello, sulla strada, dove lo avevano trovato
addormentato.
Si diresse verso il centro del paese.
Non vide e non fu visto da nessuno. Non fece più ritorno.
Non si seppe mai più nulla di lui. |


 ELIANA
ELIANA