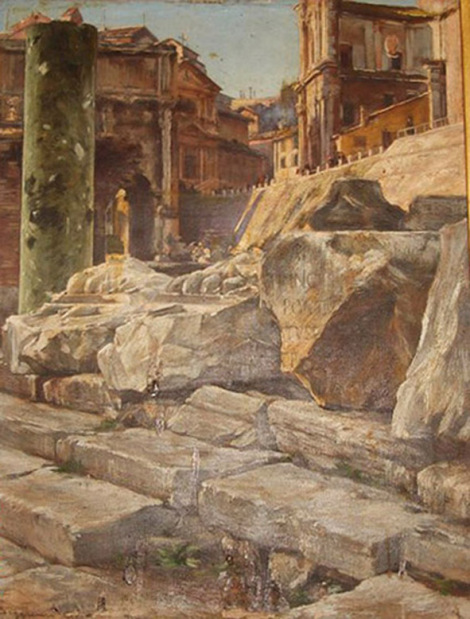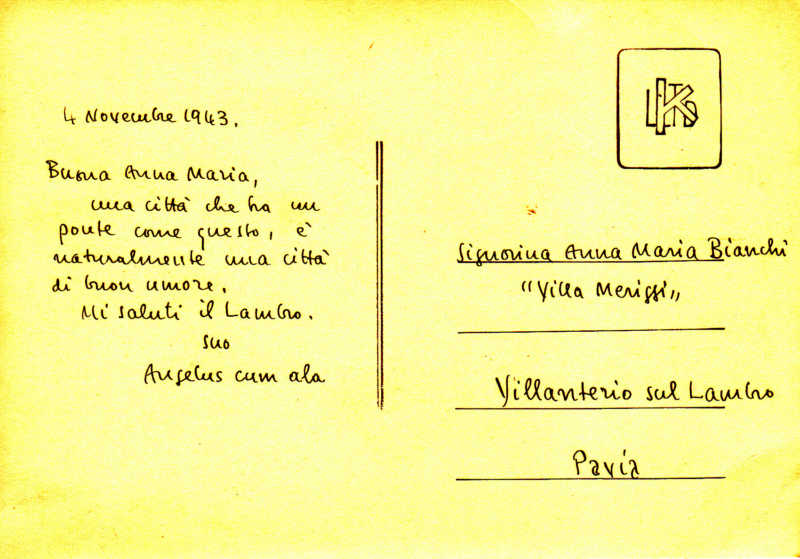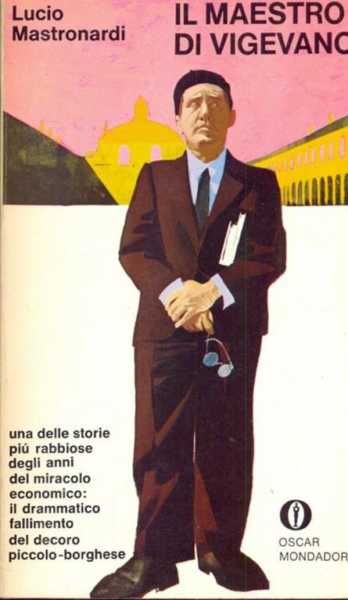|
Letteratura classica e moderna. Ritratti di donne poco conosciuti I primi versi di un poeta italiano che spasima per una donna sono quelli di Ciullo d’Alcamo in questo curioso botta e risposta tra lo spasimante e la desiata: «Rosa fresca e profumatissima che sbocci all'inizio dell'estate, le donne nubili e maritate ti desiderano: liberami da questa passione, se ne hai la volontà; a causa tua non ho pace notte e giorno, pensando solo a voi, mia signora». «Se soffri a causa mia, è la follia che ti spinge a farlo. Potresti arare il mare, seminare ai venti, mettere insieme tutte le ricchezze di questo mondo: non puoi avermi a nessun costo e piuttosto mi taglio i capelli [mi faccio monaca]». «Se ti tagli i capelli [se diventi monaca] preferirei morire, poiché con essi perderei ogni gioia e felicità. Quando passo di qui e ti vedo, rosa fresca del giardino, mi dai piacere in ogni momento: facciamo in modo che il nostro amore si unisca». «Che il nostro amore si unisca non voglio che mi piaccia: se ti trova qui mio padre con gli altri miei parenti, sta' attento che questi forti corridori non ti raggiungano. Come sei stato rapido a venire qui, ti consiglio di esserlo altrettanto ad andartene». Gli stilnovisti e la loro donna angelo riprenderanno più tardi il tema degli amorosi sensi verso l’amata, qui di Guido Cavalcanti questi versi,
“passa la gran beltate e la piagenza Di Guido Guinizelli ora abbandonandoli e volgiamo l’attenzione per il momento a versi poetici che conosciamo quasi tutti a memoria e che riguardano, amante amata: Dante e Beatrice, Petrarca e Laura, Catullo e Lesbia, Foscolo e l’amica risanata e la contessa Pallavicini , Leopardi e Silvia e Nerina , la dannunziana Ermione “dalla favola bella” Eleonora Duse o Alessandra di Rudinì?, Didima la nera bellezza “ E se è nera che importa? ” che fa spasimare Asclepiade (“Con i suoi scherzi Didima mi ha preso. Ahimé, mirando la sua bellezza, mi struggo come cera al fuoco. Se è nera, che importa? Anche i carboni sono neri. Ma, se li accendi, splendono come boccioli di rosa” , ritratti di donne in bella mostra nella pinacoteca delle immortali della letteratura. Compito di questa breve nota è di arricchire un poco, stante la mole del materiale che i vari poti ci offrono, questa stanza museale riportando alla luce solo alcuni di questi quadri meno conosciuti traendoli dagli scaffali di librerie e di biblioteche. Dal mondo greco ecco spuntare il ritratto della Eliodora
di Meleagro “La mia anima mi dice di
fuggire l’amore di Eliodora,
perché sa per aspetti sentimentale e di amorosi sensi da accostare
alla Lesbia catulliana “Odi
et amo. Quare id faciam, fortasse
requiris. Nescio, sed fieri sentio et excrucior.”
Odio e amo. Forse mi chiedi come Al quadro di Beatrice, donna angelica, ecco, spigolando nella letteratura del novecento, il suo accostamento a quello della sconosciuta amata del Carducci, o forse quella Maria già cantata nell’Idillio maremmano..tu sorridi ancora Improvvisa al mio cuore, o Maria bionda;E il cuor che t'obliò, dopo tant'ora Di tumulti oziosi in te riposa, O amor mio primo, o d'amor dolce aurora.”?) ”Cosa di cielo è la mia donna allora Che il roseo collo
piega e il vago riso A i baci porge e quei d’ambrosia irrora. Oh, che d’ogni
mortal cura diviso, Sopra quel sen, tra quegli amplessi io mora! Né v’invidio, o
beati, il paradiso.” Le due figure di Guido Gozzano, La Signorina Felicita
“Nel mio cuore amico
Signorina Felicita, è il tuo giorno! e la “cattiva signorina” Cocotte” “ Vieni. Che importa se
non sei più quella
Alle due donne foscoliane depositarie della divina ed eterna bellezza ci riporta Vincenzo Monti con l’ode dedicata alla figlia Costanza, “Per un dipinto dell’Agricola” “Piú la contemplo, piú vaneggio in quella Mirabil tela: e il cor, che ne sospira, Si nell’obbietto del suo amor delira, Che gli amplessi n’aspetta e la favella, Ond’io già corro ad abbracciarla. Ed ella Labbro non move, ma lo sguardo gira Ver’me si lieto che mi dice: Or mira, Diletto genitor, quanto son bella. Figlia, io rispondo, d’un gentil sereno Ridon tue forme; e questa imago è diva Si che ogni tela al paragon vien meno. Ma un’imago di te vegg’io piú viva.”
La Delia di Tibullo è tutto ritrosia e dispetto e con questo ritratto chiudiamo la nostra breve ricerca iconografica. “Che mi giova, Delia, la tua Iside ora? che mi giovano quei bronzi che tante volte la tua mano ha agitato o quel tuo purificarti nell'acqua, seguendo piamente il rito, quel tuo dormire da sola, ricordo, in un letto illibato? “ “Se invece io potessi, mia Delia, con te aggiogare i buoi e pascere le greggi sul monte che sai, e mi fosse consentito tenerti con amore fra le braccia, dolce sarebbe il mio sonno anche sulla nuda terra. Che vale distendersi su un letto di porpora senza un amore ricambiato, quando viene la notte e una veglia di pianto? Nemmeno piume o coperte a ricami, nemmeno il mormorio d'un placido ruscello potrebbero indurti a dormire.”
Una storia in parte vissuta:
la fuga del pilota del caccia americano caduto nella seconda guerra
mondiale nelle campagne di Motta Visconti
Alcune
curiosità riguardanti le Vie Medievali dei Pellegrini
Veronica e Agostino Veronica da Binasco
Giovannina ( Nina)
Negri o Negroni nasce nel
……………………………………………………………………………………………….. Mario Capodicasa curatore di una edizione delle Confessioni così ci presenta nella prefazione la figura di Agostino “ La sua grandezza, come teologo, filosofo, mistico, scrittore, psicologo, è data dalla sintesi armoniosa e splendente delle sue doti,.... se rifletti bene e lo segui nelle sue speculazioni e nella sua dialettica ravvisi Aristotele, Atanasio; se ti invade il fiume della sua eloquenza ravvisi Cicerone, Crisostomo; se ti commuove la genuina parola del cuore che è sempre alta poesia ravvisi Pindaro, Virgilio; se riesci a penetrare nel suo cuore lo vedrai simile a quello di Paolo, generoso come quello di Pietro” . Veronica da Binasco, al contrario, una delle tante figlie spirituali del Santo di Tagaste è una povera ed ignorante contadina: quali dunque i punti di contatto, quale il possibile raffronto tra questi due Santi tanto dissimili per origine, cultura e periodi storici?
Il cammino di fede parte per entrambi da Milano: la Milano romana di
Ambrogio per il primo, la Milano ducale di Lodovico il Moro per la
seconda; protagonista di spicco Agostino, difensore della fede
cristiana a Cartagine,
Generato a nuova vita e abbandonate le giovanili dissolutezze, dopo l’incontro in Milano con Ambrogio ed aver ricevuto il battesimo, Agostino il novello presbitero e poi vescovo di Ippona, ritornato in patria, all’epoca del nascente culto cristiano, organizza nel 411 d.C. il primo dei concili di Cartagine. Oggi, nell’odierna Tunisia, uno dei luoghi che lo videro indiscusso protagonista, le Terme di Gargilius, sono ridotte a pochi ruderi e si nota solo qualche sbrecciata colonna a rompere l’ondeggiare di selve di gialli ranuncoli e di solitari papaveri di color scarlatto. Così doveva essere questo luogo, lontano e a lei sconosciuto, secoli dopo anche ai tempi di Giovannina ma non dissimile, quale immagine, dall’odorante e fiorita campagna di Cicognola dove la fanciulla rendeva con il suo lavoro mena faticosa la vita dei genitori ed attendeva nel silenzio di realizzare il suo sogno: una chiamata misteriosa farsi monaca! Così nell’immaginario della mente ora, chiudendo gli occhi, confondendo i luoghi, il passato con il presente e il presente con il passato, e come se vedessimo Agostino passar lieve su quel campo e prendere per mano Nina. Per lei ignorante ma dalla fede genuina accanto alle parole di Cristo “ Ti benedico o Padre Signore del cielo e della terra, perché hai tenuto nascoste queste cose ai sapienti e agli intelligenti e le hai rivelate ai piccoli” non valevano forse per lei, ferma nella fede cattolica, le parole di Agostino per il manicheo Fausto ? : “ E’ vero che, benché ignorante, poteva benissimo possedere la verità in materia religiosa, …………….” Monito anche per noi portati a giudicare il prossimo ed a valutarne i comportamenti in termini di fede e religiosità.
Se poi, non volessimo cedere all’immaginazione e riaprendo gli occhi
cancellassimo questa intima visione e
lasciare, nostro malgrado, quel campo fiorito, ecco come
Così gli occhi e la mente scorrono lentamente su queste pagine: “ Nell’anno 1487 dal parto della Vergine Maria, mentre Veronica si dedicava all’orazione notturna, le apparve il Beato Agostino per tre volte…Agostino era ricoperto di un manto di seta e di una veste di porpora. Si vedeva l’aspetto tipico di un essere divino. Sul capo portava una fulgentissima mitra. Dapprima Veronica si spaventò di quella luce immensa, quindi esultò per le gioie celesti.” (Libro secondo-Capitolo secondo: L’apparizione di sant’Agostino). E poi continuando nella lettura :”Durante la festa particolare di S. Agostino, tralasciando con lo spirito i sensi terrestri, vide queste cose: il nostro santo padre Agostino in abito pontificio e con sotto una veste di color rosso avanzava tra i santi Nicola da Tolentino e Guglielmo…Con una mitra che splendeva d’oro e di pietre preziose..reggeva in mano una nicchia d’oro di meravigliosa fattura. La mente umana non comprende quanto fosse la bellezza, incredibile lo splendore” ( Libro quinto- Capitolo undicesimo: La manifestazione della festività di S. Agostino). Detto di questi incontri creati dalla immaginazione e vissuti nell’estasi, ora con riferimento alla cronaca e alla storia sappiamo per certo che da Milano punto di partenza , come già detto, della conversione di Agostino, Nina si avvia alla vita religiosa e spirituale, iniziando proprio da un Convento agostiniano quello di S. Marta, la sua missione di conversa questuante e poi di missionaria per le vie di Milano, Como, Firenze, Roma. Nella provincia romana del Nord Africa,allora il colto e dotto Vescovo Agostino, formatosi nelle scuole di retorica di Cartagine e di Roma, riduceva al silenzio e disputava con successo grazie anche alla sua arte oratoria ( Aurelius Augustinus poi Doctor Gratiae) le tesi ed argomentazioni di manichei, donatisti ed altri scismatici oppositori della fede cattolica, così Veronica nel nome di Cristo e della verità parlerà ai ricchi ed ai potenti del suo tempo siano essi i Duchi di Milano, Lodovico il Moro e Beatrice d’Este nonché lo stesso Vicario del suo amato Cristo: Papa Borgia, richiamando ora in Milano a più onesti comportamenti la poco morigerata corte ducale e poi a Roma sede dei Papi, lei, l’analfabeta contadina di Cicognola, con umili e tremanti parole, ma per Divina Provvidenza toccanti e persuasive, indicherà la strada della conversione al poco raccomandabile in termini di virtù e costumi Papa Borgia-Alessandro VI. Artefici entrambi della luccicante e sempre rinnovata, giorno per giorno da nuovi mattoni e da nuovi castoni, casa del Padre, cercheremmo invano di differenziare il loro contributo a questa edificazione: tra gli operai e gli artefici del Regno di Dio non esiste distinzione tra orafi e badilanti! Allora in Africa, il demonio sotto le sembianze di scellerati e debosciati giovani cartaginesi induceva il giovane Agostino ai piaceri della carne nei lupanari della città e lo conduceva alle frivolezze dei giardini delle Terme di Antonino, ora, sconvolto dalla angelica purezza di Veronica, il diavolo le si presenta, nel buio di una piccola cella, nel suo più reale e bestiale aspetto e ne lacera, ne percuote, ne trafigge le povere e misere carni.
Nonostante queste diaboliche torture e tentazioni, sia per Agostino
che per Veronica le porte degli inferi non hanno prevalso; nel sorgere
a vita nuova del primo scorgi il segno della misericordia divina nei
confronti del singolo peccatore, nella sofferenza corporale di
Veronica, intimamente connessa con il sacrificio della Croce, vi trovi
il tributo individuale alla redenzione e alla remissione dei peccati
dell’umanità. Quando pecchi e ti smarrisci Agostino ti dice che puoi
risorgere, Veronica ti aiuta a risorgere!
“Dall’Alpe a Sicilia, recitano due versi dell’Inno di Mameli e di fatto, se si scorre lentamente l’elenco di coloro che seguirono Garibaldi nella gloriosa spedizione dei Mille, ricorrono spesso quali nomi dei loro paesi di origine o di provenienza quelli di piccoli o sconosciuti borghi. Ad esempio oltre a quello della città di Pavia significativo risulta l’elenco dei comuni della sua Provincia quali: Albuzzano, Belgioioso, Bereguardo, Copiano, Corteolona, Landriano, Marcignago,Vidigulfo. Spostandosi poi dalla Certosa di Pavia verso Milano notiamo che la vicina Vernate ha offerto i natali a Giuseppe Sisti il garibaldino della sua frazione di Pasturago ma particolare attenzione merita, in questo ricordo, una visita presso il Cimitero di Binasco dove nella parte vecchia si offrono alla pietas del visitatore antiche tombe e tra di esse una, alquanto semplice e scolorita dal tempo ma sempre adorna di fiori, che sulla lapide riporta la seguente iscrizione: Marcello Candia/Chimico-Farmacista/1837-1894/Una Prece; la moglie Teodolinda Beretta Candia (1848-1877) gli riposa accanto assieme ad altri familiari. Nome, quello di Marcello Candia, che ricorre spesso nella “Storia di Binasco” di Damiano Muoni allorché, con riferimento alle guerre risorgimentali si legge :” In questi ultimi anni di rivolgimenti e di lotte per conseguire la patria redenzione non furono pochi gli abitanti di Binasco e del suo territorio che per eroici fatti si mostrarono all’altezza dei tempi”…” Lunga è la lista di coloro che parimenti si distinsero nella campagna del biennio 1859 e 1860:Citeremo soltanto quelli che ricorrono alla nostra memoria…; il Candia, il Marcello e i due fratelli Melotti di Lacchiarella..” Marcello Candia:l’antico speziale binaschino, il combattente per l’unità d’Italia, altro non è che il nonno di un altro Marcello Candia “ Il Marcello dei Lebbrosi” così chiamato da Padre Piero Gheddo che nel libro a lui dedicato così descrive le origini di questa famiglia :”La famiglia Candia veniva da Lacchiarella, nella bassa milanese: Speziali da almeno tre secoli, i Candia nell’ottocento avevano una farmacia a binasco, grosso borgo agricolo non lontano da Lacchiarella” oltre a riportare anche ulteriori testimonianza sulla figura dello speziale binaschino attraverso le parole di Riccardo Candia, un fratello di Marcello:” in casa si conserva un bel ricordo di famiglia: uno schizzo di Domenico Induno che riproduce il nonno Marcello, suo compagno d’armi, nella divisa di Cacciatore delle Alpi, il corpo garibaldino a cui si era unito come volontario durante la seconda guerra di indipendenza ( 1859) quando era ancora studente all’Università di Pavia-un bel giovanotto-era nato nel 1837, morirà nel 1894-dallo sguardo fiero e dai baffi elettrici. Il disegno a carboncino, vivo e di rara perfezione stilistica, è tracciato sul foglio di via per viaggiare, con trasporto gratuito da Brescia a Milano, e fu pagato da quel lontano Marcello all’Induno con un fiasco di vino.”
Bibliografia 1) Area megalitica di Saint-Martin-de-Corléans - museo e ... - Valle d'Aosta.Internet 2) I megaliti di Aosta, sito megalitico di Saint Martin de Corléans, Internet... 3) Area megalitica di Saint-Martin-de-Corléans - Wikipedia-Internet 4) Raffaella Poggiali Keller,Philppe Curdy, Angela Maria Ferroni, Lucia Sarti:”Area megalitica di Saint-Martin-de-Corléans- Parco archeologico e Museo”-2016- Regione Autonoma Valle d’Aosta-Assessorato Istruzione e cultura
«Andrò in Oriente per cinque o sei settimane: agli scavi di Delfo e di Micene, alle rovine di Troia. Queste visitazioni votive sono richieste dai miei studi attuali. Mi sono rituffato nell’Ellenismo»: è con tali parole che, il 10 luglio 1895, Gabriele D’Annunzio annunciava al suo editore Treves le motivazioni che lo indurranno a intraprendere il viaggio verso la Grecia. In realtà l’intento dannunziano non era quello di esplorare luoghi a lui stranieri, ma di osservare con i propri occhi ciò che aveva precedentemente letto nelle opere greche classiche. Il viaggio gli permise infatti di rivisitare i luoghi descritti da Omero e dagli autori greci, precedentemente conosciuti tramite i loro scritti. Prevista tra il 18 o 19 luglio da Brindisi, la partenza, a causa delle pessime condizioni meteorologiche, fu anticipata al 13 luglio: l’imbarco a bordo dello yacht Fantasia1 di proprietà di Edoardo Scarfoglio avvenne dal porto di Gallipoli. Oltre a Scarfoglio, compagni di viaggio furono Guido Boggiani , Georges Hérelle e Pasquale Masciantonio. Al ritorno da questo viaggio inizierà la stesura di Maia, dedicata a Giosuè Carducci, un lungo poema autobiografico, in ventuno canti, intitolato Laus vitae che risulta il primo libro de Le Laudi del Cielo, del Mare, della Terra e degli Eroi in cui sono le raccolte poetiche della maturità di D’Annunzio. Ma chi erano questi amici? Il più noto di questi amici è certamente Edoardo Scarfoglio, scrittore e giornalista di chiara fama: noto ai più qui solo ricordiamo che fu marito di Matilde Serao da cui si separò per una sua relazione extraconiugale: curioso poi il fatto che questo viaggio nel Pireo inizia proprio dopo tale separazione e che per ironia della sorte lo yacht prende il nome dal primo romanzo della Serao. Georges Hérelle è stato un letterato francese, professore di filosofia, autore per i tempi di un saggio all’avanguardia e che destò scalpore sulla omosessualità, traduttore delle opere, in particolare, di Grazia Deledda, Matilde Serao e dello stesso D’Annunzio, oltre che etnografo e grande appassionato di viaggi. Pasquale Masciantonio avvocato dopo che ebbe modo di conoscere in quel di Napoli il corregionale Gabriele d'Annunzio a lui rimarrà sempre legato da un sentimento di profonda amicizia. Merita di ricordare che a soli ventisei anni, fu eletto sindaco di Casoli e si dimise dalla carica nel 1899 per partecipare alle elezioni per la Camera dei deputati, candidandosi nel collegio uninominale di Gessopalena: qui vinse al ballottaggio del 22 luglio e risultò essere il più giovane degli eletti della legislatura. Fu confermato nelle elezioni del 1904, del 1909, del 1913, del 1919 e del 1921.
Guido Boggiani. di cui qui si vuole ricordare la figura, era nato con
l’Unità d’Italia il 20 settembre
Ritornando a quel viaggio, giunti in Grecia l’1 agosto, D’Annunzio e i suoi amici, l’Ulisside, come il poeta si definì e come definirà due dei suo compagni di avventura, scrive: «Siamo finalmente nel mare classico. Grandi fantasmi omerici si levano da ogni parte».
“E
COME l’esule torna L’itinerario scelto da D’Annunzio prevedeva l’imbarco a Brindisi e poi Corfù, Patrasso, Corinto, Delfi, Egina, Nauplia (per visitare le la cittadella fortificata di Micene e le mura ciclopiche a Tirinto), Salonicco, Costantinopoli, le rovine di Troia. Da lì la Fantasia avrebbe dovuto toccare la costa turca fino a Rodi e proseguire verso l’Egitto, la Tripolitania, Malta, la Sicilia e Napoli. Il tragitto fu radicalmente modificato a causa delle variazioni metereologiche e come ricorda Ornella Rella nel suo commento a questo viaggio, fatto tappa dopo il diverso peregrinare nautico, presso le grotte del Parnaso, i quattro viaggiatori soggiornarono ad Atene fino al 16 agosto. Nonostante l’intento di visitare Costantinopoli, furono costretti a modificare i loro progetti a causa delle cattive condizioni meteorologiche; Masciantonio e D’Annunzio, stanchi del tanto viaggiare e dei disagi ad esso connessi, abbandonarono il gruppo non prima, tuttavia, di aver lasciato la Grecia, il 21 agosto i due amici approdarono al porto di Brindisi e giunsero in Italia. Il resto del gruppo ritornò in patria il 24 settembre. Durante la crociera Hérelle e Boggiani scoprirono di avere molte affinità e, forse, un’attrazione velatamente omosessuale. Sia D’Annunzio, che Hérelle e Boggiani tennero un diario del viaggio. Quello di Boggiani, ora custodito nella biblioteca della Yale University, era anche corredato da mappe disegni. Ne esiste un’altra copia trascritta per Hérelle, ma priva di disegni, che si trova nella Médiathèque de l’Agglomeration Troyenne. I turisti si fermarono una settimana ad Atene: le giornate erano dense di visite a musei e monumenti, le serate erano alla ricerca di donne di facili costumi a cui Boggiani ed Hérelle non partecipavano.
Dalle pagine del diario di Hérelle si percepisce una certa idiosincrasia per il narcisismo del Vate, che non perdeva occasione per nuotare e prendere il sole nudo: e la veste di lino erami grave, mi scinsi… Il traduttore annotava: c’è in molti italiani un’assenza totale di pudore che mi sorprende sempre. Lunghe docce di Scarfoglio, di D’Annunzio, di Masciantonio; interminabili lavaggi con il sapone; semi-nudità durante pomeriggi interi, sul ponte. Boggiani, che è del nord, ha tutt’altro carattere: non si stupisce di niente, ma si burla di questo lasciarsi andare e dice ridendo: “Sono dei bambini maleducati!”. Herelle e Boggiani i due Ulissidi Così scriveva poco tempo fa Vincenzo Amato sulla Stampa al riguardo di Boggiani:”Fino a pochi anni fa c’era una scuola a lui intitolata. Adesso a Omegna a ricordare Guido Boggiani resta solo una strada. Dimenticato in patria il grande esploratore, etnografo, pittore e fotografo è celebrato in Sud America e la città di Asunciòn, capitale del Paraguay, gli dedica periodicamente diverse mostre.” Pertanto affinché la sua figura non cada nell’oblio questo il mio ricordo, questi i miei poveri versi concatenati con quelli aulici dedicatigli in Maia dal Vate amico: Ultimo Ulisside Guido che dalle dolci acque del Cusio dove di San Giulio quell’eremo, lì son vergini pie al silenzio votate lor sol muta è concessa a Dio la preghiera, si specchia al centro solitario, e da quelle ceruele acque del Verbano dall’isole che il Santo patrono milanese noma punteggiate a te lidi del patrio focolare un dì lontan lasciati, forte il desiderio la brama tua, ultimo Ulisside, di solcar mari nuove acque per lo spirito bere alla mente portare nuove ampie conoscenze e all’animo di goder di luoghi nuovi e di bellezze nuove ai più ignote sconosciute e ti sorrise così l’Egeo mar isole dove si rincorron i Miti antichi, dove la man tua con abil tocco su tela mise di qualle greca civiltà le rovine antiche, la man che a Olimpia più volte toccò di Prassitele il marmoreo Hermes e gli occhi chiari tuoi di pianto si bagnaron e da ultimo poi l’Oceano oltre le colonne d’Ercole e ben lontan solcato il piede tuo, nuov’acqua sconosciuta, toccò quel fiume quel Rio Paranà e alla vision che gli occhi infiamma la Bolivia selvaggia del Chaco gli Indios dalla bella nudità selvaggia nuove piante insetti nuovi uccelli dal piumaggio strano e la giungla del Paraguay selvaggia ultima meta del tuo umano viaggio che qui volle crudel destin fosse da man violenta la tua luce spenta. No, no ancor tu Ultimo Ulisside vivi: questo per te in Maia il canto dell’amico Vate:
“Ed uno di noi, che
taceva
e nervose di
corritore
con gli occhi
chiarissimi il solco.
della fronte nata a
cozzare Or ascolta da lontano questa voce Guido: “Son qua, Ulissìde.„
“Su, svegliati! È l’ora. ………………………………..
Fonti e riferimenti 1) Gabriele D'Annunzio Laudi del cielo, del mare, della terra e degli eroi, Libro Primo - Maia, Milano, Fratelli Treves Editori,1908. Fonte: Internet Archive 2) G. D'Annunzio, Versi d'amore e di gloria, II, a cura di A. Andreoli e N. Lorenzini, Milano, Mondadori, 1984. 3) I taccuini del viaggio di D'annunzio costituiscono la nuova edizione digitale, curata e commentata da Ornella Rella- da Internet 4) Dal Verbano al Chaco. L'avventurosa vita di Guido Boggiani, ... 5) Maia- Poesia-Wikipedia-da Internet 6) Georges Hérelle — Wikipédia da Internet 7) L'esploratore di Omegna dimenticato nel Cusio e “venerato” in .Paraguay-da Internet
"Chi sono i Copti?" LACCHIARELLA – Andando a zonzo sulle rive del Ticinello, dopo Binasco seguendo l’ultimo tratto di questo figlio del Ticino, giunti nei pressi di Lacchiarella , più propriamente nella frazione di Mettone ecco stagliarsi, tra il verde della campagna, uno svettante monastero..il monastero dei monaci Copti. “Chi sono i Copti”?: un sito Internet riporta quanto segue : “Copti sono i discendenti diretti degli antichi Egizi dei tempi dei faraoni. Sono stati anche definiti “i figli moderni dei faraoni”.
La parola “copto” significa in realtà semplicemente “egiziano” e deriva dalla parola greca “Aigyptos”, che a sua volta derivava dall’antico vocabolo egizio “Hak—ka—ptah” (la dimora dello spirito del dio Ptah), uno dei nomi della prima capitale dell’antico Egitto, Menfi. Dall’epoca della conquista araba (641 d.C.), i musulmani hanno usato la parola “guipte” (copto) per designare gli Egiziani, che a quell’epoca erano tutti cristiani. A poco a poco si è verificata un’identificazione del termine “copti” con l’essere “cristiani”. Il vocabolo “copto” sottintende anche la lingua, l’arte e la civiltà dell’Egitto tra la fine dell’epoca tolemaica e l’arabizzazione del Paese, cioè dal 30 a.C. Circa fino al Medioevo.” Quando i Copti accolsero la fede cristiana, la loro brama del mondo venturo aumentò, ma su una base evangelica. Piuttosto di occuparsi del ritorno dell’anima al corpo mummificato, il loro forte desiderio divenne quello di innalzare il cuore e lo spirito e il pensiero divenne quello di godersi la vita celeste anche camminando nella carne sulla terra. Così questo desiderio ha preparato la via alle pratiche ascetiche ispirate al Vangelo nacque così e si diffuse in Medio Oriente il loro monachesimo. Oggi una delle caratteristiche della Chiesa Copta Ortodossa è il continuo aumento del numero di coloro che desiderano aderire alle comunità monastiche, tanto che si tende a ravvivare gli antichi monasteri disabitati. Anche monasteri abbandonati da secoli e in rovina sono stati riadattati e ospitano ora nuovamente dei monaci. Monasteri copti sono stati fondati anche all’estero, presso le principali comunità della diaspora. Uno di essi, il Monastero di Anba Shenuda, si trova a Mettone di Lacchiarella, alle porte di Milano. Inizialmente il luogo era una fattoria e rimase abbandonata per più di 50 anni. Fu così messa in vendita dal proprietario e nel 1989 acquistata dal Santo Patriarca il Papa Anba Shenouda III. Fino agli inizi degli anni ’90 era curato dai preti di quel periodo, ma nel ’96 fu il Vescovo Anba Kirellos ad occuparsene, avviando così la ricostruzione del Monastero. Il terreno venne pulito e curato, costruite le celle per i monaci. Quindi questi monaci Copti sono i discendenti di chi vide le acqua del Nilo e di chi si bagnò nelle sue acque. Piace pertanto da questi aspetti storici e geografici poter affermare con entusiasmo: dalle acque del maestoso Nilo a quelle più lente e modeste del Ticinello che qui scorre poco lontano da Mettone in quel di Casirate Olona. Da Ticino Notizie
Il Ticino, fiume generoso.. Ma non per tutti!
Privilegi di concessioni, autorizzazioni, diplomi elargiti dai tempi antichi fino ad oggi hanno e favoriscono solo alcuni a dispetto della maggior parte. Per quanto riguarda, ad esempio, lo sfruttamento delle sabbie aurifere, “ la pesca dell’oro”, dopo l’epoca romana allora prerogativa di Roma che si serviva dell’impiego di schiavi, era nel tempo gestito direttamente dalle Autorità dominanti e/o dato in concessione ad enti o operative locali.
Così da un interessante libro “I tesori sotterranei d’Italia-Le Alpi” di Guglielmo Jervis: “In tutto il fiume Ticino, dal Lago Maggiore al Po e relativa lanche, valli e martizze, esiste il diritto della pesca dei pesci e della sabbia a pagliuzze d’oro e d’argento ( oro argentifero) , e ciò per concessione del 1654 di Filippo IV re di Spagna, a favore del marchese Giovanni Pozzobonelli, diritto che già per sentenza del 1635 era dichiarato a favore della R. Camera. Al Pozzobonelli, per eredità e vendita, sono successi alla casa Clerici, i marchesi Arconati Visconti e Busca, il comune di Galliate ed il papa Urbano Crivelli, fondatore della soppressa abbazia di Santa Maria della Pace, in Magenta, ora dei nobili consorzi Crivelli.La competenza Clerici, consistente nella maggior parte di tutto il fiume, venne rivenduta ad enfiteusi perpetua a diversi, che ancora attualmente esercitano economicamente la pesca, e si estende dal Lago Maggiore al territorio di Galliate e Robecchetto con Induno, indi dopo Besate fino al Po”. Ancora oggi sono ben visibili in alcune campagne dei comuni rivieraschi del fiume o al limitare di alcuni boschi del Ticino stesso cartelli con scritte “riserva di caccia e pesca”. “ In particolare il Parco del Ticino possiede tre Diritti Esclusivi di Pesca. Questi riguardano aree particolarmente interessanti ed idonee alla sopravvivenza delle specie ittiche che riproduce. · Diritto Esclusivo di Pesca di Turbigo; · Diritto Esclusivo di Pesca di Magenta; · Diritto Esclusivo di Pesca di Vigevano. In quanto per la loro localizzazione geografica e la loro estensione questi diritti esclusivi rivestono un ruolo strategico nella gestione e nella conservazione dell’ittiofauna autoctona del Fiume Ticino. All’interno dei loro confini si ritrovano infatti tratti di Ticino e ambienti acquatici laterali al fiume di elevatissimo pregio naturalistico e conservazionistico, come il Ramo Delizia, il Ramo dei Prati, il Canale Nasino ed anche il Ramo Morto, il quale da anni è uno dei corsi d’acqua laterali del Ticino più ricchi di biodiversità, in particolare di specie ittiche pregiate.I diritti esclusivi di pesca vengono gestiti attraverso uno specifico Piano di Gestione, che prevede ripopolamenti di specie autoctone in declino.La pesca sportiva all’interno dei diritti esclusivi del Parco non è vietata, ma per poterla praticare bisogna essere in possesso, oltre che della regolare licenza, del libretto segnacatture (annuale o giornaliero) del Parco.”
I poveri diavoli un tempo meno oggi, volendo godere o fruire di questi “ben di Dio”, a loro rischio e pericolo, allora talvolta con l’impiccagione oggi con multe salatissime, eran o sono costretti costretti alla pesca di frodo o al bracconaggio. Con questo non si intende certamente perorare la causa dei frodatori e dei bracconieri in quanto il riferimento vale in particolare per i tempi passati dove nella campagne vivevano povertà e miseria, e spesso si era costretti per la cupidigia e la poca carità dei potenti ad essere trasgressivi! Come non ricordare quanto nel 1938 la poetessa Antonia Pozzi, nipote per linea materna, del conte Antonio Cavagna Sangiuliani di Gualdana e di Maria Gramignola, proprietari di una vasta tenuta terriera, detta La Zelata, a, Bereguardo, annotava sul suo Diario poco prima della morte? : “Ieri, sull’argine del Ticino, dove il fiume fa un’enorme ansa e la corrente si attorce in gorghi azzurrissimi, e ha subbugli, scrosci, rigurgiti improvvisi e minacciosi, sono rimasta per un’ora sulla riva in faccia al sole che tramontava, a chiacchierare con un guardiacaccia che fu al servizio del mio nonno e si ricorda della mia mamma e delle mie zie bambine. Ebbene: era un senso strano pensare che tutta questa smisurata terra, i campi coltivati da Motta a Bereguardo, e i boschi della riva, dal lido di Motta fin giù al ponte di barche, con i diritti di pesca, di caccia, di cava d’oro persino, erano proprietà unica dei miei antenati. Io non so che cosa pagherei per potermi costruire qui, in vista del Ticino, due stanze rustiche e venirci a stare; le mie radici aristocratiche non le sento molto, nemmeno qui, ma le mie radici terriere sì, in modo acuto e profondo, e gli uomini dietro l’aratro mi incantano, non solo per un senso di armonia estetica”. Da Ticino Notizie
Il Castello di Binasco le acque del Ticino Scampoli di Geografia e di Storia, anche qui Il Ticino muove le sue acque: il Ticinello! Come si può leggere da Wikipedia, il Ticinello era un canale difensivo costruito nel 1152 da Castelletto di Abbiategrasso a Landriano da Guglielmo da Guintellino a difesa di Milano dalle incursioni dei Pavesi alleati di Federico Barbarossa. Dove questo canale prendesse acqua non è certo, ma è possibile che lo facesse direttamente dal Ticino e, in questo caso, in una data anteriore a quella il 1179 o il 1177 storicamente indicata come l’inizio dei lavori a Tornavento di Lonate Pozzolo per il futuro Naviglio Grande.
Congiunto il Ticino con Abbiategrasso, il Ticinello era un canale irriguo, che proseguiva fino a Casorate Olona da dove continuava fino a confluire nel fiume Lambro Meridionale nei pressi di Landriano. Il canale Ticinello è tuttora esistente, esso deriva le sue acque, come detto, dal Naviglio Grande presso il nodo idrico di Castelletto di Abbiategrasso, dove comincia anche il naviglio di Bereguardo. In seguito lambisce Morimondo, Bubbiano, Rosate e Vernate dopodiché attraversa il centro di Binasco dove biforcandosi dà origine al Navigliaccio e sottopassa il Naviglio Pavese. Successivamente bagna Lacchiarella e tra le frazioni di Mettone e di Casorate Olona (che si trovano poco oltre il centro abitato principale di Lacchiarella), riceve le acque del cavo Rainoldi e poco oltre si unisce alla Roggia Carona. Oggi come un tempo, lo scopo del Ticinello è quello di irrigare i campi: infatti, durante il suo corso il canale alimenta numerose rogge.
E’ parso pertanto interessante dare uno sguardo anche a questi paesi dove seppure a fatica il Ticino muove le sue acque. Ed ecco Binasco, “culla” del romanzo storico italiano. La nascita del romanzo storico italiano si fa generalmente risalire al 1827, anno della pubblicazione dei «Promessi sposi». Nell’ambito della storia della letteratura italiana c’è posto anche per la scrittrice torinese Diodata Saluzzo Roero e per Binasco ed il suo castello. Infatti, nel 1819 viene data alle stampe ad opera di questa autrice la novella «Il castello di Binasco» dal netto intreccio e sapore di romanzo storico e che anticipa, anche se di ben diverso spessore letterario, la pubblicazione dei Promessi Sposi e che peraltro ebbe il plauso dello stesso Manzoni che con Diodata esercitò un amichevole scambio epistolare. La novella racconta la triste sorte di Beatrice Balbo Lascaris-Tenda, detta Beatrice di Tenda che sposò in prime nozze il condottiero Facino Cane e dopo essere rimasta vedova nel 1412 si risposò con Filippo Maria Visconti duca di Milano di molti anni più anni giovane di lei, come descritto da Pietro Verri nella sua Storia di Milano.
«Così il duca, da Beatrice Tenda, ottenne la ricuperata sovranità di Milano, Pavia, Lodi, Como, Vigevano, Alessandria, Tortona e Novara. A lei doveva tutto, persino l’esistenza, che gli sarebbe sicuramente stata levata, se non aveva il di lei soccorso. Essa con tutto ciò soffrì il trattamento di essere (malgrado l’età sua e la sua virtù) dal marito incolpata d’avergli violata la fede per un giovine cavaliere, nominato Michele Orombello, che era al di lei servizio… Volle il duca che venisse imprigionata in Binasco l’infelice Beatrice Tenda; e il non meno disgraziato cavaliere fu parimenti posto nei ferri. Furono condannati l’una e l’altro a perdere la testa sotto la scure; il che si eseguì in Binasco nell’infausta notte susseguente al giorno 13 di settembre dell’anno 1418. Ci dice il Biglia che il giovine Orombello, lusingato di potere sfuggire il supplicio calunniando la duchessa, preferisse la vita alla virtù, sebbene in fine perdesse e l’una e l’altra; e che la duchessa, avanti il patibolo, da donna forte e virtuosa, rimproverasse la vile colpa all’Orombello…». Damiamo Muoni, primo estensore di una Storia di Binasco, fece apporre il 13 giugno 1869 una lapide marmorea all’ingresso del castello binaschino, luogo e teatro di tanta crudeltà: «Con turpe sconoscenza ricambiando la illibata fede l’assecurato trono Filippo Maria Visconti spegneva nella notte del 13 settembre 1418 in queste mura l’onoranda consorte Beatrice di Tenda l’orrore del fatto fecondi e ritempri ne’ figli d’Italia gli affetti più puri i doveri più sacri auspice il municipio alcuni oblatori posero». Questa, come curiosità, la prima pagina e l’incipit di questo lavoro letterario ripreso da Il Raccoglitore ossia Archivj a cura di Davide Bertolotti( Magiera Dott. Enrico)-Milano, 1818 della Tipografia e Calcografia Batelli e Fanfany : “Il Castello di Binasco.Novella (inedita) di cui li principali avvenimenti ed i personaggi sono tratti della storia del 1360. ( Della contessa Diodata Saluzzo)
“
Diverse lingue, orribili favelle, Dante , Inferno, canto 3. “Diradavano i primi raggi del sole nascente il cielo molle e rosato della feconda Lombardia, e cadevano perdendosi fra le ombre di una nera profonda selva di frassini antichi. Fra quelle piante scendeva la scabra via, dove or lentamente veniva il Sire di Ventimiglia Orombello sovra un generoso corsiero. Tornando egli da Terra Santa bellicoso pellegrino, portava dipinto sulla sua fronte un amore occulto a tutti i viventi, fonte di melanconici entusiasmi e di arditissime imprese.Non raro in quella nobile età era quell’amore, che nasceva in animo egregio dal plauso dei forti, o della fama dell’altrui virtù. Ben sapeva Orombello che non lontano dalla immaginosa pittorica spiaggia erano le mura di Binasco signoreggiata dalla contessa di Tenda, e l’invitto cuore, che mai tra pugne non palpitò, palpitavagli fra quelle aure, per lui di una soverchia vita ripiene, perché Beatrice circondavano.” Il fatto storico di riferimento avvenne non già nel 1360 ma negli anni 1412-1418. Da Ticino Notizie
Le colonie elioterapiche lungo il Ticino Una volta c’erano le colonie! “Le colonie elioterapiche di un tempo sul Ticino: distruzione, ruderi..ma fortunatamente non solo!” Sì una volta c’erano le colonie! Tempi andati, tempi passati oggi presenti nella memoria di oggi ha più settant’anni come me. Le colonie nascono come ospizi marini alla fine dell’800 per ospitare bimbi affetti da malattie tubercolari: il mare e il sole avevano funzione curativa sui piccoli tanto da essere definiti ‘antitubercolari’. La funzione terapeutica prosegue anche negli anni trenta, in pieno regime fascista, quando a quella sanitaria si aggiunge la funzione educativa e di propaganda e le colonie montane, lacustri, elioterapiche e marine, che ospitavano “balilla” e “piccole italiane” e furono il fiore all’occhiello della politica igienista del fascismo. Nelle colonie il tempo trascorreva fra adunate, esercitazioni, giochi, bagni di sole. L’opportunità di frequentare le colonie, offerta anche a molti ragazzi figli di italiani residenti all’estero, fu un’efficace operazione di propaganda presso le comunità dell’emigrazione italiana. Nel dopoguerra, eliminata la funzione propagandistica, le colonie ebbero una nuova vita dagli anni cinquanta quando si optò per la funzione sanitaria e ricreativa ma anche quale aiuto psicologico e morale per ragazze e ragazzi colpiti dagli effetti del conflitto bellico. La costruzione delle colonie fu inarrestabile. Senza pretese architettoniche come quelle realizzate nel trentennio, le colonie assomigliano più ad alberghi ‘alla buona’ ma verso la fine degli anni settanta si assisterà alla dismissione e abbandono delle strutture che avevano ospitato fino a quel periodo centinaia di migliaia di piccoli provenienti da tutto il paese e la maggior parte viene inesorabilmente lasciata andare alle intemperie delle stagioni e al degrado. A questo degrado è invece sfuggita oltre alla Colonia Enrichetta di Abbiategrasso la colonia elioterapica sul Ticino di Turbigo come riporta il sito di Ticino Notizie e alla cui nota si rimanda per maggiori notizie e a G.LEONI, L’Amministrazione comunale durante il ventennio fascista, in ‘Contrade Nostre’, vol VI, pagina 25 qui riprendendo in nuce solo alcune annotazioni storiche:
” Quest’anno la gestione di ‘Progetto Vita’ della ‘Colonia’ comunale di Turbigo ha avuto un grande successo (130 iscritti), probabilmente per la capacità animare il periodo con tanti momenti di svago (visita Expo compresa), tanta piscina, partecipazione al ‘Turbigusto’. Una storia quasi secolare, quella della Colonia Elioterapica che l’attuale Amministrazione intende rivalutare affidando la gestione a privati in grado di valorizzare il sito, pur mantenendo in essere la tradizione, che vede i giovani turbighesi passare un mesetto estivo sulla riva destra del Ticino. Ecco, brevemente, la storia di questo servizio che quest’anno è entrato in auge:“Dalla prima circolare del 2 maggio 1931, in cui si invitava il popolo fascista a muoversi nella realizzazione di colonie per bambini, il Fascio locale si fece subito carico del problema. Affittò un terreno di dieci pertiche milanesi adiacente al fiume Ticino, di proprietà del Comune di Galliate e, iniziati i lavori il 6 giugno 1931, mediante le prestazioni di volontari, il 5 luglio la Colonia venne inaugurata e furono accolti subito 58 bambini. La rapidità nella costruzione e le appropriate sistemazioni degli impianti costituiti da un fabbricato centrale adibito a refettorio, di una cucina, di doccia con serbatoio, pompa per l’acqua potabile, di latrine, tutto cintato con rete metallica fanno della colonia denominata Benito Mussolini una delle migliori della plaga. In proseguo i bambini sono continuamente aumentati e così nell’anno successivo si ampliò il fabbricato mediante il concorso di Luigi Gualdoni che volle ricordare con la propria donazione il nome del proprio figlio Giannino tragicamente scomparso …” Come in altre località dell’attuale “Parco del Ticino” (Abbiategrasso, Samarate, Trecate, e della già citata Turbigo) a Motta Visconti sorgeva sulla riva del fiume, nell’attuale località “Guado della Signora”, una “colonia elioterapica”, i cui edifici sono stati completamente travolti dalle piene o forse, per meglio dire, a mio parere da locali talebani.
Infatti da qui corrono i ricordi alla mia fanciullezza e a quei poveri bianchi ruderi ancora presenti negli anni cinquanta sulle sponde del Ticino a Motta Visconti e dopo pochi anni rasi completamente al suolo e a quella ancora presente seppure asfaltata e modificata strada, come riporta il sito del Comune di Motta Visconti a “LA STRÄÄV AD LA COLONIA: Era un sentiero che scendeva dalla costa, nei boschi ed era percorsa dai boscaioli, dai sassaioli e dai pescatori: Fu ampliato e vi fu fatta una strada negli anni ’30 anche perché era stata costruita da poco la “Colonia Elioterapica Emilio Gorla” a cui andavano in estate moltissimi bambini a fare la cura del sole e ad abituarsi a vivere insieme. E così in modo malinconico riporta al riguardo un altro sito mottese che su internet recita: ” La bellezza perduta della Colonia Elioterapica “Emilio Gorla” composta dal grande padiglione con dormitorio e mensa, un elegante ristorante (negli anni a venire trasformato in discoteca) e il solarium accanto al fiume. La colonia venne inaugurata il 24 giugno 1932, benedetta dal prevosto di Casorate Primo, don Defendente Tettamanzi. Il sentiero che dal paese portava alla riva del fiume venne ampliato a strada. Il grande sito dedicato “alla cura del sole” (ce n’erano altri simili in provincia di Milano a Cuggiono, Legnano, Cerro Maggiore, Parabiago) era composto da un grande padiglione con dormitorio, cucina e mensa (totalmente scomparso, ubicato pressappoco sull’attuale piazzale al Guado della Signora), un elegante ristorante, sorta di piccolo gioiello con echi di stile” Un discorso a parte merita la “Colonia Enrichetta” oggi diventata il “Centro Permanente di Educazione Ambientale”, fornito anche di posti letto). Così recita un sito che si occupa del Territorio abbiatense:”La vallata di Abbiategrasso che conduce al Ticino si apre in numerosi percorsi ciclopedonali: tutti attraversano le ampie aree agricole per poi immergersi nel fitto dei boschi di querce e carpini. Vicino al fiume la vegetazione si diversifica, alternando bellissimi salici e pioppi. Proprio in questa zona sorge Colonia Enrichetta, su un terreno di 10.000 metri quadri recintati all’interno di un bosco, a circa 300 metri dalle sponde del Ticino (in corrispondenza della radura della Gabbana, tradizionale approdo – ora ormai in crisi – della navigazione leggera e del canottaggio). “La storia della Colonia Enrichetta parte all’inizio del XX secolo, quando nel lontano 1919 il Comitato Abbiatense della “Lega Nazionale Contro la Tubercolosi” pensa di far costruire un centro elioterapico. L’intento è quello di curare i bambini abbiatensi attraverso i cosiddetti “bagni di aria e di sole”, rimedio ritenuto curativo e preventivo nei confronti di una malattia che mieteva numerose vittime. Il nome stesso della Colonia è scelto in memoria della giovane Enrichetta Chierichetti Pianzola, morta di tubercolosi nel 1914, all’età di diciannove anni. Per volere del dott. Alessandro Casazza vengono utilizzate alcune tende dismesse dagli ospedali da campo della Grande Guerra. Per allestire il centro elioterapico viene individuato un terreno boschivo di proprietà del Conte Antonio Trivulzio Manzoni, nei pressi del Ticino. Poi il fascismo dilaga ovunque, e negli anni ’20-’30 Colonia Enrichetta si trasforma in Fondazione fascista. Di fronte alla crescente richiesta di prestazioni, si impone l’ampliamento della struttura, di cui è incaricata la Cooperativa d’Arte Edile: l’intervento fa sorgere diversi edifici, molti dei quali presenti ancora oggi.” Bello sarebbe se i depositari e i cultori di memorie storiche locali potessero fornire notizie e documentazioni sulle altre colonie elioterapiche dei Comuni rivieraschi del Ticino. Da Ticino Notizie
Una mansio (punto di sosta) lungo la via Francisca del Lucomagno (La casa del frate) In tempi recenti, anche sulla scorta del sempre più crescente e diffuso interesse per i cammini storico-religiosi, si è avviata la riattualizzazione della Via Francisca del Lucomagno, su proposta dell’Association Internazionale Via Francigena (AIVF) e dell’Associazione Amici Badia di Ganna, come riportato di recente anche da Ticino Notizie. Com’è noto, la Via Francisca del Lucomagno con l’itinerario di Sigerico o Via Francigena era una delle due vie principali percorse dai Pellegrini nel Medioevo che si snodavano in parte attraverso il territorio italiano.
L’itinerario di Sigerico o Via Francigena rimanda ad una relazione di viaggio tra le più antiche che risale al 990 ad opera di Sigerico, arcivescovo di Canterbury, di ritorno da Roma dopo aver ricevuto il Pallio, ovvero la nomina, dalle mani del Papa. In tale documentazione l’arcivescovo descrive le 79 tappe del suo itinerario che si sviluppa su di un percorso di 1.600 chilometri che parte da Canterbury arriva a Dover per attraversare la Manica; da Calais, passando per Reims, Besançon e Losanna si arriva alle Alpi che vengono passate al colle del Gran San Bernardo. Dalla Valle d’Aosta si scende a Ivrea, quindi Vercelli, Pavia e si attraversano gli Appennini tra le province di Piacenza e Parma passando per Segalara, Fornovo di Taro e poi Berceto. Da Pontremoli si prosegue per Lucca, Porcari, Altopascio, Galleno, Ponte a Cappiano, Fucecchio, San Gimignano, Colle di Val d’Elsa, Siena, Viterbo per terminare a Roma. I punti di sosta ( mansiones) con la relativa numerazione progressiva in Lombardia risultano quattro: uno nella Provincia di Lodi e tre tre in quella di Pavia: XXXIX Sce Andrea, oggi Corte Sant’Andrea frazione del comune di Senna Lodigiana, XL Sce Cristine, oggi Santa Cristina, XLI Pamphica, come detto oggi Pavia , XLII Tremel, oggi Tromello: 79 tappe, circa 20 km per tappa, tra Senna Lodigiana e Santa Cristina che risulta essere il punto centrale del viaggio.
A sua volta la Via Francisca del Lucomagno legata ad un antico tracciato romano-longobardo, storicamente documentato, partendo da Costanza, centro dell’Europa, e attraversando la Svizzera mediante il passo del Lucomagno giungeva fino a Pavia con un percorso fondamentale di collegamento dallo stesso centro dell’Europa con la Pianura Padana; queste erano le seguenti tappe principali : Costanza, san Gallo, Coira, passo del Lucomagno, Bellinzona, Agno, Varese e Pavia.Significativo oltre al fatto della mansio di Pavia quale punto di incontro e di unione di questi due itinerari, di grande interesse poi, alla luce di antichi e giovanili ricordi, che nell’ambito delle manifestazioni che faran seguito alla lodevole iniziativa del Comune di Robecco sul Naviglio congiuntamente alla Regione Lombardia sulla valorizzazione di tale via, nei prossimi giorni si darà l’avvio ad un percorso a tappe di un tratto della stessa Via Francisca del Lucomagno da Lavena Ponte Tresa-Pavia; inoltre la mansio di Motta Visconti è stata inserita come arrivo della 8° tappa Abbiategrasso – Motta Visconti e partenza della non e ultima tappa Motta Visconti-Pavia. Infatti il ricordo non può che andare alla Cä dal frä (la Casa del Frate), situata al confine tra i comuni di Motta Visconti e di Besate e distrutta negli anni ’50 e di certo per secoli mansio lungo la Via Mercatorum ( Magenta-Pavia); inoltre la la stessa Via Francisca del Lucomagno che dall’Abbiatense portava come da recente ricostruzione storica, snodandosi parallelamente al corso del fiume Ticino, alla mansio di Pamphica ( Pavia). Pare fosse stata anche in anni sconosciuti anche la dimora di un eremita da cui il nome, comunque bello pensare come qui i viandanti e i pellegrini nel tempo antico vi trovassero luogo amichevole di sosta, di riposo e di ristoro. Da Ticino Notizie
Il fiume Ticino: il brigantaggio-Tadè il brigante di Motta Visconti
Viaggiatori assaliti dai briganti, dipinto di Bartolomeo Pinelli (1817). da Internet Alla voce Brigantaggio-Wikipedia (1) così si legge :” Il brigantaggio è una forma di banditismo caratterizzata da azioni violente a scopo di rapina ed estorsione, mentre in altre circostanze esso assume risvolti insurrezionalisti a sfondo politico e sociale. Sebbene il fenomeno abbia origini remote e riguardi periodi storici e territori diversi, nella storiografia italiana questo termine si riferisce generalmente alle bande armate presenti nel Mezzogiorno tra la fine del XVIII secolo e il primo decennio successivo alla proclamazione del regno d'Italia nel 1861. L'attività brigantesca assunse connotati politici e anche religiosi all'inizio del XIX secolo, con le sollevazioni sanfediste antifrancesi. Fu duramente repressa all'epoca del Regno di Napoli e durante l'occupazione napoleonica, borbonica e risorgimentale, quando, dopo essersi ulteriormente evoluta, si oppose alle truppe del neonato Stato italiano. In questa fase storica, sia all'interno che al di fuori di queste bande e mossi anche da motivazioni di natura sociale e politica, agivano gruppi di braccianti ed ex militari borbonici. Nessuna regione, da Nord a Sud , di quel che sarebbe stato il futuro Regno d’Italia fu risparmiata in questi secoli, pur con ragioni e modalità diverse, dalla piaga del brigantaggio, alla letteratura riportata in margine a tale voce si rimanda per specifici approfondimenti ed in particolare ai riferimenti(2-3-4). Nella presente nota viene dato uno sguardo a quanto riportato dalle cronache per quanto concerne il brigantaggio nel Lombardo-Veneto ai tempi dell’Imperatrice Maria Teresa e limitatamente ai boschi del fiume Ticino nel tratto che va da Castelletto Ticino fino a Torre d’Isola, ovvero l’abbiatense con punto centrale Motta Visconti tra i suoi boschi rivieraschi e quelli della allora sponda piemontese di Garlasco e Vigevano Il fiume Ticino, le sue sponde, i suoi boschi e sottoboschi come già descritto in alcune note o poesiole apparse anche su Ticino Notizie (5-6-7) furono nel passato spettatori di vite dal diverso aspetto , non solo di oneste figure di cavatori di ciottoli quarzosi, di cercatori di pagliuzze e di piccole pepite d’oro, di gente dedita alla raccolta di legna di funghi, di flora o al taglio di giunchi e vimini oltre alla caccia di uccelli e di piccolo mammiferi o alla pesca ma anche di persone al di fuori o ai margini o ai confini della legalità: briganti e piccoli contrabbandieri .Questo avveniva con particolare attività e come narrano le cronache, nel Settecento, tra quelle zone del Ticino di quel incerto confine tra Piemonte e Lombardia.Infatti per il trattato di Aquisgrana, stipulato nel 1748, l’Austria occupava l’antico Ducato di Milano ed i piemontesi potevano estendere il loro dominio fino al Ticino; ma la pace era stata raggiunta dopo lunghe guerre che causarono disastri, sofferenze e disordini gravi alle popolazioni lombarde. I boschi del Ticino erano così diventati il rifugio di bande di briganti ed assassini della peggior specie che rapinavano i passanti, assalivano le abitazioni isolate ed uccidevano facilmente per rubare o per vendetta.(8) Così come riportano gli Atti dell’Archivio Storico Lombardo, nella seconda metà del Settecento, la lotta al contrabbando, che lungo il Ticino era un fenomeno endemico, rese necessarie alcune disposizioni e specifici e mirati interventi delle autorità governative. (9-10) A tal fine fu potenziato, lungo il fiume, il controllo delle forze dell‘ordine e furono istituite le prime « ricevitorie » della finanza per cercare di arginare i « movimenti commerciali clandestini » da e per lo Stato Sardo. In particolare, l’imperatrice d’Austria Maria Teresa volle estirpare la mala pianta del banditismo comminando pene crudeli che, per quanto inflitte da tutti i tribunali degli stati europei, suscitarono un senso di orrore negli stessi contemporanei (8). Mia nonna paterna Carolina Barenghi di Boffalora sopra Ticino (11) si ricordava che nel passato alcuni suoi parenti per sbarcare il loro povero lunario erano dediti tra le sponde del fiume ad attività di piccolo contrabbando. Ma come detto, oltre al contrabbando una altra piaga ben più pericolosa per la collettività e per l’ordine sociale si appoggiava od era in competizione con quest’ultimo: il banditismo. Così riporta l’interessante libro dello storico Mario Comincini :” Storia del Ticino:la vita sul fiume dal Medioevo all’età contemporanea”-Società storica abbiatense-1981, (7) :”… briganti sanguinari che non esitano ad assalire non solo i casolari sparsi per le campagne, ma anche grossi villaggi; i loro frequenti e funesti sconfinamenti nel Milanese già nel 1761 avevano indotto il governo austriaco ad istituire un cordone di truppe sulla sponda sinistra del fiume, da Sesto a Pavia, e a chiedere la collaborazione delle comunità locali, invitate a suonare la campana a martello appena veniva avvistata una masnada di quei malviventi”Altri particolari significativi sulle attività di banditismo sono riportate da un altro storico locale Ambrogio Palestra sia nella sua Storia di Abbiategrasso e sia in alcune pagine della Storia di Motta Visconti e dell’antico Vicus di Campese (12) .“ I boschi del Ticino erano diventati il rifugio di bande di briganti e di assassini dello peggior specie che rapinavano i passanti, assalivano le abitazioni isolate ed uccidevano facilmente per rubare o per vendetta” Tra i più feroci di questi grassatori criminali i due Storici ( 7-12) ricordano in particolare un brigante di Motta Visconti, così il primo storico :” ……Dal 1754 al 1771 una decina di briganti che terrorizzavano l’Abbiatense finì sulla forca, subendo prima sevizie di ogni genere: Giuseppe Lisso detto Tadè, di Motta Visconti, ladro e grassatore, fu condannato ad essere tirato a coda di cavallo fino al luogo dell’impiccagione…”Il secondo storico(12) : “ Fra i condannati a morte vi fu anche un feroce bandito chiamato Giuseppe Lisso, detto Tadè, della Motta Visconti, che spadroneggiò ferocemente sule strade lungo il Ticino, assalì i viandanti, invase le abitazioni dei terrorizzati abitanti dal 1744 al 1760. Aveva con sé la moglie Anna Maria Lisso, unica donna tra tanti truci briganti….condannata a morte la pena le fu poi commutata in una specie di ergastolo a vita…”Ci fu ad Abbiategrasso una confraternita dei Disciplini di San Bernardino che si assunse il compito di assistere questi banditi condannati a morte e della loro opera di assistenza spirituale ci hanno lasciato una dettagliata relazione col nome dei condannati, la descrizione delle torture che venivano loro comminate (8).In conclusione, come curiosità personale ricordo che ancora negli anni cinquanta, alla fine della seconda guerra mondiale, le mamme di Motta Visconti come minaccia ai loro bimbi capricciosi e disobbedienti si rivolgevano a loro con queste parole ..” ..fai il bravo se no arriva Tada”…“.. attento e buono altrimenti dai boschi verrà a prenderti Tada (13) ” …………………………………………………………………………. Nota 1) Rif (1)Secondo alcuni, il termine "brigante" deriverebbe dal popolo celtico dei Briganti (abitanti della Britannia), insediato presso Eboracum (York) e, sempre per costoro, tristemente famoso presso i romani a causa della loro riottosità[1]; secondo il Devoto per briga è da intendersi una parola che in lingua gallica (il gallico è una lingua celtica estinta, parlata nelle antiche Gallie, praticamente le odierne Francia ed Italia settentrionale), indica "forza", passata poi a significare "prepotenza"[ Il nome Brigantes (Briganti, Βρίγαντες; della Britannia) è affine a quello della dea celtica Brigantia. Comunque il nome viene da una radice celtica che significa altitudine. Il nome Brigantes infatti è collegabile a brig che significa "alto, elevato ed anche colle, altura" e non è chiaro se i nomi derivati erano così denominati col significato di "quelli alti" nel senso metaforico di animi nobili, o col significato di "montanari", oppure col significato di abitanti, luoghi o fortificazioni situati in altura. Anche il nome Brigit ed altri simili avrebbero avuto la stessa origine in Irlanda[. A parziale conferma, Tolomeo nel menzionare i Brigantes, li riconosce come tribù presente anche in Irlanda. Un'altra tribù celtica (da taluni identificata come Brigantii) è citata da Strabone come una sub-tribù presente nel territorio dei Vindelici. Nella geografia pre-romana dell'Europa, Vindelicia era una regione delimitata a nord dal Danubio (e successivamente dal Limes Germanico di Adriano), a est dall'attuale fiume Inn, a sud dalla Rezia e ad ovest dal territorio degli Elvezi. Il suo capoluogo divenne con i Romani Augusta Vindelicorum ("Augusta dei Vindelici", o Augusta). L'origine etnica del Vindelici non è sicura. In ogni caso solo verso la fine del primo secolo d.C. questa regione è stata inclusa nella provincia della Rezia dove erano sicuramente presenti sub-tribù di Brigantes Celti. Nella lingua italiana la parola brigante, da cui, fra gli altri, i nomi inglesi e francesi di brigand e brigade (e poi anche di brigandage) si evidenzia da espressioni derivate dal latino medievale non prima del XIV secolo. Il termine brigante, con la connotazione di "fuorilegge", deriverebbe, come sopra affermato, da "brigare"[4]. Non vi sarebbe dunque un'origine celtica di termini relativi alla parola brigantaggio ed anche se una derivazione celtica fosse possibile, ogni connessione con la tribù celtica dei Brigantes della Britannia appare affatto improbabile in quanto detta tribù non aveva avuto alcuna particolare presenza nella penisola italica ed era scomparsa come popolo da qualche migliaia di anni rispetto al momento in cui comparvero termini correlati con brigantaggio. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………… Nota 2) Rif. (4-9) Nel Ducato di Milano, siamo nel XVI secolo, presso il Bosco della Merlata, che era una distesa boschiva a nord est di Milano e che prendeva il nome del torrente Merlata che vi scorreva, agiva una banda di briganti, i quali avevano la loro base presso l’Osteria di Melgasciada, famosa perché i milanesi facevano tappa per gustare gli asparagi. I capi di questa banda di briganti, tali Giacomo Legorino e Battista Scorlino, furono poi catturati e messi a morte. Il fenomeno però non veniva meno, tanto che nella brughiera di Gallarate i briganti spadroneggiavano, per cui i governatori furono costretti a mettere una taglia di ben 100 mila scudi a chi eliminava questi banditi. Furono loro stessi che incamerarono quel premio, poiché si offersero di entrare a far parte delle guardie dei governatori. Oltre ai due capi sopra ricordati, tra l’altro veri e proprio malfattori, facciamo adesso la conoscenza di altri due briganti, il primo, tale Giacomo Carciocchi, detto “il Carcini”, nativo di Plesio, nel comasco, dove, unitamente al compagno Pacini, operò con la sua temibile banda, il cui nascondiglio era in una grotta ancora oggi chiamata “Bogia di brigant”, sul monte Grona. Il Pacini divenne un personaggio nel teatro dei burattini bergamasco, col nome di “Pacì Paciana”. L’altro, il cui nome era Vincenzo Pacchiana, di origini della provincia di Bergamo, divenne, da oste che era, brigante In seguito a una condanna per furto subita ingiustamente. Un’altra versioneracconta che era un gendarme del governo Veneto, condannato da questi per vari reati, si diede alla macchia e al brigantaggio. Permettetemi di ritornare un attimo sulla citata Osteria Melgasciada, tra l’altro ancora oggi in attività, poiché dal volume “vecchie osterie milanesi”, di L. Medici, leggo che sull’uscio che immette nella cucina grande, è scritta la seguente strofa: Qui è murata la testa della mula dei celebri briganti Giacomo Legorino e Battista Scorlino giustiziati nel Maggio del 1566 Ecco un altro piccolo spaccato della nostra storia lombarda, e, prima di concludere, brigante, nel nostro dialetto meneghino si dice “brigànt o sassìn de strada”. ………………………………………………………………………. Nota 3) Rif. (7-8-12) Quando una sentenza di morte veniva pronunciata, il podestà di Abbiategrasso inviava ai Confratelli copia della sentenza dove erano descritti i crimini dei condannati, invitandoli a compiere il loro pietoso ufficio. Il priore dei Disciplini con alcuni foglietti assegnava ai confratelli i diversi compiti; alcuni giravano per il borgo questuando la somma di denaro necessaria; altri caricavano un altare di legno sopra un carro e si recavano alle carceri di Milano, dove sino al giorno dell’esecuzione assistevano il condannato facendo perfino celebrare messe nella sua stessa cella. Lo persuadevano a confessarsi, a comunicarsi e a recitare preghiere per prepararsi a sopportare pazientemente i terribili tormenti. Comperavano anche cibarie che offrivano ai condannati e prodigavano loro quelle cure che servissero a dare loro un poco di sollievo. Raccoglievano infine il corpo straziato e gli davano pietosa sepoltura nella stessa chiesa di San Bernardino dove ancor oggi, dinnanzi all’altare del Crocifisso, vi era nel pavimento una pietra tombale che reca incisa una triste parola: Giustiziati. Fra i condannati a morte vi fu anche un feroce bandito chiamato Giuseppe Lisso detto Tadé, di Motta Visconti, che spadroneggiava ferocemente sulle strade lungo il Ticino, assaltando i viandanti, invase le abitazioni dei terrorizzati abitanti dal 1744 al 1760. Aveva con sè la moglie Anna Maria Lisso, unica donna fra tanti truci briganti, la quale seguiva la banda capeggiata dal marito e lo aiutava a commettere i peggiori crimini. Quando venne acciuffata dagli sbirri subì il processo e le fu commutata la pena di morte in cinque anni di “camuccione”, che probabilmente era una specie di segregazione, e nel carcere a vita. Il Tadé suo marito fu condannato ad essere tirato a coda di cavallo fino al luogo dove venne impiccato. …………………………………………………………………………………………………………………… Riferimenti bibliografici 1) Brigantaggio-Wikipedia-Internet 2) Brigantaggio in Treccani.it – Enciclopedia on line-Istituto dell’Enciclopedia Italiana-15 Marzo 2011 3) Giuseppe Pennacchi-“ L’Italia dei briganti”-Rendine, 1988 4) Laura Colombo-“ Banditi al bosco della Merlata: un episodio di brigantaggio nella Milano spagnola del XVI secolo-Comune di Milano 5) Giuseppe Gianpaolo Casarini-“L’oro del Ticino tra realtà e leggenda”-Cultura e Prospettiva-n.48, 2018-Convovio Editore 6) Giuseppe Gianpaolo Casarini-“ Persone al di fuori o ai margini della legalità”-Ticino Notizie-Internet 7) Mario Comincini-” Storia del Ticino:la vita sul fiume dal Medioevo all’età contemporanea”-Società storica abbiatense-1981 8) Punto di Vista-Motta Visconti-Dicembre 2017-Facebook 9) Oliviero Spada- Brigantaggio e briganti milanesi: storia lombarda-da Internet 10) G. Solavaggione-“ Brigantaggio e contrabbando nella campagna lombarda del Settecento”-Nuova Rivista Storica.11) Carolina Barenghi-Comunicazione personale-Motta Visconti-1950 12) Ambrogio Palestra-“ Storia di Motta Visconti e dell’antico Vicus Campese”-Motta Visconti, 198213) Antonia Scotti – Comunicazione personale-Motta Visconti-1950
RICHIAMI DI METALLURGIA NELLA LETTERATURA Giuseppe Casarini-Binasco (MI) RIASSUNTO
“ Fragile è il ferro allor ché non resiste/di fucina mortal tempra
terrena/
“Ecco Rinaldo con la spada adosso/a
Sacripante tutto s'abbandona;/ La scoperta dei metalli, delle leghe metalliche e il loro uso, dall’età del ferro all’era moderna, quella degli acciai inossidabili e delle superleghe, hanno accompagnato ed accompagnano l’evoluzione e la storia dell’umanità nonché il suo modo di vivere. Nella pratica quotidiana, per limitarci al loro impiego in casa, in ufficio e nei mezzi di trasporto, i metalli, sotto forma di oggetti e di manufatti, i più disparati, ci sfiorano e ci sono a portata di mano anche tale continua familiarità lo fa spesso dimenticare e porta alla ingrata indifferenza. Tuttavia non solo nella praticità e nel campo della scienza e del mondo industriale ma anche nel campo delle arti i metalli hanno dato e danno direttamente un significativo contributo all’appagamento di altri bisogni e necessità dell’uomo, quelle dell’estetica e del bello: basti pensare alle statue bronzee della antichità classica ed alle moderne sculture in acciaio inossidabile. Indirettamente, e questo è il tema di questo excursus, vedremo come sempre nel campo degli appagamenti culturali e dello spirito i metalli abbiano offerto ed offrano immenso materiale nel campo della letteratura. Spaziando in questo campo, dall’antichità ai tempi nostri è facile riscontrare, punto di riferimento la Divina Commedia, nella quale sono state evidenziate e commentate a suo tempo le innumerevoli terzine con riferimento ai metalli, come gli stessi metalli non siano sfuggiti alla penna di storici, pensatori e poeti per evocare immagini, suggestioni, riflessioni degne della nostra attenzione. Nella presente memoria, data la vastità dell’esplorazione, il campo di indagine è stato confinato alla classicità greco-romana. Vedremo come questa, attraverso i versi di Esiodo, Omero, Ovidio, Lucrezio,Virgilio e Tibullo, offra un immenso tesoro di riferimenti alla metallurgia ed alla lavorazione dei metalli: metalli come simbolismo tra dei, miti e leggende, suggestivi versi sull’origine della metallurgia, sull’impiego e l’uso dei metalli, le loro proprietà, l’usura, la corrosione, il riciclaggio, nonché sfolgoranti descrizioni e una profusione di oggetti metallici.Ai poemi cavallereschi della letteratura italiana, se ci sarà, il prossimo appuntamento a cominciare dal Tasso e dall’Ariosto.
INTRODUZIONE Fluit aes rivis aurique metallum, vulnificusque chalybs vasta fornace liquescit ( Scorrono a ruscelli il bronzo e l’oro, l’acciaio atto a ferire si liquefa nel vasto forno): questo frammento di un famoso distico tratto dall’Eneide virgiliana , risulta impresso, quale motto, sulla moneta etrusca raffigurante Vulcano, il dio dei metalli, adottata come stemma dall’Associazione degli Industriali Metallurgici, primo atto di quella che sarà in seguito l’Associazione Italiana di Metallurgia ed è apparso per la prima volta nel numero di settembre del 1917 della nostra rivista La Metallurgia Italiana a testimonianza del connubio che sempre dovrebbe ricercarsi tra scienza ed arte. A partire da tale frammento, già citato a suo tempo nelle ricerche su Dante, i suoi mentori e la Divina Commedia (1-3) cercheremo di scoprire, con riferimento alla classicità greco-latina, le immagini, le suggestioni e le riflessioni che i metalli hanno evocato e prodotto nei versi dei poeti di quel tempo antico. Tale breve ricerca, oltre che sprone per i giovani cultori della metallurgia ad una più approfondita ricerca in questo campo, vuole rendere un modesto omaggio a tutti quegli studiosi che in passato non hanno disgiunto l’amore della scienza con quello della letteratura, primo fra tutti l’Ing. Giuseppe Cozzo e poi: E. Crivelli, A. Uccelli, G. Somigli e I. Guareschi (4-7)
I METALLI COME SIMBOLISMO: TRA DEI, MITO E LEGGENDA L’antropologia moderna analizzando la preistoria e la protostoria dell’umanità, classifica la sua evoluzione attraverso le seguenti età: età della pietra ( paleolitico, mesolitico, neolitico), età del bronzo e età del ferro in funzione della natura dei primi utensili impiegati dall’uomo e dalla cronologia della scoperta e dell’uso dei metalli. Anche nell’antichità seppure strettamente legata a superstizioni, suggestioni di interventi divini tra miti e leggende varie, l’importanza dei metalli, come fattori di progresso, era già stata fortemente sentita e percepita nonché tradotta anche in componimenti epici o liriche nostalgiche ed accorate. Inizialmente, sia nel mondo greco e poi in quello latino, al pari della visione biblica dell’Eden o Paradiso terrestre, la prima fase della storia dell’umanità veniva confinata nell’età dell’oro, età ove regnano pace e serenità, seguita poi, come punizione divina, a periodi di guerre e di discordie: metalli sottratti all’aratura dei campi e trasformati in armi letali. Classicità GrecaPer primo, Esiodo, epico greco della fine dell’VIII sec. A.C., nelle “Opere ed i giorni” (8) enumera cinque età del mondo, fondate proprio sull’uso dei metalli, ed nelle quali si sarebbero avvicendate altrettante “specie umane”, o in altre parole, altrettanti stadi della civiltà. La prima detta “età dell’oro” in cui vecchiaia, preoccupazioni ed affanni della vita erano stati risparmiati agli uomini e dove il suolo fertilissimo avrebbe offerto spontaneamente erbe e frutta in abbondanza. A questa sarebbe seguita la stirpe “ dell’età dell’argento” distrutta da Zeus per la pochezza della sua intelligenza e per il disprezzo verso gli Dei; terza “l’età del bronzo”, vigorosa ed indomabile e dal cuore duro conclusasi tra lotte tremende e crudeli.Ad esse seguiranno una quarta, come fase di transizione, per poi ultima “l’età del ferro”, quella in cui visse il poeta, piena di sofferenze, di miserie, di delitti e di empietà.“Prima una stirpe aurea di uomini mortali/ fecero gli immortali che hanno le olimpie dimore...come dèi vivevano, senza affanni nel cuore,.. il suo frutto dava la fertile terra../Come seconda una stirpe peggiore assai della prima,/argentea, fecero gli abitatori delle olimpie dimore,..vivevano ancora per poco, soffrendo dolori../né gli immortali venerare volevano,/ né sacrificare ai beati sui sacri altari,../ Zeus padre una terza stirpe di gente mortale/fece, di bronzo, in nulla simile a quella d'argento,..di bronzo eran le armi e di bronzo le case,/col bronzo lavoravano perché il nero ferro non c'era…di nuovo una quarta, sopra la terra feconda,/fece Zeus Cronide, più giusta e migliore,/di eroi, stirpe divina, che sono detti semidei, …/combattendo per le greggi di Edipo,…./là il destino di morte li avvolse;/ma poi lontano dagli uomini dando loro vitto e dimora/il padre Zeus Cronide della terra li pose ai confini./…Zeus, poi, pose un'altra stirpe di uomini mortali/dei quali, quelli che ora vivono.../perché ora la stirpe è di ferro; né mai di giorno/cesseranno da fatiche e affanni, né mai di notte,/affranti; e aspre pene manderanno a loro gli dèi.” Classicità Latina
A quella medesima e
felice età dell’oro ricordata da Esiodo si richiameranno più tardi
anche i poeti elegiaci latini. In particolare, Ovidio (
Tibullo ( 55-
Anche Virgilio (70- Tema dell’età dell’oro ripreso poi dallo stesso Virgilio in una sorta di profezia messianica, anche nelle Bucoliche ( IV Ecloga) :”O Muse sicule, cantiamo poesie più elevate: non a tutti piacciono gli arbusti e le basse tamerici;/se cantiamo i boschi, siano boschi degni di un console. /E' giunta l'ultima età / di nuovo nasce un grande ciclo di secoli e già torna la Vergine, tornano i regni di Saturno, già una nuova generazione viene fatta scendere dall'alto cielo./Tu, casta Lucina, sii propizia al bambino che sta per nascere / al tempo del quale inizierà a scomparire la generazione del ferro/ e in tutto il mondo sorgerà quella dell'oro; il tuo Apollo regna già./”(12).
LA METALLURGIA NEI GRANDI POEMI DELL’ANTICHITA’ La nascita della metallurgia : la lavorazione dei metalli e l’uso dei metalli
Il poeta latino Tito
Lucrezio Caro ( 98-
Le proprietà dei metalliDi seguito e sempre nel Libro V, Lucrezio mette in evidenza come, dopo la scoperta della metallurgia, gli uomini abbiano imparato a conoscerne subito le caratteristiche e l’utilità:” E dapprima s'apprestavano a far queste cose con l'argento e l'oro/non meno che con la forza violenta del possente rame,/ma invano, poiché la tempra di quelli vinta cedeva,/né potevano sopportare ugualmente il duro sforzo./Difatti ‹il rame› era più pregiato e l'oro era trascurato/per l'inutilità, perché si smussava con la punta rintuzzata./” ma, come mette in evidenza Lucrezio i tempi cambiano :”/Ora è trascurato il rame, l'oro è asceso al più alto onore./Così il volgere del tempo tramuta le stagioni delle cose:/ciò che era in pregio, diventa alfine di nessun valore;/”… Usura e corrosione dei metalli L’osservazione di Lucrezio sui metalli e sul loro decadimento con specifico riferimento alla concezione atomistica delle cose, si fa ancora e più profonda ( Libro I) : qualsiasi sia la natura del metallo o della lega: oro, ferro, bronzo, al pari delle pietre, tutto ciò, con l’impiego e nel tempo, si usura e si corrode senza che noi ne possiamo conoscerne il perché :“Per di più, nel corso di molti anni solari l'anello,/a forza d'essere portato, si assottiglia dalla parte che tocca il dito;/lo stillicidio, cadendo sulla pietra, la incava; il ferreo vomere/adunco dell'aratro occultamente si logora nei campi;/e le strade lastricate con pietre, le vediamo consunte/dai piedi della folla; e poi, presso le porte, le statue/di bronzo mostrano che le loro mani destre si assottigliano/al tocco di quelli che spesso salutano e passano oltre./Che queste cose dunque diminuiscano, noi lo vediamo,/perché son consunte. Ma quali particelle si stacchino in ogni/momento, l'invidiosa natura della vista ci precluse di vederlo./ “ Riciclaggio Virgilio, nel Libro VII dell’Eneide, ci offre un saggio poetico sui riciclaggi del ferro e dell’acciaio: il nemico incombe e bisogna difendersi : attrezzi agricoli e mezzi per dissodare il terreno vengono rifusi e trasformati sotto forma di armi e di corazze: “ Cinque grosse città con mille incudi/ a fabbricare, a risarcir si dànno/ d'ogni sorte armi: la possente Atina,/ Ardea l'antica, Tivoli il superbo,/ e Crustumerio, e la torrita Antenna./ Qui si vede cavar elmi e celate;/ là torcere e covrir targhe e pavesi:/per tutto riforbire, aüzzar ferri,/ annestar maglie, rinterzar corazze,/ e per fregiar piú nobili armature,/ tirar lame d'acciar, fila d'argento./ Ogni bosco fa lance, ogni fucina/ disfà vomeri e marre, e spiedi e spade/ si forman dai bidenti e da le falci.”/ Sfolgoranti descrizioni Omero (IX sec. A.C.), nell’Iliade come nell’Odissea e parimenti Virgilio, nell’Eneide, quasi gareggiando tra di loro, ci offrono a profusione, “forgiando” indimenticabili versi, una sfolgorante descrizione di metalli in varie forme e dalle fogge e decorazioni le più diverse:armi, scudi, cocchi divini, vasellame, suppellettili, abitazioni, strumenti musicali; per brevità ci si dovrà limitare solo ad alcuni rimandi: al lettore diligente la voglia ed il compito di dar seguito a personali approfondimenti. Gli scudi di Achille e di Enea Di seguito sono riportati i versi che descrivono il lavoro di Efesto-Vulcano nell’atto di forgiare, su richiesta di Teti, la madre di Achille, il nuovo scudo del Pelide dopo che quello indossato in sua vece da Patroclo era stato preda di Ettore a seguito dell’uccisione del fraterno amico.”Eran venti che dentro la fornace/per venti bocche ne venìan soffiando,/e al fiato, che mettean dal cavo seno,/or gagliardo or leggier, come il bisogno/chiedea dell'opra e di Vulcano il senno,/sibilando prendea spirto la fiamma./In un commisti allor gittò nel fuoco/argento ed auro prezïoso e stagno/ed indomito rame. Indi sul toppo/locò la dura risonante incude,/di pesante martello armò la dritta,/di tanaglie la manca; e primamente/un saldo ei fece smisurato scudo/di dèdalo rilievo, e d'auro intorno/tre ben fulgidi cerchi vi condusse,/poi d'argento al di fuor mise la soga./Cinque dell'ampio scudo eran le zone,/ (14 ) Non da meno è l’abilità poetica di Virgilio, nell’VIII libro dell’Eneide, nel descrivere il lavoro dei Ciclopi, intenti nelle nere fucine etnee del dio Vulcano, a forgiare , su richiesta di Pallade-Atena, le armi di Enea: “Tosto che giunse: «Via, - disse a' Ciclopi -/ sgombratevi davanti ogni lavoro,/ e qui meco guarnir d'arme attendete/ un gran campione. E s'unqua fu mestiero/ d'arte, di sperïenza e di prestezza,/ è questa volta. Or v'accingete a l'opra/ senz'altro indugio». E fu ciò detto a pena,/ che, divise le veci e i magisteri,/ a fondere, a bollire, a martellare/ chi qua chi là si diede. Il bronzo e l'oro /corrono a rivi; s'ammassiccia il ferro,/ si raffina l'acciaio; e tempre e leghe/ in piú guise si fan d'ogni metallo./ Di sette falde in sette doppi unite,/ ricotte al foco e ribattute e salde,/ si forma un saldo e smisurato scudo,/ da poter solo incontro a l'armi tutte/ star de' Latini. Il fremito del vento /che spira da' gran mantici, e le strida/ che ne' laghi attuffati, e ne l'incudi/ battuti, fanno i ferri, in un sol tuono/ ne l'antro uniti, di tenore in guisa /corrispondono a' colpi de' Ciclopi,/ ch'al moto de le braccia or alte or basse/ con le tenaglie e co' martelli a tempo fan concerto, armonia, numero e metro/” Una profusione di oggetti metallici Poi in un crescendo di citazioni, sia in Omero che in Virgilio, appaiono magnifiche descrizioni di: cocchi divini, vasellame, suppellettili, abitazioni, strumenti musicali: IliadeNel bel mezzo della battaglia tra Achei e Troiani, ecco intervenire in aiuto dei due schieramenti, alcune divinità armate di tutto punto ( Iliade-Libro V):“Immantinente al cocchio Ebe le curve/ruote innesta. Un ventaglio apre ciascuna/d'otto raggi di bronzo, e si rivolve/sovra l'asse di ferro. Il giro è tutto/d'incorruttibil oro, ma di bronzo/le salde lame de' lor cerchi estremi./Maraviglia a veder! Son puro argento/i rotondi lor mozzi, e vergolate/d'argento e d'ôr del cocchio anco le cinghie/con ambedue dell'orbe i semicerchi,/a cui sospese consegnar le guide./Si dispicca da questo e scorre avanti/pur d'argento il timone, in cima a cui/Ebe attacca il bel giogo e le leggiadre/pettiere; e queste parimenti e quello/d'auro sono contesti. Desïosa/Giuno di zuffe e del rumor di guerra,/gli alipedi veloci al giogo adduce./Né Minerva s'indugia. Ella diffuso/il suo peplo immortal sul pavimento/delle sale paterne, effigïato/peplo, stupendo di sua man lavoro,/e vestita di Giove la corazza/di tutto punto al lagrimoso ballo/armasi. Intorno agli omeri divini/pon la ricca di fiocchi Egida orrenda,/che il Terror d'ogn'intorno incoronava/” OdisseaOro, argento, rame: questa l’offerta, segno dell’opulenza delle case di Ilio, di un prigioniero troiano onde aver salva la vita come descritto nel libro VII: “L'aggiungono anelanti i due guerrieri,/l'afferrano alle mani, ed ei piangendo/grida: Salvate questa vita, ed io/riscatterolla. Ho gran ricchezza in casa/d'oro, di rame e lavorato ferro./Di questi il padre mio, se nelle navi/vivo mi sappia degli Achei, faravvi/per la mia libertà dono infinito.” Sempre nello stesso libro:“Palagio chiara, qual di sole o luna,/Mandava luce. Dalla prima soglia Sino al fondo correan due di massiccio/Rame pareti risplendenti, e un fregioDi ceruleo metal girava intorno./Porte d'ôr tutte la inconcussa casaChiudean: s'ergean dal limitar di bronzo/Saldi stìpiti argentei, ed un argenteo Sosteneano architrave, e anello d'oro/Le porte ornava; d'ambo i lati a cui,Stavan d'argento e d'ôr vigili cani:/Fattura di Vulcan, che in lor ripose” … “Canto arricchillo. Il banditor nel mezzo/Sedia d'argento borchiettata a lui/Pose, e l'affisse ad una gran colonna:/Poi la cetra vocale a un aureo chiodo/Gli appese sovra il capo, ed insegnagli/,Come a staccar con mano indi l'avesse.” Ecco, nel libro X dello stesso poema, la munificenza di oro, argento, bronzo, che arreda le maritali stanze della maga Circe dove Ulisse riprende le vigorose forze:“Bei tappeti di porpora, cui sotto/Bei tappeti mettea di bianco lino:/L'altra mense d'argento innanzi ai seggi/Spiegava, e d'oro v'imponea canestri:/Mescea la terza nell'argentee brocche/Soavissimi vini, e d'auree tazze/Coprìa le mense: ma la quarta il fresco/Fonte recava, e raccendea gran fuoco/Sotto il vasto treppié, che l'onda cape./Già fervea questa nel cavato bronzo,/E me la ninfa guidò al bagno, e l'onda/Pel capo mollemente e per le spalle/Spargermi non cessò, ch'io mi sentii/Di vigor nuovo rifiorir le membra./Lavato ed unto di licor d'oliva,/E di tunica e clamide coverto,/Sovra un distinto d'argentini chiovi/Seggio a grand'arte fatto, e vago assai,/Mi pose: lo sgabello i piè reggea/.E un'altra ninfa da bel vaso d'oro/Purissim'acqua nel bacil d'argento/ “ EneideE non da meno, come descrizioni di opulenza e di splendori metallici, risultano questi vrsi tratti dal libro II dell’Eneide:Poscia che ciò come profeta disse,/ comandò come amico ch'a le navi/ gli portassero i doni, opre e lavori/ ch'avea d'oro e d'avorio apparecchiati/, e gran masse d'argento e gran vaselli /di dodonèo metallo: una lorica/ di forbite azzimine; e rinterrate/ maglie, dentro d'acciaro e 'ntorno d'oro/, una targa, un cimiero, una celata,/ ond'era a pompa ed a difesa armato/ Nëottòlemo altero”.
CONCLUSIONI La letteratura della classicità greco-latina, come messo in evidenza, offre un immenso tesoro di riferimenti alla metallurgia ed alla lavorazione dei metalli: metalli come simbolismo tra dei, miti e leggende, suggestivi versi sull’origine della metallurgia, sull’impiego e l’uso dei metalli, le loro proprietà, l’usura, la corrosione, il riciclaggio, nonché sfolgoranti descrizioni e una profusione di oggetti metallici.Ai poemi cavallereschi della letteratura italiana, se ci sarà, il prossimo appuntamento a cominciare dal Tasso e dall’Ariosto.
BIBLIOGRAFIA 1 1) G. Casarini :” Riferimenti ad arti e mestieri alchemici metallurgici nella Divina Commedia: Fabbri e Ferraioli”-28° Convegno Nazionale A.I.M.-Milano Novembre 2000-Atti-Vol.2-pagg 635-541 2 2) G.Casarini:” Metallurgia e scienza nei gironi danteschi”-Civiltà degli Inossidabili-Ediz. Trafilerie Bedini-Dic.1992 3 3) G. Casarini:” Dante Alighieri e la Metallurgia”- Pianeta Inossidabili-Ediz. Acciaierie Valbruna-Giu.1995 4 4) G. Cozzo:” Le origini della metallurgia-I metalli e gli dei”-Editore G.Biardi-1945 Roma 5 5) E. Crivelli:” La metallurgia degli antichi”-Supplem. Ann. Enciclopedia della Chimica-Unione Tipografica Editrice- 1913 Torino 6 6) I. Guareschi :”Storia della Chimica-I colori degli antichi”- ”-Supplem. Ann. Enciclopedia della Chimica-Unione Tipografica Editrice- 1905 Torino 7 7) A. Uccelli-G.Somigli:”Dall’alchimia alla chimica-Storia della Metallurgia e delle lavorazioni meccaniche nel medio-evo”-Enciclopedia storica delle scienze e loro applicazioni”-U. Hoepli Editore-Milano 8 8) Esiodo: “ Le opere e i giorni”-Trad. G. Arrighetti-Ediz.Garzanti-1985 9 9) Ovidio:” Metamorfosi”-Ediz.varie 1 10) Tibullo: “Elegie”_Ediz.varie 1 11) Virgilio:”Eneide”-Trad.A.Caro-Ediz.varie 1 12) Virgilio: “Bucoliche”-Trad. L.Canali-Fabbri Editori 1 13) Lucrezio: “De Rerum Natura” 1 14) Omero: “Iliade”-Trad. V.Monti-Ediz.varie 1 15) Omero: Odissea”-Trad.I.Pindemonte-Ediz.varie 1 16) T. Tasso: “ La Gerusaleme Liberata”-Ediz. varie 1 17) L. Ariosto: “ Orlando Furioso”-Ediz.varie
Cesare Angelini e Il Ticino: Elegia del Ponte Rotto.
Dell’Elegia se ne riporta qui solo una prima perché merita, come spero di fare nel tempo, di essere trattata nella sua interezza con un ampio commento, direi, quasi, con un saggio esegetico! “ E’ lì, da due anni, costernato nella sua sofferenza drammatica, nel silenzio improvviso delle sue arcate; ma con uno strano pudore d’esser guardato, come ogni bellezza devastata. I suoi diritti sono quelli dei mutilati, dei grandi mutilati di guerra, che vanno assistiti, guariti, rifatti. Se no, è una ingiustizia in terra e in cielo. Ma ha pazienza ; nella sua maestosa stanchezza di rudere, dà tempo al tempo. Sa che un ponte non si rifà in un giorno e in una notte, a meno d’affidarne la costruzione al diavolo come i vecchi favoleggiavano di lui, ma lui non vuole. Era, nei secoli, il motivo lirico della nostra città; il suo volto, la sua distinzione; il simbolo nella geografia e nell’arte. Era la firma di Pavia. Un ponte coperto su un bel fiume, non è cosa di tutti i giorni né di ogni città. C’è il ponte di Bassano, il vecchio ponte di Firenze, ma il nostro che era il terzo e basta ( “ i ponte dei sospiri” è un’arcata tenuta su dagli innamorati”) li batteva tutt’e due per imponenza e figura. E quelle cento colonne di granito che ne sorreggevano il tetto, se nelle notti di luna gli davan lievità di sogno di visibile favola, di giorno creavano una balaustra di freschezza per i poveri che vi sostavan volentieri. Era l’edificio più ammirato dallo straniero, quando lo straniero si chiamava Petrarca che invitava un certo Boccaccio a vederlo come opera insigne; o si chiamava Leonardo che provava malinconia di non essere arrivato in tempo a metterci una mano anche lui; o si chiamava Montaigne che, ritornato in Francia, lo lodava tra i suoi. Era l’edificio più ammirato dai concittadini, quando i concittadini si chiamavano Cherubino Cornienti, Pasquale Massacra, Faruffini, Tranquillo Cremona, Ezechiele Acerbi, Erminio Rossi, Romeo Borgognoni: che Dio li ha tutti nella sua pace.” All’inizio dell’Elegia ci viene presentato un Ponte sofferente, stanco in quella “maestosa stanchezza di rudere”, ma paziente in attesa di essere guarito..sa che ci vuole tempo …a meno che..” ma lui non vuole” con riferimento al diavolo e alla favola della sua primitiva costruzione (da Wikipedia:” Secondo una leggenda, la notte di Natale dell’anno 999 molti pellegrini volevano recarsi alla messa di mezzanotte in città, ma, per la fitta nebbia, le barche non potevano effettuare il tragitto. All’improvviso arrivò un uomo vestito di rosso, che promise di costruire immediatamente un ponte in cambio dell’anima del primo passante. L’uomo era il diavolo e solo l’arcangelo Michele accorso dalla chiesa poco distante lo riconobbe; finse d’accettare il patto e, quando il ponte fu costruito, fece passare per primo un caprone. In realtà, il nuovo ponte fu costruito a partire dal 1351 sui ruderi del ponte romano, su progetto di Giovanni da Ferrera e di Jacopo di Cozzo”). Poi dalla penna, dal cuore di Angelini, ecco uno slancio accorato, un amore forte immediato, per questa “creatura” mutilata che “Era, nei secoli, il motivo lirico della nostra città; il suo volto, la sua distinzione; il simbolo nella geografia e nell’arte. Era la firma di Pavia.” Sì solo amore, certezza, nessun dubbio, nessun sciocco campanilismo in quel affermare con decisione la sua supremazia nei confronti degli altri due ponti coperti “su un bel fiume” italiani:” . “ C’è il ponte di Bassano, il vecchio ponte di Firenze, ma il nostro che era il terzo e basta ( “ i ponte dei sospiri” è un’arcata tenuta su dagli innamorati”) li batteva tutt’e due per imponenza e figura” E poi quel lirismo: “ se nelle notti di luna..”. Balaustra di freschezza per i poveri, bello questo riferimento, ai poveri poco importa la bellezza architettonica ma la sua funzionalità ..punto di ristoro, bellezza, imponenza architettonica che invece richiamano l’attenzione e lo stupore dei visitatori “stranieri” e che stranieri: Petrarca, Leonardo, Montaigne! Cosi nelle loro invocazioni qui parzialmente espresse e a quegli inviti agli amici di venire in quel di Pavia per ammirarlo par di sentire la trasmissione e la condivisione della gioia di chi ha trovato un tesoro ma che non lo tiene gelosamente per sé.. sì anche voi amici ne dovete godere quindi venite a vedere! “Era l’edificio più ammirato dai concittadini, quando i concittadini…”, qui Angelini sembra sospirare in quel nostalgico ricordo di quei concittadini, quei bei nomi di valenti pittori , tutti orbitanti in tempi diversi attorno della Civica Scuola di Disegno e di Incisione in seguito divenuta Civica Scuola di Pittura, alcuni morti giovanissimi: Massacra patriota in combattimento, Cremona, l’iniziatore della scapigliatura in pittura, avvelenato da coloranti tossici, e sembra dire “i tempi sono purtroppo cambiati” e diventa nel ricordo un “laudator temporis acti”.
Cesare Angelini e Il Ticino: Elegia del Ponte Rotto. Parte seconda.
“Congiungeva le due rive -come dire la città e la campagna- con un senso vivo di umana solidarietà. E i boschi vicini, rimbiondendo in primavera, gli mandavano vento di giovinezza. Giunta qui, l’acqua del fiume-nato in alto e lontano- rimormorava attonita: “Nel mio percorso non ho visto cosa più bella”; e si metteva a giocare fanciullescamente coi piloni, coi sette archi, che parevano un invito alla danza. Poi più a valle, si cancellava nel Po, ma consolata d’aver visto tale maraviglia. Da piazza Leonardo, da via luigi Porta lo guardavano le torri coetanee con compiacenza di sorelle superstiti; e il tiburio di San Michele e di San Teodoro ogni giorno allungavano il collo per meglio vedere e assicurarsi che era sempre lì.
Ed era sempre lì; un po’ vecchio, un po’ stanco, con quelle sue forme a dorso di mulo. Ma il mulo è sempre più tenace che stanco. E quella schiena curva che portava la dolcezza d’una chiesa fatta a barca, vinceva il peso e il passo dei secoli. In pace temevano che i suoi nemici fossero le piene che d’autunno aggredivano i piloni e invadevano gli archi ponendo quasi storcerli e ruinarli. Ma poi era niente. Le onde sfogavano le forze radunate a Sesto Calende e qui,rompendosi contro il tagliamare, scoppiavano in una fragorosa orchestra di tuoni sommersi. Ma in guerra i suoi nemici furono i mostri precipitanti da cieli apocalittici; e ne hanno slogato le vertebre, sciancate le arcate, mutilato il canto.” “Congiungeva le due rive -come dire la città e la campagna”, ecco la sua funzionalità sociale e di comunicazione, quindi non solo balaustra di freschezza per i poveri in estate, non solo monumento simbolo da ammirare e ammirato, ma quell’unire le due rive quel andirivieni di persone, di merci, di mezzi di trasporto di vario genere. un tempo impedito o difficoltoso , ora diventa possibile grazie a lui che agisce “ un senso vivo di umana solidarietà” tra due mondi diversi, fin qui separati, l’opulenza della città e la povertà della campagna. E nel commento giunge in soccorso, grazie a quanto inviato da un suo pronipote, il Dr. Fabio Maggi, Angelini stesso che nel capitolo “Pavia sotto la neve” così scrive “Dal Ponte vecchio arrivano lenti i carretti insaccati in tendoni carichi di neve; scendono dai paesi di collina dove ne è caduta di più, e ne sono una memoria poetica. Ma fate che un gregge di pecore, sceso da Zavatarello, da Varzi, passi lento sul Ponte coperto; Pavia prende l’aria d’essere ancora nella favola, o appena uscita da una stampa del nostro Giovita Garavaglia o del suo maestro Fausto Anderloni, incisori d’alta statura, che nel grande Ottocento, come i poeti, sapevano ancora commuoversi davanti a queste scene cosmiche, a queste nevi cristiane, vantamento e ricchezza dei nostri siti settentrionali.” Poi ti par di sentire anche tu e di essere sfiorato come il ponte da quel vento di giovinezza che arriva dai boschi in quanto son queste due righe di pura poesia! Acqua che nel suo lungo percorso, circa 200 km, prima di giungere a Pavia, il Ticino nasce nella lontana Svizzera, dalle due sorgenti dei passi di Novena e del Gottardo, ne bagnate di meraviglie con il figlio suo il lago Maggiore ( Intra, Pallanza, le isole Borromee e altro ) ha da lontano visto monumenti, torri, castelli, piazze, abbazie delle lontane Stalvedro e Bellinzona o delle vicine Vigevano e Morimondo. ma… “Nel mio percorso non ho visto cosa più bella” acqua che poi gioca “fanciullescamente coi piloni, coi sette archi, che parevano un invito alla danza” non è anche questa poesia? Acqua che infine muore, muore nel Po ma dolcemente e serenamente dopo aver visto tanta “maraviglia” ! Bello quel animarsi, prender vita delle torri, delle chiese di Pavia che, come piene di timore, vogliono tranquillizzarsi e assicurarsi che sia sempre lì.
E l’Elegia diventa elegia: stupenda la similitudine con il mulo: po’ vecchio, un po’ stanco”. ma “sempre più tenace che stanco”, “quella schiena curva che portava la dolcezza d’una chiesa fatta a barca, vinceva il peso e il passo dei secoli.” Sì le sue battaglie vinte vittoriosamente nei secoli e in tempo di pace durante le piene d’autunno che ” aggredivano i piloni e invadevano gli archi ponendo quasi storcerli e ruinarli. Ma poi era niente. Le onde sfogavano le forze radunate a Sesto Calende e qui, rompendosi contro il tagliamare, scoppiavano in una fragorosa orchestra di tuoni sommersi.” Vittorioso nei secoli e in tempo di pace poi, in un sol giorno e in soli pochi minuti, in guerra, “ i suoi nemici… i mostri precipitanti da cieli apocalittici.. ne hanno slogato le vertebre, sciancate le arcate, mutilato il canto.” Tutta la sofferenza di questo passo dell’Elegia è raccolta in questo “mutilato canto.”
Cesare Angelini e Il Ticino: Elegia del Ponte Rotto. Parte finale “Ora dice la gente:-Bisogna abbattere i ruderi e farne uno nuovo e diverso, che serva agli interessi più di prima- Come se le opere d’arte nascessero per servire gli interessi,o, meglio non servissero all’interesse più vero che è quello dell’anima ossia della bellezza. Dice ancora la gente:-Bisogna costruire non guardando al passato che non torna, ma all’avvenire che incalza- Eppure ha scritto un grand’uomo che solo chi salva il passato e i suoi acquisti, può dirsi intenditore del presente e costruttore dell’avvenire. Signori del Comune,un giorno le ragioni della bellezza si affidavano ai poeti come a difensori naturali. Ora, se mi guardo intorno , non vedo più poeti tra noi, o sono tutti nascosti. Quelle ragioni son quindi affidate a voi e al vostro sentimento. Salvare il ponte, pur nei suoi ruderi, è un modo di rimanere pavesi e di sentire la religione della città perché quel ponte è solo di Pavia; un altro d’ogni altro luogo. Salvate quel ponte come il più grande monumento alla nostra sofferenza , come la lapide più attonita e viva che si possa incidere sull’acqua e sull’aria a memoria della nostra tragedia. Un giorno gli occhi dei poveri a guardarlo, si consolavano come di una cosa bella che anch’essi potevano godere.E in repubblica democratica sarà lecito vergognarsi di ponti ornamentali? Salvate quel ponte. Restituite quel sogno alle nuove generazioni. E’ un invito alla musica, alla bellezza che è parola uscita dalla bocca di Dio. Questa, la vedete. non è poesia. Non è nemmeno polemica. Forse è un grido di dolore. Certo è un grido d’amore: amore di Pavia. Cesare Angelini
Diversi sono i pareri della gente: “Bisogna abbattere i ruderi e farne uno nuovo e diverso, che serva agli interessi più di prima”, ”Bisogna costruire non guardando al passato che non torna, ma all’avvenire che incalza”, cancellare il passato, non guardarsi indietro, servire gli interessi più di prima, guardare all’avvenire: questo dice la gente. Qui nascono all’animo, al cuore di Angelini amarezza e delusione, perché “l’interesse più vero che è quello dell’anima ossia della bellezza” e segue poi un severo monito:” solo chi salva il passato e i suoi acquisti, può dirsi intenditore del presente e costruttore dell’avvenire.” Queste parole derivano da un passo delle “Considerazioni inattuali” di Friedrich Nietzsche contenuta ne “L’utilità e il danno della storia per la vita” e così tradotto da Benedetto Croce, “quel grand’uomo” e suo carissimo o amico “La parola del passato è sempre simile a una sentenza d’oracolo; e voi non la intenderete se non in quanto sarete gli intenditori del presente, i costruttori dell’avvenire”. Merita di ricordare al riguardo che, nel 1946, nel secondo dopoguerra il poliedrico intellettuale Giovanni Pugliese Carratelli fonda La Parola del Passato con Gaetano Macchiaroli, editore rigoroso, impegnato nel sociale e nella politica, rivista ottiene rapidamente un posto di primo piano nel mondo culturale italiano. Il significato e il profilo della rivista sono racchiusi e chiariti in tale frase, che troviamo in epigrafe nella terza di copertina di tutti i fascicoli; è un indirizzo di ricerca: lo studio delle Humanae Littarae non si deve limitare alla mera erudizione, ma alla promozione dell’istruzione morale ed estetica, perché non sia fuga dal presente, ma dia il suo contributo al dibattito contemporaneo; esso può modificare il presente e ha l’obbligo le basi del futuro. Il significato e il profilo della rivista sono racchiusi e chiariti in tale frase, che troviamo in epigrafe nella terza di copertina di tutti i fascicoli; è un indirizzo di ricerca: lo studio delle Humanae Littarae non si deve limitare alla mera erudizione, ma alla promozione dell’istruzione morale ed estetica, perché non sia fuga dal presente, ma dia il suo contributo al dibattito contemporaneo; esso può modificare il presente e ha l’obbligo le basi del futuro. Ritornando alla Elegia Angelini così amaramente si sfoga “… un giorno le ragioni della bellezza si affidavano ai poeti come a difensori naturali. Ora, se mi guardo intorno , non vedo più poeti tra noi, o sono tutti nascosti”. Ma come diremo un poeta vi è ancora e neanche tanto nascosto: è Cesare Angelini! Ed ecco nascere il suo accorato grido agli Amministratori di Pavia:” Salvare il ponte, pur nei suoi ruderi, è un modo di rimanere pavesi e di sentire la religione della città perché quel ponte è solo di Pavia; un altro d’ogni altro luogo”, ma è pure un grido, sì di dolore, per questo ponte dolente:”quel ponte come il più grande monumento alla nostra sofferenza”, un grido infine addolcito da quel nostalgico ricordo:”un giorno gli occhi dei poveri a guardarlo, si consolavano come di una cosa bella che anch’essi potevano godere. E in repubblica democratica sarà lecito vergognarsi di ponti ornamentali?” Se nel grido che richiama alla bellezza, al grido sofferente, al nostalgico grido volto al passato e, infine, se nella invocazione:”Restituite quel sogno alle nuove generazioni” si può far riferimento al Foscolo dell’inno alla bellezza, dell’Ortis, dei Sepolcri, della pavese esortazione “ Italiani vi esorto alle storie” Nel “ E’ un invito alla musica, alla bellezza che è parola uscita dalla bocca di Dio.” vi è tutto il Poeta Cesare Angelini!
Un sentito grazie al Dr. Fabio Maggi pronipote di Cesare Angelini per le varie documentazioni inviatemi Da Ticino Notizie
Nel Maestro di Vigevano innumerevoli le citazioni del fiume azzurro Lucio Mastronardi merita un posto a parte nella nostra ricerca volta a trovare le citazioni del fiume Ticino nella letteratura italiana: nasce a Vigevano, quindi è un figlio del Ticino, il Ticino infine segnerà la sua vita terrena quale suicida nelle acque del fiume azzurro. Nei suoi tre principali romanzi Il Maestro, Il Calzolaio, Il Meridionale, nei titoli domina Vigevano, nelle pagine forte emerge il suo fiume.
Bello e gustoso il paragone tra Vigevano e Parigi come, nel Maestro di Vigevano, il giornalista Pallavicino “la stava menando” mentre il campanone della torre suonava la mezzanotte:” Io vi dico che Vigevano vale duecento Parigi. Cosa c’è a Parigi che non vi sia a Vigevano? A Parigi c’è Pias Pigal; a Vigevano ioma Pias Ducal; a Parigi c’è la Senna; a Vigevano c’è il Tisin; a Parigi c’è la tur Eifel, num ioma la tur Bramant.” E così sempre nel Maestro il protagonista, il maestro Mombelli, nel suo solitario camminare e “nei miei pensieri” “Scendo per una discesa rapidissima e mi trovo nella vallata del Ticino” ed ecco la Centrale Edison che ritroveremo nuovamente nelle pagine del Calzolaio “ .” ..Annibale sconfisse i Romani dove ora c’è la Centrale Edison, sul Ticino, che pur essendo vicina a Milano, Vigevano, geograficamente parlando, è in Piemonte, al di qua del Ticino”.
Nel Maestro dopo la vista della Centrale Edison il protagonista prosegue nel suo cammino. “Sono seduto ora su di un ponticello. E’ un ponticello d’irrigazione che posa su due fiancate; messo per traverso. Sotto ci passa la trincea ferroviaria. Sono in alto; il mio sguardo abbraccia tutta la vallata del Ticino: fiume, boschi, ponte.” Più avanti nel racconto del Maestro “ Sono tornato sul ponticello…Dal Ticino venne un rombo di barche che rompeva quel’armonia. Infine nel Meridionale di Vigevano ecco nuovamente la vallata:” Ci affacciammo sulla terrazza. Si vedeva un pezzo della vallata del Ticino qualche arcata del ponte; le boscaglie; un tratto della Nuova Circonvallazione”.
Il Ticino e Lucio Mastronardi (parte
seconda) Ancora qualche riferimento al fiume Ticino, dopo i primi, presente nei tre più noti romanzi di Lucio Mastronardi: Il Ticino dove lo scrittore vive, sogna, spera, soffre, muore suicida; Il Ticino dove Antonio il maestro, Mario il calzolaio, Camillo il meridionale, vivono, sperano, sognano, soffrono ma ancor oggi vivono figure nitide e presenti nelle pagine di Mastronardi. Ecco Mario che ritorna ai suoi anni giovanili e ricorda:” Andiamo a Ticino in camporella nei boschi.Tornare giovani. Gli venne in mente una scappata che aveva fatto da ragazzo., l’unica, con una morosetta, proprio nelle boscaglie del Ticino.” Quel dialogo pieno di speranze e incertezze tra Netto il fratello di Menchina, e Luisa, la moglie di Mario, dopo il richiamo di questi alle armi ed i dissapori ed i continui screzi con il socio Pellegatta:” Piare un po’ di terra in Santa Giuliana, sul stradone per Novara- diceva il Netto” – Costruire adesso coi bombardamenti, che sfanno giù tuttecose!” “-Ma sono tanti che costruiscono. Basta costruire nò verso Ticino. Loro hanno di mira il ponte, mica i nostri fabbrichini.”
La favola, il sogno, l’incubo sui tradimenti di Ada la moglie di Antonio:” Fisso la casa e mi accorgo che è una casotta del Ticino…” “ …..l’industrialotto guida sempre più forte: centottanta, duecento, duecentoventi, finché arriviamo sul ponte del Ticino, ma il ponte è senza parapetto. La macchina corre sull’orlo del ponte, in bilico, finché con un urlo mi sveglio, bagnato, come fossi caduto davvero nel fiume.” E le belle e intense riflessioni dello stesso Antonio:” Ogni epoca ha i suoi sensi di vita. L’uomo ha costruito questa trincea, questa ferrovia, questo ponte di irrigazione, quel ponte sul Ticino, quella torre che intravedo…” “ So che prima era ancora chiaro, ora è buio. La luna è grandissima, si riflette nell’acqua del Ticino; so che prima gli alberi erano silenziosi, ora la natura canta; e sono grilli e sono civette e sono amorici che cantano.” Quella affannosa ricerca della donna scomparsa dalla casa in cui era ospite Camillo:” Poco dopo scendevamo la vallata del Ticino.Una luna forte schiariva la campagna. Arrivammo al fiume in silenzio.” “..Il fiume era una massa scura e lucida.” E poi quel girovagare notturno sempre di Camillo:” Arrivai ad un bivio. Da una parte lo stradale proseguiva per il ponte del Ticino; dall’altra, cominciava una strada di periferia.” “ Sullo sfondo c’è nebbia: sale dalla vallata del Ticino” Quel dialogo tutto particolare tra l’industrialotto e Camillo” –Dottore è libero incò? –Perché?- Per portavi a Ticino.Voglio farvi provare un motoscafo!” Da Ticino Notizie
Ada Negri e Antonia Pozzi: Poetesse del Ticino Ada Negri (Lodi 1870- Milano 1945) e Antonia Pozzi (Milano 1912-Milano 1938) le Poetesse del fiume Ticino: ne videro entrambe le azzurre acque, ne respirarono l’aria, ne odorarono i profumi del boschi e dei sottoboschi, trassero godimenti del canto degli uccelli e di quelle vite che ne popolavano le rive. Antonia, figlia dell’avvocato Roberto Pozzi, originario di Laveno, e della contessa Lina, a sua volta figlia del conte Antonio Cavagna Sangiuliani di Gualdana e di Maria Gramignola, proprietari di una vasta tenuta terriera, detta La Zelata, a, Bereguardo, volgendo lo sguardo da questo luogo giù verso il fiume, Ada, sia agli esordi della sua attività di insegnante elementare, dall’alto della costa che attraverso una ripida discesa ne portava alla sue rive sia durante periodi di soggiorno in quel di Pavia. Cosi ricorda nei suoi scritti Monsignor Cesare Angelini, a partire dal primo incontro nel 1927,:” Sul filo dell’amicizia con una gentildonna pavese — Luisa Boerchio — un giorno Ada Negri venne tra noi a Pavia col suo dono poetico. E da non so quanti anni, al giungere dell’autunno, quando sulla nostra terra i giorni si fanno più nudi e l’umido e le nebbie fanno cercare un angolo accogliente, ella lasciava Milano e tornava nel tiepido nido che l’amicizia le preparava. Vi si fermava due mesi, tre mesi, cinque mesi. Magari s’annunciava a qualcuno: «La settimana prossima lascerò il mio solaio di Viale dei Mille e Bianca e Donata [la figlia e la nipote, ndr], e verrò a Pavia. Vivere nella vostra città è un premio che mi voglio concedere anche quest’anno. Pavia mi chiama. Le strade, le torri, il ponte...». Pavia le piaceva e la sua natura rustica e preziosa, il suo silenzio così idoneo alla meditazione dei poeti. Vi trovava tranquillità, raccoglimento, riposo dell’anima e del corpo, e ispirazione. Anime belle e buone dalla vita sentimentale travagliata: Antonia morirà suicida in giovane età per l’amore contrastato studentessa nel liceo classico Manzoni di Milano intreccia con il suo professore di latino e greco Antonio Maria Cervi, una relazione che verrà interrotta nel 1933 a causa di forti ingerenze da parte dei suoi genitori, il padre in particolare, e da qui poi più tardi seguirà quel fatale gesto; Ada, segnata da quell’intenso e forte amore giovanile con Ettore Patrizi, un amore pieno, intenso, appassionato, una lunga corrispondenza epistolare, che dopo la partenza del Patrizi per l’America, nel 1893 terminerà nel 1896 con l’ultima lettera e che sancirà la fine di questo rapporto d’amore, sarà infine “vittima” di uno sbrigativo e presto fallimentare matrimonio con Giovanni Garlanda,industriale tessile di Biella, dal quale ebbe la figlia Bianca, ispiratrice di molte poesie, e un'altra bambina, Vittoria, che morì a un mese di vita. Rimandando il lettore esigente alla loro estesa biografia e alle loro complete fatiche letterario ci limiteremo nel riportare in questa breve pagina “frammenti” della loro prosa o versi dal dolce e sapore romantico per questo “loro” fiume qui riportiamo solo brevi notizie. Antonia Pozzi compie studi classici presso il
Liceo Manzoni, ha una cospicua preparazione musicale, segue lezioni
private di disegno e scultura; a partire dalla fine degli anni Venti
si dedica alla fotografia e a molti sport: scia, nuota, cavalca,
pratica tennis e alpinismo; la circonda una colta cerchia di amici fra
i quali Paolo e Piero Treves. Ada Negri una tra le più affascinanti poetesse della letteratura italiana rappresentò, nel vasto panorama letterario una donna che visse liberamente, componendo versi e rime straordinari. Sin dalla pubblicazione di “Fatalità”, nel 1892, prima raccolta di liriche, la maestrina di Motta Visconti ebbe un successo di pubblico straordinario per quei tempi. Si parlava con entusiasmo della “vergine rossa”, dei suoi temi che erano pienamente inseriti nel contesto storico-culturale di fine ottocento. Libertà, uguaglianza, giustizia sociale erano gli argomenti trattati dalla Negri che, coi suoi versi, risvegliava le coscienze invitandole alla ribellione verso i soprusi e le sofferenze delle masse. Poetessa oggi dimenticata, merita di riportare quanto scrive Giacomo Properzj:” Due giorni dopo al suo funerale c'era pochissima gente: qualche autorità della Repubblica Sociale a cui lei aveva aderito, i parenti e pochi altri. Eppure si trattava di una Accademica d'Italia, la prima e l'unica donna che fece parte di questo altissimo consesso culturale. Tutti possono ancora vedere il suo volto serio e smunto in mezzo a Guglielmo Marconi e a Giovanni Gentile nelle fotografie dell'epoca.. La Poetessa, che era stata per tanti anni sugli altari della letteratura, cominciava ad essere dimenticata. La sua adesione al Fascismo, che ne aveva favorito il successo, ora diventava una colpa, i suoi libri non sarebbero più stati pubblicati, nelle scuole per molti anni non si sarebbe parlato di lei così come nel mondo della cultura secondo lo stile fazioso che ha sempre accompagnato la nostra storia: Ada aveva avuto un rapido anzi rapidissimo successo perché a 25 anni era già la più nota poetessa italiana. Successo determinato dalle sue prese di posizione in politica, molto cariche di impegno sociale e di polemica contro lo stato borghese e, in generale, contro i ricchi. Da Motta mandò al Corriere della sera la poesia “Gelosia”, aveva già pubblicato qualcosa sul Fanfulla da Lodi; il direttore Barbiera del supplemento letterario Illustrazione Popolare la pubblica con un lusinghiero giudizio. Un anno dopo la scrittrice e letterata Sofia Bisi Albini viene a Motta per conoscerla e da quel momento partono una serie di giudizi positivi sulle maggiori riviste letterarie italiane. Nel '94 il giovane anarchico Sante Caserio di Motta Visconti uccide il presidente della repubblica francese Carnot. Si attiva immediatamente una polemica dei giornali clericali contro la Negri, accusandola di aver influenzato in senso sovversivo Motta Visconti e il giovane Caserio. Il Secolo e il Corriere della Sera la difendono, Caserio nato nel '73 non era mai stato suo allievo, ma tutta questa polemica non fa altro che aumentare la fama della giovine “Vergine Rossa”, che incomincia ad essere tradotta anche all'estero. Dopo la separazione dal Garlanda si trasferisce in volontario esilio a Zurigo al seguito della figlia Bianca. Alla fine della Prima Guerra Mondiale ritorna in Italia e riprende i contatti, che non aveva mai interrotto con le amiche“sovversive”: Anna Kuliscioff - che avrà su di lei una grande influenza, positiva nel senso letterale della parola, perché la dottoressa russa era notoriamente positivista. Riprende contatto anche con Margherita Sarfatti, molto autorevole nel mondo culturale milanese che gli presenterà, vedi un po', Benito Mussolini. Questi, all'uscita del libro Stella Mattutina che è l'autobiografia giovanile della Negri con tutti i suoi risvolti di frustazioni sociali, scrive una lunga recensione entusiastica sul Popolo d'Italia il 9 luglio del 1921. Poco prima o poco dopo - secondo la testimonianza da me raccolta dalla maestra Cecilia Monguzzi - Ada Negri viene a Motta. Ci ritornava spesso, accompagnando Mussolini: una riunione in una delle molte osterie del Paese con un piccolo gruppo che gli resterà fedele fino alla fine. Bene ha fatto l'Amministrazione di Motta Visconti ad organizzare per il 25 settembre una rievocazione della “Maestrina di Motta Visconti”, con letture di alcuni suoi testi e accompagnamento di romanze dell'epoca. Bene ha fatto questa Amministrazione, perché la quasi dimenticata poetessa, sovversiva, socialista rivoluzionaria, fascista, repubblichina, scapigliata, impressionista, forse lesbica certamente disperata è stata la più grande poetessa italiana del '900 alla faccia del politicamente corretto.” Ed ecco frammenti di come le due Poetesse parlarono o cantarono del fiume Ticino: ”Così annotava nel 1938 Antonia sul suo Diario poco prima della morte : “Ieri, sull’argine del Ticino, dove il fiume fa un’enorme ansa e la corrente si attorce in gorghi azzurrissimi, e ha subbugli, scrosci, rigurgiti improvvisi e minacciosi, sono rimasta per un’ora sulla riva in faccia al sole che tramontava, a chiacchierare con un guardiacaccia che fu al servizio del mio nonno e si ricorda della mia mamma e delle mie zie bambine. Ebbene: era un senso strano pensare che tutta questa smisurata terra, i campi coltivati da Motta a Bereguardo, e i boschi della riva, dal lido di Motta fin giù al ponte di barche, con i diritti di pesca, di caccia, di cava d’oro persino, erano proprietà unica dei miei antenati. Io non so che cosa pagherei per potermi costruire qui, in vista del Ticino, due stanze rustiche e venirci a stare; le mie radici aristocratiche non le sento molto, nemmeno qui, ma le mie radici terriere sì, in modo acuto e profondo, e gli uomini dietro l’aratro mi incantano, non solo per un senso di armonia estetica” Anni prima ( Milano, 24 Aprile 1929) così metteva in versi: “Ricordo che, quand’ero nella casa
Durante il suo soggiorno a Pavia così scriveva Ada in “Gente di Fiume”: “ Le lavandaie di Borgo Basso hanno tutte ugual foggia di vestire: sottana scura di rigatino, con la parte superiore rialzata e tenuta gonfia sui fianchi dal nastro del grembiale: alti zoccoli, fazzoletto bianco pendente dalle cocche ai lati del viso, e, sul fazzoletto, un largo cappello di paglia gialla. La faccia, le braccia, le mani, lavorate ben ben dal vento, dal sole dagli strapazzi: le voci, rauche: il colore della pelle un di mezzo fra il rame e la terracotta. Le loro figlie sembrano d’un’altra razza: snelle e graziose, portano calze fini, scarpette scollate, tuniche corte senza maniche e lavorano nelle fabbriche. Abitano nelle rustiche ma ridenti casucce del borgo, sulla riva destra a specchio del Ticino: fette di case, dipinte a capriccio, con una porticina, una stanza a terreno, due di sopra, un balcone e una finestra. Nei cortili aperti sulla riva, rampe esterne di scale, pergolati di glicine e vite vergine, rozze insegne d’osteria con frasche: giochi di bocce, stracci stesi ad asciugare, cataste di legna raccolta a spizzico nei boschi, monelli che ricorrono gatti e galline, vecchi che sulle soglie si godono il sole. La riva è occupata da panchette, su alti e solidi trampoli: nei tre giorni regolamentari della settimana le lavandaie vi stanno inginocchiate, dorso e spalle curvi sull’acqua; e insaponano immergono torcono strizzano panni, battendoli anche, a tutto spiano con una mazzuola. Nelle prime ore del mattino, i reiterati colpi s’odono da lontano, attraverso le nebbie che salgono dal fiume; e fanno malinconia. “ E ancora durante uno dei suoi soggiorni a Pavia così mette in nota: “Dalle mie scorribande per calli e callette,chiese e chiesette, piazze e chiassuoli non vorrei mai ritornare, non avvertendo neppur la stanchezza fisica, per il giubilo delle scoperte: se non fosse per ritrovare la postierla della casa ospitale, gli stanzoni di largo fiato, dove il riposo è veramente riposo del corpo e dell’anima. Spesso, qui, mi viene incontro qualcosa di me,qualcuno ch’era me, e che credevo di aver dimenticato. Quei boschi del Ticino, che oltre e campi e gli orti scorgo dal balcone della mia camera al limite dell’orizzonte, chiamano di frequente il mio sguardo. Non riesco a vedere il fiume. Ma mi sorprendo a navigare lungo la limpida corrente, come nel tempo in cui ero, laggiù, maestrina in un villaggio di battellieri. A un punto perduto del fiume, un guado: una spiaggetta ghiaiosa, e foreste percorse dal brivido delle acque divise in rami di canaletti: le foreste di Motta Visconti. Nome che mi porta alle narici odor di pane caldo, appena tolto dal forno nelle prime ore dell’alba: odore di giovinezza. Così poi canterà in “Ritorno a Motta Visconti”: “Ella dintorno si guardò, tremando, …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… Fonti di riferimento 1) Ada Negri-Wikipedia 2) Antonia Pozzi-Wikipedia 3) Giacomo Properzj, “ Perché non si deve dimenticare Ada Negri, la maestrina di Motta Visconti”- da Internet 4) Cesare Angelini, 1. Antonia Pozzi. Poesia che mi guardi | Doppiozero 1. Antonia Pozzi: vita d`amore e di poesia - Rai Letteratura Antonia Pozzi | enciclopedia delle donne Antonia Pozzi un suicidio annunciato - la Repubblica.it Antonia Pozzi, la poetessa che amiamo male | Tropismi
Difficile dire quanti siano i riferimenti e le citazioni negli scritti letterari e nella corrispondenza epistolare con gli amici di Cesare Angelini, sacerdote, poeta, critico, letterato, al fiume Ticino. La presente è solo una nota esplorativa con le prime e immediate spigolature. Parlando di Pavia scrisse:” A Pavia, la luce trova il suo condensatore o cassa di risonanza nella presenza del fiume. Privilegio delle città che nascono e crescono lungo le acque è quello di rispondere al richiamo della luce; e il Ticino, che è il primo ad accendersi e l’ultimo a spegnersi, si beve da millenni tutte le nostre aurore e i nostri tramonti. Un giorno, se mi prenderà l’estro, vorrò farci su qualche componimento poetico.” Non risulta che poi lo abbia fatto a differenza di quella bella pagina dal sapore decisamente poetico scritta sull’Adda in uno dei tanti suoi magistrali commenti ai Promessi Sposi dell’amato Manzoni. Sul Ticino allora sono i suoi riferimenti asettici e “anonimi” ? Per nulla come vedremo anche se alcuno, non si sa perché, è giunto a dire che Monsignor Angelini non amasse il Ticino. Dubbi in tal senso parrebbero sorgere ad una lettura frettolosa della lettera scritta il 12 gennaio 1923 a Giuseppe Prezzolini:” Non ha voglia, Signor Prezzolini di spingersi sino a Pavia? Con alcune dolci lentezze provinciali, l’aspettano basiliche stupende con gallerie che salgono ad archetti interzati come le rime di Dante verso Il Paradiso. E ci sarebbe il caso, entrando da Porta Santa Giustina, di imbattersi in Petrarca, ospite dei Visconti e un poco invecchiato, caracolla s’un cavallo candido più che neve per consolarsi di Laura salita da un poco in Paradiso. E poi c’è il Ticino…tutto un compasso insomma.” Di fatto il Ticino è lasciato per ultimo come una appendice ma non è cosi: qui prevale lo spirito del critico letterario tenuto conto del dotto interlocutore. Ticino che sarà però reso vivido negli anni della tarda età in quella intervista impossibile:”La confidenza dei pavesi col fiume è raccontata dai cronisti di ogni tempo, cui s’aggiungono le testimonianze dei pittori. Insomma, una città di barcaioli e pescatori, mentre sull’altra riva del Ticino le lavandaie del Borgo, sbattendo alle-gramente camicie e lenzuola, aiutavano il folclore” .
Difficile dire quanti siano i riferimenti e le citazioni negli scritti letterari e nella corrispondenza epistolare con gli amici di Cesare Angelini, sacerdote, poeta, critico, letterato, al fiume Ticino. La presente è solo una nota esplorativa con le prime e immediate spigolature. Parlando di Pavia scrisse:” A Pavia, la luce trova il suo condensatore o cassa di risonanza nella presenza del fiume. Privilegio delle città che nascono e crescono lungo le acque è quello di rispondere al richiamo della luce; e il Ticino, che è il primo ad accendersi e l’ultimo a spegnersi, si beve da millenni tutte le nostre aurore e i nostri tramonti. Un giorno, se mi prenderà l’estro, vorrò farci su qualche componimento poetico.” Non risulta che poi lo abbia fatto a differenza di quella bella pagina dal sapore decisamente poetico scritta sull’Adda in uno dei tanti suoi magistrali commenti ai Promessi Sposi dell’amato Manzoni. Sul Ticino allora sono i suoi riferimenti asettici e “anonimi” ? Per nulla come vedremo anche se alcuno, non si sa perché, è giunto a dire che Monsignor Angelini non amasse il Ticino. Dubbi in tal senso parrebbero sorgere ad una lettura frettolosa della lettera scritta il 12 gennaio 1923 a Giuseppe Prezzolini:” Non ha voglia, Signor Prezzolini di spingersi sino a Pavia? Con alcune dolci lentezze provinciali, l’aspettano basiliche stupende con gallerie che salgono ad archetti interzati come le rime di Dante verso Il Paradiso. E ci sarebbe il caso, entrando da Porta Santa Giustina, di imbattersi in Petrarca, ospite dei Visconti e un poco invecchiato, caracolla s’un cavallo candido più che neve per consolarsi di Laura salita da un poco in Paradiso. E poi c’è il Ticino…tutto un compasso insomma.” Di fatto il Ticino è lasciato per ultimo come una appendice ma non è cosi: qui prevale lo spirito del critico letterario tenuto conto del dotto interlocutore. Ticino che sarà però reso vivido negli anni della tarda età in quella intervista impossibile:”La confidenza dei pavesi col fiume è raccontata dai cronisti di ogni tempo, cui s’aggiungono le testimonianze dei pittori. Insomma, una città di barcaioli e pescatori, mentre sull’altra riva del Ticino le lavandaie del Borgo, sbattendo alle-gramente camicie e lenzuola, aiutavano il folclore” . Ha voluto essere sepolto a Torre d’Isola paese a lui caro per i tanti ricordi ed affetti familiari e di cui scrisse a suo tempo come nacque (Dal giornale cattolico “Il Ticino” del 26 luglio 1969): “ La prima notizia di Torre d’Isola, che ce ne racconta la nascita e spiega il nome «fluviale», risale al Mille o giù di lì; quando la Lombardia era sotto il dominio di Re Ottone e della Regina Adelaide, che risiedevano in Pavia. Pare una favola tant’è bella. Dice che ogni notte, partendo dal ponte, solcava le acque del Ticino una barchetta guidata da un lume e, dopo alcuni chilometri, approdava a una piccola isola poco lontana dalla sponda. Vi calava una donna che si raccoglieva nel bosco, rimanendovi fin verso il mattino quando tutto spariva, il lume e la barca.”Ora, vuoi per caso o per amorevole destino, poiché Torre d’Isola si trova nel Pavese occidentale e si estende lungo la riva del Ticino piace immaginare che il fiume poco distante dal luogo dove riposa Don Cesare, con il suo continuo lento scorrer mormorio, voglia cullare il suo eterno sonno. Nel narrare dei giorni del Foscolo a Pavia il Ticino è nominato di fretta quasi distrattamente:” E al Ticino, al non ancora «varcato» Ticino, giunse da Milano, in legno, la sera del 1° dicembre, ch’era un giovedì…” E poi riferendosi sempre al Foscolo:” Intanto Pavia riempie le sue lettere, anche se guardata con un senso di disagio.
All’Arrivabene, il 21 ottobre dà notizia d’una rapida corsa che vi ha
fatto: «Sono andato a Pavia ad apparecchiarmi la prigione e ad
onorarla». Al Pindemonte: «Io andrò a Pavia all’apertura dell’anno
scolastico, non prima». Al Brunetti: «Non penso a Pavia senza vedere
nell’Università mille accusatori giusti contro di me, senza udire
mille maligni esagerati. Ma, caschi il cielo ad opprimermi, non verrà
dicembre senza ch’io non mi trovi a Pavia». Al Monti: «Io vo dì e
notte pensando come provvedere alla mia traslocazione in Pavia». Al
Giovio: «Al conte Giulio scriverò quel giorno ch’io moverò verso il
Ticino». E qui è invece il Foscolo a nominare con un certo senso di
disagio il Ticino.
Con nostalgia e pare anche con un certo senso di rimpianto per i tempi
passati riappare il nome del Ticino assieme a caratteristici
personaggi nel Diario del Novecento a cura di Luciano Simonelli:” Ma i
rimpianti di Cesare Angelini scompaiono al ricordo di alcuni
personaggi caratteristici della Pavia di un tempo e sta parlando di
loro quando arriviamo in piazza Borromeo:” C’era il professor
Balanzone. D’estate portava il cappotto come d’inverno e andava sempre
in giro a raccogliere giornali…poi il professor Peo che sul ponte del
Ticino vendeva i “brassadè”, dei dolci…”
In “Conoscere la provincia”-Panorama del Pavese il suo scrivere è un inno d’amore per Pavia e indirettamente per il suo fiume:” Poniamo, questa mia provincia, che sulla carta geografica della Lombardia presenta la forma stravagante d’un triangolo con la base in su e il pizzo in giù; con una capitale che non invecchia perché antica (antica capitale di regni) e un contado così prosperoso di vita e di opere tutte al vento e al sole, che ogni giorno qualcuno rinnova il gusto d’esserci nato contadino. Ma smorziamo ogni tentazione di lirismo, e parliamo con calma di questa provincia che, fatta di sindaci e parroci e d’un mezzo milione di anime, è naturalmente quella di Pavia. calma di questa provincia che, fatta di sindaci e parroci e d’un mezzo milione di anime, è naturalmente quella di Pavia La quale, come la Gallia di Cesare, divisa est in partes tres. Quarum unam…, anzi due — il Pavese propriamente detto e la Lomellina — sono le parti soprane del triangolo; la terza o parte sottana, è l’Oltrepò. Maravigliosa provincia che, al nord, scappa verso i fiumi — il Ticino e il Po — con la sua pianura di praterie, di boschi, di marcite, di risaie e rogge e nebbie basse; e, al sud, sale coi festanti filari dei suoi vigneti verso i dorsi dell’Appennino.. Al capoluogo, Pavia, basti aver accennato. Descriverlo, il discorso sarebbe trattenuto nella soggezione delle Guide vecchie e nuove, a cui ben poco c’è da aggiungere, o nulla; fuorché l’ammirazione per la città regale che intreccia il superbo capriccio delle sue torri medievali alla sapienza delle basiliche e alla maestà bonaria del suo fiume nel momento più bello. E par sempre una memoria poetica la notizia che il paese di Bereguardo sul Ticino ospitò nel suo castello un pittorone come Filippo Brunelleschi, chiamatovi da Firenze per certi restauri.” Anche nella “Lombardia di Carlo Cattaneo” dove “… assistiamo alla nascita di questa nostra terra che, collocandosi tra il Piemonte e la Venezia sorte per opera d’altre eruzioni, entra, sotto il sublime arco delle Alpi, nel panorama settentrionale, «quasi adempiendo un disegno unitario della natura». Così, tra il Verbano e il Ticino da una parte, il Benaco e il Mincio dall’altra, corsa da giovani fiumi e dal poderoso Po che la lega all’Adriatico, sparsa di laghi che ne specchiano la bellezza, ricca di mirabili attitudini d’aria e di cielo, la Lombardia, che ancora non si chiamava così, preparava il destino agricolo del popolo che doveva abitarla. «Poiché in ogni parte del globo giacciono predisposti gli elementi di qualche grande compagine che attende solo il soffio dell’intelligenza nazionale” il Ticino “ giovane fiume” da il suo contributo gioioso alla nascita di “questa nostra terra”! Chiudiamo questa nota riportando quando scrive nel suo “Andar per chiese” :” Visita San Lanfranco. È la basìlica più visitata dai forestieri, anche per il posto poetico dove sorge: sul Ticino, fra campi e alberi e balli campestri…..La facciata, come la massiccia torre quadrata che le sorge a fianco, è del secolo XIII e, divisa in tre campate verticali, è sparsa di tazze o scodelle iridate che riflettono il sole quando tramonta nei boschi del fiume. Ma tutta la facciata ha indelebilmente
sopra di sé i colori bruciati dei tramonti” Non
si respira forse in queste poche righe aria di poesia? Da Ticino Notizie
Le marcite Negli anni cinquanta percorrendo in bicicletta la ex-Strada Provinciale dell’est-Ticino da Bereguardo fino ad Abbiategrasso si notavano , anche in pieno inverno, qua e là verdi prati verdi lussureggianti: le marcite! Come noto e come ben recita Wikipedia alla voce marcita: “La marcita è una tecnica colturale caratteristica della pianura padana impiantata per la prima volta nelle grange che erano grandi aziende agricole di proprietà delle abbazie; essa consiste nell’utilizzo dell’irrigazione a gravità effettuata utilizzando l’acqua proveniente dalle risorgive anche nella stagione invernale. Nella stagione estiva i prati vengono irrigati periodicamente, mentre in quella invernale sono irrigati in modo continuato. L’acqua di risorgiva, che generalmente sgorga per tutto l’anno ad una temperatura costante compresa fra i 9 °C (in inverno) e i 14 °C (in estate), viene mantenuta in continuo movimento dalla conformazione dolcemente declinante del terreno, impedendo in questo modo che il suolo ghiacci; lo sviluppo della vegetazione prosegue così anche durante l’inverno rendendo possibile effettuare annualmente almeno sette tagli di foraggio (ma spesso anche nove), contro i 4-5 ottenuti dalla coltivazione del migliore prato stabile. Non è noto chi abbia inventato la tecnica della marcita; tuttavia si attribuisce comunemente ai monaci provenienti dalla Francia, in particolare Cistercensi il merito di aver contribuito grandemente alla sua diffusione nelle campagne del nord Italia. In particolare per quanto riguarda i territori rivieraschi del fiume Ticino le marcite furono introdotte in Pianura Padana intorno all’anno mille per merito delle popolazioni contadine lombarde e piemontesi. Infatti in quegli anni i monaci che abitavano le Abbazie e ricavavano dalle terre circostanti il loro sostentamento, affinarono queste pratiche agricole preesistenti, praticandole loro stessi, descrivendo la marcita nei loro testi e contribuendo in maniera decisiva alla loro diffusione. In particolare qui nella nostra zona il centro dal quale si diffuse poi rapidamente tale tecnica si deve identificare con l’Abbazia di Morimondo in provincia di Milano: territorio posto sulla riva sinistra del Ticino, con orografia dolcemente digradante verso il fiume interrotta sporadicamente da collinette, depressioni e arginature. Il territorio comunale è vasto e prevalentemente destinato ad uso agricolo. Ancora oggi La vegetazione comprende, a partire dalle sponde del fiume, salici, robinie e pioppi,questi ultimi coltivati per la produzione di carta. Si possono osservare diversi boschi con pioppi dal fusto diritto disposti in regolari file parallele.
Dal punto di vista storico merita di ricordare come all’inizio dell’ottocento in quel di Besate comune rivierasco del Ticino e poco distante da Morimondo, dopo le piene del Ticino del 1814 e del 1824 che avevano rovinato molte delle colture besatesi e distrutto completamente le cascine Ghisalba e Ghisalbetta, il duca Carlo Visconti di Modrone escogitò un sistema per sbarrare la forza d’urto delle acque del fiume, riducendo la costa e inclinandola verso la corrente, convertendo quei terreni che erano di sua proprietà a marcite. Difficile impossibile oggi rivedere quei verdi prati invernali! Infatti oggi il significato agronomico della marcita e dell’erba ivi prodotta come alimento del bestiame bovino è scomparso, perché sono cambiati i sistemi di alimentazione e quindi non c’è più interesse da parte degli agricoltori a mantenere le marcite, pratica colturale oltremodo faticosa da attuare, non potendo impiegare completamente i mezzi meccanici, dato il particolare assetto a “valli e dossi” tipico dei campi dedicati a questo tipo di coltivazione.
Infatti oggi il significato agronomico della marcita e dell’erba ivi prodotta come alimento del bestiame bovino è scomparso, perché sono cambiati i sistemi di alimentazione e quindi non c’è più interesse da parte degli agricoltori a mantenere le marcite, pratica colturale oltremodo faticosa da attuare, non potendo impiegare completamente i mezzi meccanici, dato il particolare assetto a “valli e dossi” tipico dei campi dedicati a questo tipo di coltivazione.
Tuttavia data l’importanza
per il loro valore storico-tradizionale, paesaggistico e faunistico,
recentemente in alcune zone a noi vicine è stata messa in atto una
risistemazione di fontanili e rogge in modo da continuare la pratica delle
marcite.
In particolare quelle che ancora oggi sopravvivono sono situate nel Parco
del Ticino e nel Parco Agricolo Sud Milano con due gruppi consistenti
(circa 500 ha). Infatti il Parco del Ticino negli anni 90,
anche grazie ai riferimenti normativi già citati del P.T.C., decise di
intraprendere un percorso di collaborazione con gli agricoltori più attenti
e sensibili, finalizzato alla salvaguardia di oltre 300 ettari di marcite.
Con il 2015 sono quasi trenta anni che il Parco assegna agli agricoltori un
contributo economico per il mantenimento o il recupero delle marcite e
pertanto sono quasi trenta anni che nel Parco sopravvivono ambienti unici in
Pianura Padana, patrimonio di queste regioni e di queste popolazioni,
testimonianza di un mondo agricolo capace di tramandare fino ad oggi un bene
dalle radici antiche, ma dal valore attuale inestimabile. Da Ticino Notizie | ||||||