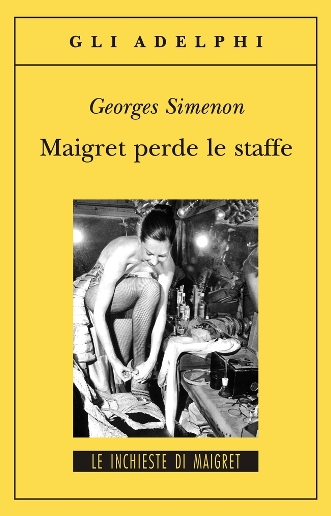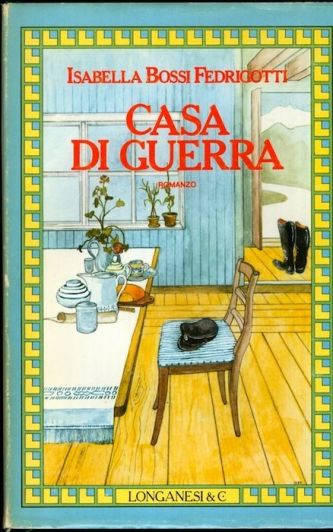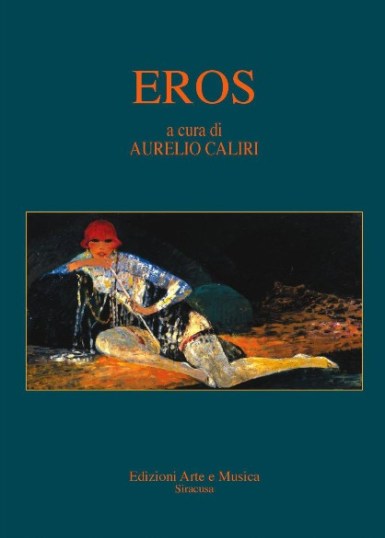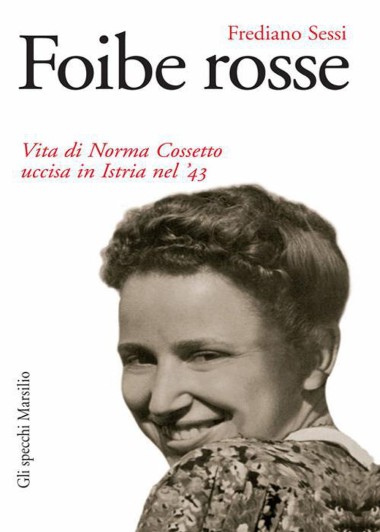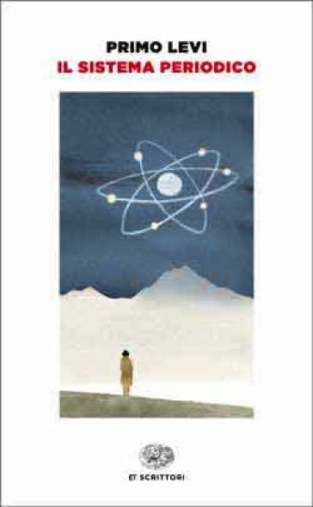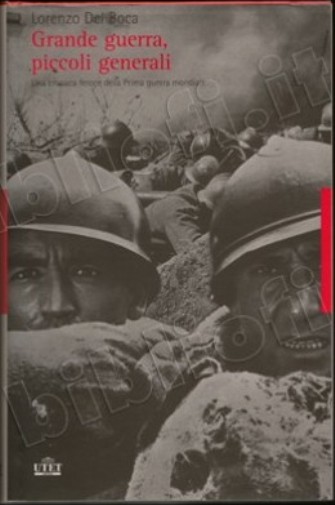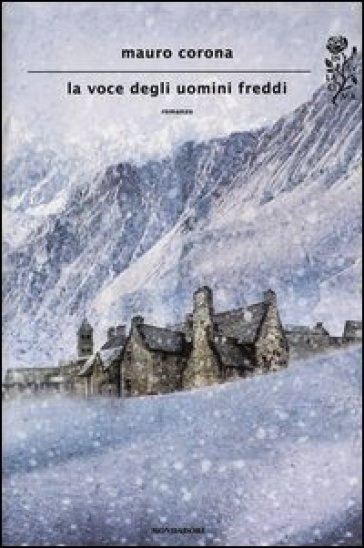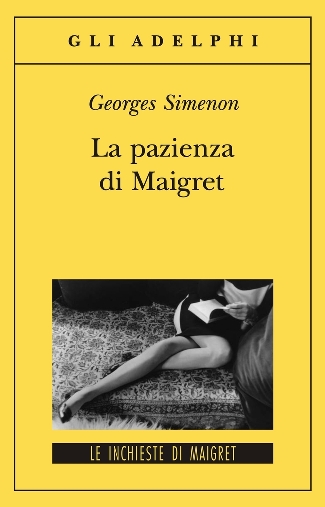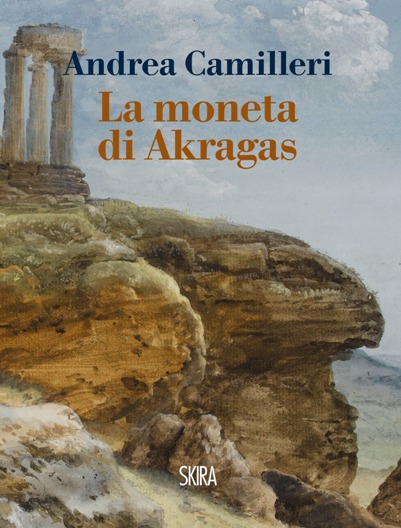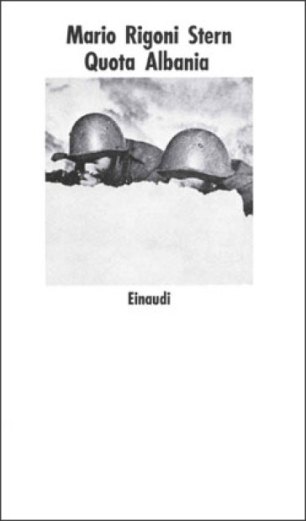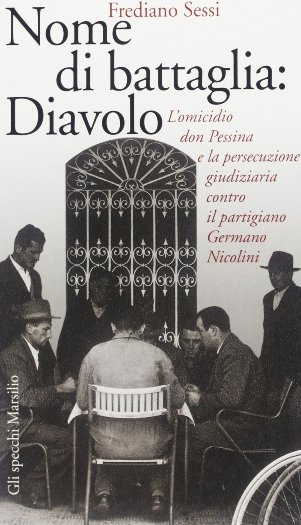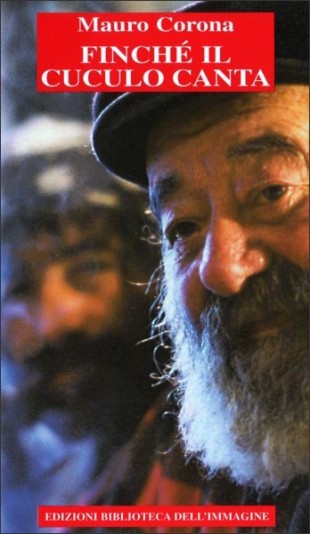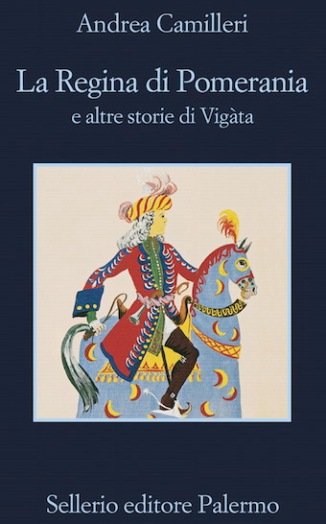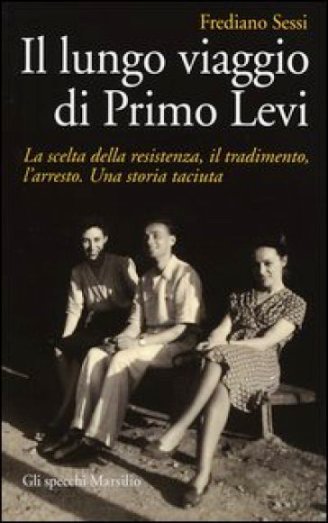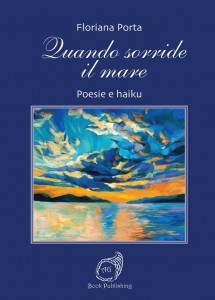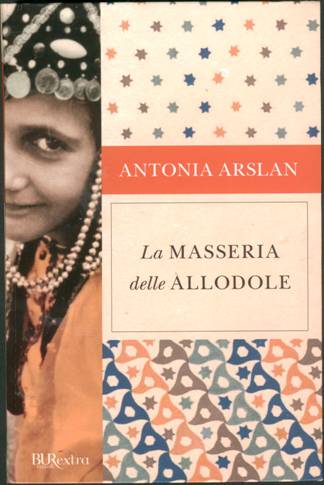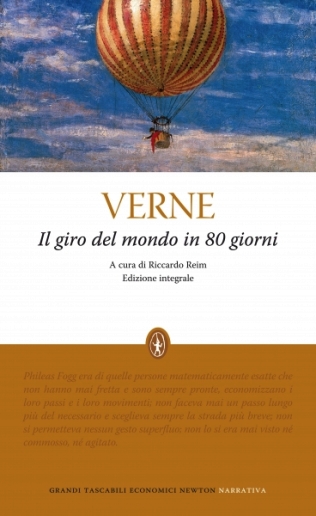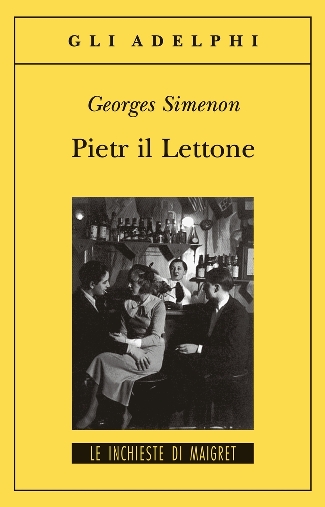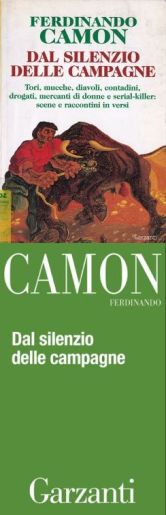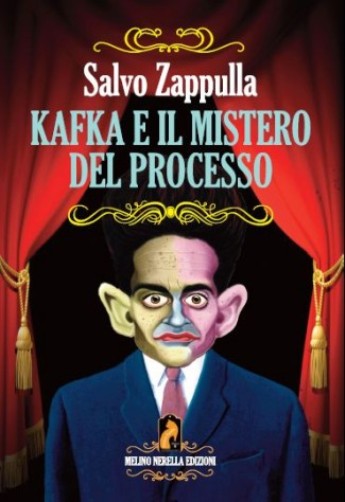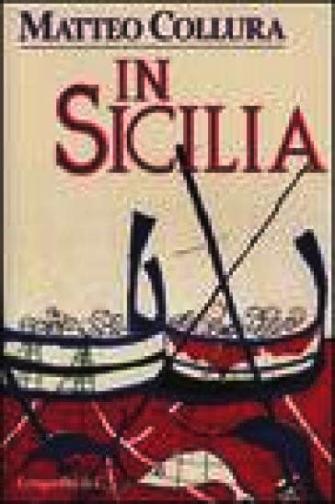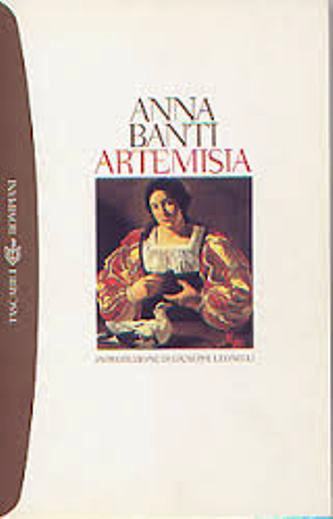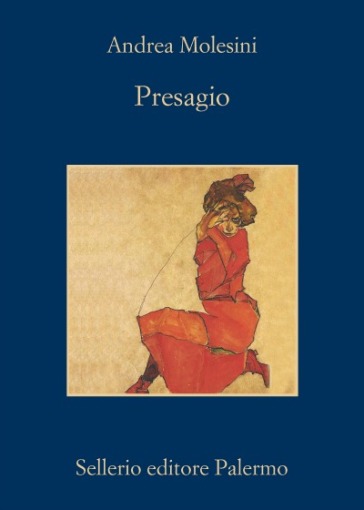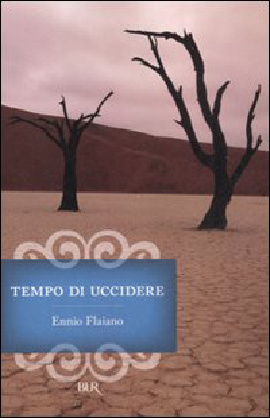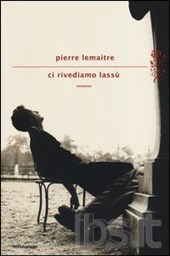2014
![]()
| Poetare | Poesie | Licenze | Fucina | Strumenti | Metrica | Figure retoriche | Guida | Lettura | Creazione | Autori | Biografie | Poeti del sito |
Commenti Poesie consigliate La Giostra della satira Concorsi La Sorgente delle poesie
|
Questa pagina raccoglie le recensioni di romanzi, libri di racconti, volumi di poesia e di altro genere letterario (libri di saggi, viaggi, teatro, ecc.), film. |
Recensioni 2012
Recensioni 2013
|
30/9/2014
La collina del vento di Carmine Abate Arnoldo Mondadori Editore S.p.A.
Narrativa romanzo
Un romanzo solo di discreta qualità Levocativa foto della copertina, il risvolto della stessa che anticipa i tratti del romanzo, evidenziando una grandiosa saga familiare dagli inizi del 900 fino a quasi ai giorni nostri, il Campiello ottenuto nel 2012 sono stati tutti elementi che mi hanno invogliato a leggere questo libro, pregustando, mentre ne terminavo un altro, quello che pensavo avrei trovato in La collina del vento. E così ho letto, appassionandomi allinizio a questa storia di contadini che non solo lottano per trarre dal terreno dissodato il necessario per vivere, ma anche, a loro modo, combattono per difendere una dignità che discende dallamore per la natura, per quellequilibrio perfetto delle cose che la cupidigia di alcuni uomini cerca di distruggere. La collina del Rossarco, tanto faticosamente acquistata e poi difesa, assume i simboli del mito e per la famiglia Arcuri non è solo la proprietà, ma la madre, al contempo fonte di reddito, riparo sicuro e segno tangibile della perfezione del Creato. Tutti questi elementi, come nella ricetta di un cuoco, se perfettamente amalgamati non potrebbero che sortire un risultato di grande qualità, unopera non solo piacevole da leggere, ma che lascia un segno profondo. Purtroppo, però, non bastano solo le buone idee, perché occorre la capacità di concretizzarle, facendolo nel miglior modo possibile. Abate, come scrittore, non è uno sprovveduto, ha buone capacità, forse anche eccellenti, ma in questo La collina del vento secondo me non è riuscito a proporsi al meglio. Mi dispiace dirlo, ma o lautore ha sprecato una grossa occasione, oppure non è riuscito a fare di più. Può però anche darsi che unipotesi non escluda laltra, perché di materiale interessante ne aveva tanto a disposizione, ma non è riuscito a sfruttarlo nel migliore dei modi. Per esempio il rapporto mistico fra luomo e la natura, fra gli Arcuri e questa collina sul cui terreno si spezzano la schiena è appena accennato, mentre invece ricorre ogni tanto, e la soluzione ci sarà solo alla fine, un aspetto giallo di cui francamente si sarebbe potuto fare a meno. La vicenda cè tutta, ma tre tragedie collettive come la prima e la seconda guerra mondiale e il ventennio fascista sembrano del tutto casuali, tanto poco Abate se ne è avvalso nella narrazione. Per quanto concerne questa, se lo stile è sobrio, con ogni tanto qualche inciso quasi poetico, presenta però un andamento lento e una logica di sequenze che a un lettore attento lasciano presupporre in anticipo quello che poi accadrà. Ai personaggi, pur di notevole interesse, è poi dedicata una descrizione sommaria, senza una precisa e attenta indagine psicologica, del resto non necessaria visto che sono o solo buoni o solo cattivi, circostanze che non si verificano mai nella realtà. In più di unoccasione ho avuto limpressione di trovarmi davanti alla sceneggiatura di una telenovela, il che mi ha anche un po infastidito, visto che la rara spontaneità è stata sovente accompagnata da una marcata artificiosità, tipica di quella letteratura prettamente devasione volta ad accattivarsi solo il pubblico e non anche a incantarlo con qualche cosa di nuovo, con approfondimenti sul senso della vita, sulle relazioni interpersonali o con altri elementi realmente costruttivi che sono indispensabili per poter arrivare a unopera di vera eccellenza. La collina del vento si lascia certamente leggere, ma, nonostante lambito premio ottenuto, è solo un romanzo discreto, incapace di lasciare una traccia significativa e indelebile.
Carmine Abate è
nato nel 1954 a Carfizzi, un paese arbëresh della Calabria, e vive in
Trentino.
28/9/2014
L'occhio rapace di Andrea Molesini
Libreria Editrice Cafoscarina
Saggistica letteraria Fra recensioni e saggi Andrea Molesini, scrittore, poeta, traduttore, saggista, nonché anche docente di Letterature comparate presso lUniversità di Padova, noto per i suoi romanzi Non tutti i bastardi sono di Vienna, La primavera del lupo e Presagio, ha raccolto in questo corposo volume di 484 pagine numerose sue recensioni, che ne costituiscono la prima parte chiamata Letture, e alcuni dei suoi saggi, che occupano la seconda e ultima parte, denominata Interventi. Considerata la corposità dellopera, sarebbe arduo parlare di tutto e di conseguenza mi limiterò solo a un paio di articoli, che, a mio giudizio, appaiono particolarmente significativi. Per quanto concerne le recensioni non poche, anzi tante, riguardano libri di poesia e la cosa appare più che giustificata essendo Molesini anche poeta e autore di diverse raccolte pubblicate da varie case editrici. Peraltro, ma la circostanza non mi sorprende più di tanto, vi è da notare che la presenza di opere di poeti italiani è pressoché sporadica, mentre massiccia è di quelle di autori di lingua inglese. Sono scritti abbastanza brevi, quasi dei flash che vanno a illuminare, giusto per il potenziale lettore, lopera esaminata, in una capacità di sintesi non certo comune. Particolarmente riuscita quella di I racconti di Robert Louis Stevenson, narratore inglese che stimo in modo particolare e a cui molto deve la letteratura. Il mare, che sempre è presente nelle sue opere e che esercita un fascino dellavventura, dellelemento abitato da mostri orrendi e sconosciuti che altri non sono se non i timori del nostro inconscio, per quanto accennato da Molesini, è allocato nel testo nel momento migliore, tanto che pare quasi di avvertire la presenza di Stevenson stesso. E tutto esemplarmente in poche pagine (solo quattro) per uno di quei narratori che assai raramente, e comunque pochi in un secolo, si affacciano, illuminandolo, sul palcoscenico della letteratura. Ci sarebbe altro, ma fra gli Interventi, cioè i veri e propri saggi, ce nè uno di cui non solo è opportuno, ma doveroso parlare. Limpersonalità del terrore, questa volta non di poche pagine, mira a una disamina attenta di quellimmane tragedia che è stata lolocausto e viene fatta con razionalità, senza enfasi e retorica, come uno studio psicologico e sociologico di quel che è stato e spero non se ne debbano avere altri il più grande terrore di tutti i tempi. Forse qualcuno potrà storcere il naso, perché tanti hanno scritto in proposito, ma il saggio di Molesini ha il pregio di un compendio approfondito e anche comprensibile di una materia difficile. Si parte dalle facile presa delle idee razziste di Adolf Hitler su un popolo, come quello tedesco, su cui invece non avrebbero dovuto avere effetto, stante i contenuti liberali, di pluralismo, di tolleranza della letteratura popolare germanica di prima e dopo la Grande Guerra, di cui si erano nutriti milioni di massaie e lavoratori. E al riguardo viene riportata unilluminante interpretazione di G.L. Mosse A mio avviso la risposta è che molta gente riteneva di star leggendo racconti di fate, e che per tradurre nella realtà la favola ci voleva un Hitler. In altre parole, cè, io credo, in tutti i fascismi (e non già soltanto nel nazismo) il senso di una porta che introduce ad unutopia di tolleranza, di felicità, di produttività e di ogni altra cosa cui la gente aspra. Per quanto ne so, nessun fascismo ( e certamente non il nazismo) menò vanto del suo carattere oppressivo; tutti sostennero invece che loppressione era una fase transitoria, necessaria per realizzare una sorta di utopia.. Cè logica in questa opinione, anche se vi è da precisare che per concretizzare la fase di indottrinamento occorrevano, e occorsero, altre circostanze, fra le quali ricordo la crisi economica di cui i veri responsabili non vollero mai accollarsi la colpa e fu così più facile propinare alla folla il tradizionale capro espiatorio: lebreo. Labilità di mettere in atto il terrore a piccoli passi, lincredulità degli stessi ebrei, lorganizzazione burocratica con cui fu messa in atto la Shoah, ben diversa dagli improvvisati pogrom, concretizzarono questa immane tragedia. Le reazioni spirituali dei deportati si suddivisero in tre fasi. La prima fu lo choc dellaccettazione, comprensiva appunto della cattura, della deportazione e dellavvicinamento al lager stipati come bestie in vagoni piombati; la seconda è stata quella della relativa apatia verso il dolore, il proprio e quello degli altri; la terza e ultima fu relativa alle reazioni psichiche successive alla liberazione. Larticolo poi affronta il tema della razionalità e morale, cioè la nota difesa dei persecutori una volta arrestati: eseguivo solo degli ordini, come se gassare migliaia di persone fosse del tutto naturale, come se quegli esseri umani fossero del bestiame portato al macello. La responsabilità però non è solo degli aguzzini, ma investe anche il disinteresse al riguardo di milioni di cittadini dei paesi conquistati dalla Germania. E i nazisti sapevano cosa stavano facendo? Se ne vergognavano? Nutrivano timori per le conseguenze dei loro atti? Forse delle tre domande, lultima è quella pertinente, perché altrimenti non si spiegherebbe come abbiano sempre cercato di nascondere il loro misfatto, così che se qualcuno si fosse salvato non sarebbe stato creduto. Fu unepoca di orrore criminale, che però ha proiettato alcuni effetti anche sui nostri anni. I revisionisti, i negazionisti fanno leva sul fatto che non esista un registro del terrore, fornendo spiegazioni fantasiose sulla scomparsa di milioni di ebrei. E evidente che anche questa panzana fa parte dei sogni malati di questi neo-nazisti e neo-fascisti, indispensabile per poter riproporre loriginale utopia. A questo bellissimo articolo sono di supporto opinioni e opere di due grandi pensatori, due ebrei, di cui il primo ha sperimentato sulla propria pelle lOlocausto: Primo Levi e Zygmunt Bauman. Questo libro è veramente bello e il saggio su Limpersonalità del terrore già da solo ne giustifica lacquisto. Da leggere, pertanto. Andrea Molesini ha pubblicato con Sellerio Non tutti i bastardi sono di Vienna, che nel 2011 ha vinto, tra gli altri, il Premio Campiello e il Premio Comisso, tradotto in inglese, francese, tedesco, spagnolo e molte altre lingue, La primavera del lupo (2013) e Presagio (2014). Inoltre ha curato libri di poesia di Pound, Brodskij, Hughes, Walcott e Simic. Nel 2008 ha ricevuto il Premio Monselice per la traduzione letteraria. Insegna Letterature comparate allUniversità di Padova.
Sito internet:
www.andreamolesini.it
25/9/2014
Gran Circo Taddei e altre storie di Vigàta di Andrea Camilleri
Sellerio editore Palermo
Narrativa racconti
Il divertimento è assicurato Si tratta di otto racconti ambientati a Vigàta in periodo fascista, un motivo in più questo per una satira graffiante e amara di un regime che aspirava a essere serioso in misura tale da provocare invece ilarità. Del resto, il credere allincredibile, il magnificare la mascolinità mica li ha scoperti come vizi italici Benito Mussolini; no, lui non ha fatto altro che ricamarci su una visione dinsieme tesa a nobilitare una dottrina (quella del ventennio) che, stringi stringi, si riduceva a un florilegio di luoghi comuni, che poi sono gli stessi che gli imbonitori della democrazia pompano e ripompano per assoggettare il popolo bue. Quindi queste storie hanno lo straordinario pregio di mettere in luce eterne e irrinunciabili caratteristiche degli italiani, veri e propri vizi a cui, se pur consapevoli, ci piace indulgere. Non è un caso, pertanto, se nella prosa Gran Circo Taddei, da cui il nome dellintera raccolta, si combinano amore, sogno di potere e piccole astuzie di ogni giorno, volte a definire il mito italico del furbo che, poi, come si potrà leggere, non è che sia così tanto astuto, perché troverà chi lo è più di lui. Ci sono vicende dal sapore un po boccaccesco, come certe pellicole italiane degli anni 70, ma il tutto non è finalizzato a un erotismo un po becero, bensì costituisce il mezzo per parlare dei nostri, invero molti, vizi. Magari si fanno apprezzare di più per labilità creativa che per un messaggio civile a cui Camilleri non è mai insensibile, come per esempio la vendetta di La congiura, oppure il gioco dazzardo di Regali di Natale, o le corna di Il merlo parlante. Sono brani che non hanno grosse pretese se non quella di divertire e ci riescono piuttosto bene. Ma Camilleri non sarebbe il narratore che è se non avesse anche nel cerchio del mirino qualche cosa di più di una pur valida pochade e allora è opportuno approfittare di un tema scottante, come la fecondazione eterologa, scrivendo un racconto misurato e di grande spessore umano come La fine della missione. E poi a questo mondo ci deve essere spazio per tutti, anche per i brutti , e da questo concetto nasce un brano struggente come Un giro in giostra; e se poi ormai gli esseri umani sembrano in aperto contrasto con la teoria dellevoluzione, con gente che crede allincredibile, perché non allestire un racconto che unisca trama ingegnosa, amore e anche un po di felicità? E così cè pure La trovatura. Quello che però è il più stupefacente è lultimo (La rivelazione), in cui un comunista antifascista e perciò condannato al carcere e al confino, alla liberazione alla fine della guerra fa di tutto per non tornare al suo paese dove farebbe il segretario del suo partito. Imbrogli, fede, anche un po di fanatismo animano il racconto che, secondo me è quello che meglio concilia qualità, originalità e capacità di divertire. Penso, insomma, che abbiate capito che la lettura di questo libro è veramente piacevole e gratificante.
Andrea Camilleri
(Porto Empedocle, 1925), regista di teatro, televisione, radio e
sceneggiatore. Ha insegnato regia presso lAccademia Nazionale dArte
Drammatica. Ha pubblicato numerosi saggi sullo spettacolo e il
volume, I teatri stabili in Italia (1898-1918). Il suo
primo romanzo, Il corso delle cose, del 1978, è stato
trasmesso in tre puntate dalla TV col titolo La mano sugli occhi.
Con questa casa editrice ha pubblicato: La strage dimenticata (1984), La
stagione della caccia (1992), La bolla di componenda (1993), Il
birraio di Preston (1995), Un filo di fumo (1997), Il
gioco della mosca(1997), La concessione del telefono (1998), Il
corso delle cose (1998), Il re di Girgenti (2001), La
presa di Macallè (2003), Privo di titolo (2005), Le
pecore e il pastore (2007), Maruzza Musumeci(2007), Il
casellante (2008), Il sonaglio (2009), La rizzagliata (2009), Il
nipote del Negus (2010, anche in versione audiolibro), Gran
Circo Taddei e altre storie di Vigàta (2011), La setta degli
angeli(2011), La Regina di Pomerania e altre storie di Vigàta (2012), La
rivoluzione della luna (2013), La banda Sacco (2013), Inseguendo
un'ombra (2014); e inoltre i romanzi con protagonista il
commissario Salvo Montalbano: La forma dell'acqua (1994), Il
cane di terracotta (1996), Il ladro di merendine (1996), La
voce del violino (1997), La gita a Tindari (2000), L'odore
della notte (2001), Il giro di boa (2003), La pazienza
del ragno (2004), La luna di carta (2005), La vampa
d'agosto (2006),Le ali della sfinge (2006), La pista di
sabbia (2007), Il campo del vasaio (2008), L'età del
dubbio(2008), La danza del gabbiano (2009), La caccia
al tesoro (2010), Il sorriso di Angelica (2010), Il
gioco degli specchi (2011), Una lama di luce (2012), Una
voce di notte (2012), Un covo di vipere (2013), La piramide di fango (2014).
19/9/2014
Terre selvagge
Rizzoli Editore
Romanzo piacevole, ma con poco spessore Penso che non ci sia nulla di strano se uno scrittore impegnato come Sebastiano Vassalli abbia deciso di concedersi un divertissement, perché Terre selvagge sembra proprio il frutto di unevasione, di un desiderio di scrivere un romanzo che non impegni più di tanto sia lautore che il lettore. E in effetti tale lho trovato, piacevole, scorrevole, anche interessante storicamente, ma la sostanza di questo prodotto così ben confezionato è poca. Tanto per dare unidea, siamo lontanissimi da opere come Marco e Mattio, oppure come Le due chiese. Che poi abbia deciso di narrarci di una battaglia accaduta più di duemila anni fa non ha particolare significato, se non quello di fare un po di luce su un evento bellico dimenticato. Si tratta dello scontro fra i Romani e gli invasori Cimbri, avvenuto in una piana allora inospitale e ben poco abitata che si trova in Piemonte, praticamente a due passi da dove abita Vassalli. Certo la storia dEuropa sarebbe stata diversa se anziché vincere Caio Mario, console romano, avesse vinto questa popolazione originaria dellEuropa del Nord, spintasi oltre i confini dei territori abituali forse per trovare Midgard, la terra promessa. Per fortuna dal sanguinoso scontro uscirono vittoriose le legioni romane e dico per fortuna perché, per quanto Roma basasse la sua potenza e la sua egemonia sulle armi, benché vivesse sulle spalle degli schiavi e dei paesi conquistati, pur tuttavia ci ha lasciato segni di civiltà che sono ancora in parte alla base della nostra, come, per esempio, il diritto. Una vittoria, invece, dei barbari Cimbri, che credevano di poter comandare solo con la forza bruta, avrebbe lasciato uneredità di violenza e di sopraffazione, proprie di un popolo incivile. Alle prese con questa battaglia, di cui si è sempre saputo poco, per quanto nei secoli successivi parecchi storici romani ne abbiano scritto (basti pensare che non è certo nemmeno il luogo, anche se tuttavia quello indicato dallautore appare più che probabile), Vassalli ha confezionato uno strano puzzle, a metà fra il saggio storico, accuratamente documentato, e il romanzo storico vero e proprio, terreno in cui si è concesso non poche evasioni, per lo più felicemente. In tal modo, però, vi sono parti più strettamente storiche e come tali, se non grevi, almeno non certo lievi, mentre altre, in cui lidea creativa prende il sopravvento, sono senzaltro godibilissime. Comunque, il lettore si diverte e si trae netta limpressione che anche lautore si sia prefissato di scrivere un libro devasione, magari divertendosi pure lui; le scene di battaglia sono ben descritte, il paesaggio e latmosfera sono resi impeccabilmente, così come i protagonisti. Quel che manca allopera è lo spessore a cui di ha abituato Vassalli, ma va bene lo stesso, concediamogli pure questo divertissement, che peraltro sarà anche nostro. Da leggere, quindi.
Sebastiano Vassalli è
nato a Genova e vive in provincia di Novara. Presso Einaudi, dopo le
prime prove sperimentali, ha pubblicato La
notte della cometa, Sangue
e suolo, L'alcova
elettrica, L'oro
del mondo, La
chimera, Marco e
Mattio, Il
Cigno, 3012, Cuore
di pietra, Un
infinito numero, Archeologia
del presente, Dux, Stella
avvelenata,Amore lontano, La
morte di Marx e altri racconti, L'Italiano, Dio
il Diavolo e la Mosca nel grande caldo dei prossimi mille anni, Le
due chiese e Comprare
il sole.
16/9/2014
Maigret perde le staffe
Traduzione di Marina Karam Narrativa romanzo
La rabbia di Maigret Èmile Boulay, ex cameriere sui transatlantici, ha costruito un piccolo impero di locali notturni a Montmartre, un tipo equivoco verrebbe da pensare, che prospera grazie agli spogliarelli e chissà a quali altri affari, ovviamente poco puliti. E invece no, conduce una vita tranquilla, casa e lavoro, stimato e rispettato da tutti, un uomo che tiene al suo buon nome, che riga dritto e che denuncia al fisco fino allultimo centesimo. Un giorno non rincasa e il cognato, un italiano, pure lui bravo e di antico stampo, teme che sia stato rapito. Il corpo di Emile sarà ritrovato una notte e due giorni dopo la sua scomparsa, in avanzato stato di decomposizione, visto il caldo di quel giugno a Parigi. Il cadavere è in una zona diversa da quella in cui luomo era stato visto lultima volta, in una strada chiusa di un quartiere residenziale e nei due giorni precedenti non era lì. Una circostanza quindi ben strana e ancor più strane sono le cause della morte, avvenuta per strangolamento, un metodo che in quegli ambienti equivoci non è mai utilizzato, perché lì si viene ammazzati o con una coltellata o con una o più pallottole. Maigret, come al solito, allinizio brancola nel buio fino a quando non ha unintuizione, peraltro non suffragata nemmeno da indizi, e su quello straccio didea conduce lindagine, che solo alla fine conferma linfallibile fiuto del commissario, grazie alla scoperta di un movente che lo fa andare in bestia, che gli fa perdere le staffe, ma, buon per lui, il colpevole finirà per togliersi la vita prima ancora della fissazione della data del processo, che finirà con lessere un procedimento giudiziario quasi burocratico e, soprattutto, non pubblico. Così, Maigret ritroverà la consueta calma, ora che giustizia doppiamente è fatta. Maigret perde le staffe è, a mio avviso, uno dei più bei gialli scritti da Simenon. Incalzante dalla prima allultima pagina procede a passo di carica in una nebbia che di dirada molto lentamente e che lascia lo spazio alla luce solo alla conclusione. Come al solito ambientazione, atmosfera e personaggi sono resi in modo impeccabile, contribuendo allautentico piacere che prova un lettore teso a pervenire il più presto possibile alla verità, proprio come il celebre commissario.
Georges Simenon,
nato a Liegi nel 1903, morto a Losanna nel 1989,
ha lasciato
centonovantatre romanzi
pubblicati sotto il suo nome e un numero imprecisato di romanzi e
racconti pubblicati sotto pseudonimi, oltre a volumi di «dettature» e
memorie. Il commissario Maigret è protagonista di 75 romanzi
e 28 racconti, tutti pubblicati fra il 1931 e il 1972. Celebre in
tutto il mondo, innanzitutto per le storie di Maigret, Simenon è
anche, paradossalmente, un caso di «scrittore per scrittori». Da
Henry Miller a Jean Pauhlan, da Faulkner
a Cocteau, molti e disparati sono infatti gli
autori che hanno riconosciuto in lui un maestro. Tra questi, André
Gide: «Considero Simenon un grande romanziere, forse il più grande e
il più autentico che
la letteratura
francese abbia oggi»; Walter Benjamin: «
leggo ogni nuovo romanzo di
Simenon»; Louis-Ferdinand Céline:
«Ci sono scrittori che ammiro moltissimo: il Simenon dei Pitard,
per esempio, bisognerebbe parlarne tutti i giorni».
14/9/2014
Casa di guerra
Edizioni Longanesi
Giunto allultima pagina mi è venuto spontaneo esclamare: Ma quanto è brava Isabella Bossi Fedrigotti!. E credo di non aver esagerato nel giudizio, perché questa narratrice trentina, di cui avevo già avuto modo di leggere e di apprezzare Di buona famiglia e Amore mio uccidi Garibaldi, ha un notevole talento letterario e una capacità rara di coinvolgere pur con vicende non eclatanti, addirittura, in alcuni casi, banali. Sarà per lo stile piano, per un linguaggio oggi un po desueto, ma per nulla arcaico, sarà il ritmo mai veloce, ma nemmeno lento, insomma sta di fatto che è pressoché impossibile non entusiasmarsi leggendo i romanzi di questa scrittrice. Aggiungo, poi, che nel raccontare la vita (nel caso specifico si tratta dellultimo anno e mezzo della seconda guerra mondiale), lo fa con eleganza, smussando le tinte forti, sondando lanimo umano, e non solo quello femminile, con straordinaria abilità. In Casa di guerra tutto parte da una fotografia di carattere familiare; è un esterno e quelle figure in primo piano, che la scrittrice descrive, fornendone le caratteristiche essenziali, piano piano sembrano animarsi e uscire da quella carta lucida, ognuna per rivendicare il ruolo di protagonista e per parlarci di come fu la sua vita in quel duro periodo di guerra, magari integrandosi a vicenda nel racconto, chiarendo punti oscuri, fornendo la propria versione dei fatti. E così che facciamo la conoscenza con la tedesca Bertha Wesemann. La governante di casa, con la sudtirolese Resi Raffler, la cuoca, con il padrone di casa conte Fedrigotti, un uomo che sta con i partigiani, con laltro sudtirolese, ma nazista, Franz Stauderer, con la signorina Maria Luigia Firmian, protagonisti che si incrociano fra loro, che un poco parlano della loro vita, soprattutto di quei mesi, dopo l8 settembre 1943 e fino alla fine di aprile-inizi maggio 1945 in cui il TrentinoAlto Adige divenne di fatto parte integrante del Terzo Reich in quella macro regione che i nazisti si compiacquero di chiamare Alpenvorland. E poi ci sono tantissimi personaggi che sgomitano quasi per ritagliarsi la loro briciola di notorietà, non semplici comparse, ma vere e proprie spalle dei protagonisti, figure tutte a cui la narratrice nellultimo capitolo intitolato Oggi cerca di dare una collocazione, un seguito, perché è naturale e spontaneo chiedersi che fine hanno fatto una volta terminata la guerra, Queste pagine conclusive sono un colpo da maestro, perché uniscono idealmente le immagini della fotografia iniziale alla realtà di molti anni dopo e sanciscono il valore storico e affettivo di una semplice istantanea che ha immortalato sulla carta uomini e donne la cui memoria non è solo lo spunto per scrivere un romanzo, ma è un tributo a chi ci ha preceduto, a chi prima di noi ha mosso i piedi sulleterno palcoscenico della commedia della vita. Sì, Isabella Bossi Fedrigotti è veramente brava e pertanto non posso che raccomandarvi la lettura di questo bellissimo Casa di guerra.
Isabella Bossi Fedrigotti,
nata a Rovereto da madre austriaca, è giornalista al Corriere
della Sera. Con il romanzo Casa di guerra (1983) è stata
finalista al Premio Strega e al Campiello. Il successo al Premio
Campiello è arrivato nel 1991 con il terzo romanzo, il bestseller Di
buona famiglia. Altri titoli sono Il catalogo delle amiche (Rizzoli,
1998), Cari saluti (Rizzoli, 2001), La valigia del signor
Budischowsky (Rizzoli, 2003) e Il primo figlio (Rizzoli,
2008).
10/9/2014
Aspettando lalba
Edizioni Einaudi Collana Supercoralli
La memoria di ciò che è stato Mario Rigoni Stern non ha mai scritto romanzi frutto di esclusiva fantasia; nei suoi libri non ci sono storie e personaggi inventati, cè invece sempre lui, capace con una creatività non disancorata dalla realtà di scrivere pagine e pagine affascinanti, benché largomento spesso e a prima vista possa apparire banale. Così non si troverà mai una passeggiata sulla neve o unalba sullaltopiano, bensì si potrà leggere di quella passeggiata sulla neve o di quella specifica alba sullaltopiano, in quanto entrambe frutto di unesperienza effettivamente maturata e che lautore ricrea arricchita dalla sua straordinaria capacità di saper osservare. Ovviamente ciò si verifica puntualmente anche con i racconti di questa raccolta, che presenta una doppia anima, cioè quella della guerra e quella della natura, che a volte si alternano, mentre altre finiscono con lincontrarsi, fondendosi in uno scritto che ben in equilibrio le ricomprende. In ogni caso sembrano tante pietruzze pazientemente raccolte e accostate che vanno ad arricchire, come un mosaico, il mausoleo della memoria edificato con pazienza e con passione da Mario Rigoni Stern. Ci sono tanti personaggi protagonisti, che a prima vista possono sembrare insignificanti e che invece hanno un peso, nemmeno di poco conto, come Romedio e la sua mula che, durante la ritirata in Russia, portano in salvo decine di feriti. Ma sono anche le piccole cose, spesso da noi volutamente ignorate, che vengono fatte emergere prepotentemente per rivendicare la storia in cui sono entrate, come nel caso della bottiglia di grappa, nascosta nel 1917 in una trincea, e ritrovata solo dopo una trentina di anni. La capacità di osservazione è tale che persino la dura realtà del lager viene smussata da chi sa guardare la natura con animo poetico. Al riguardo il ritorno dopo molti anni dalla fine della guerra nel luogo di detenzione, accompagnato dalla moglie e dal figlio, che prudentemente stanno in disparte, sono fra le pagine più belle. Ora non ci sono più baracche, torrette e reticolati, ma solo campi verdeggianti, in cui Stern, con i pochi riferimenti sopravvissuti, fruga nella memoria per rivedere dove si trovava il suo tavolaccio, o per ripercorrere parte della strada che ogni mattina lo portava al lavoro forzato. Il contrasto fra ciò che cè ora e ciò che cera è reso in modo stupendo e sembra di vedere lautore teso nello sforzo di ricostruire quel suo passato. E poi ci sono gli amici: Nuto Revelli, ma soprattutto Primo Levi, a cui scrive una lettera di sublime bellezza allindomani della sua tragica scomparsa. Sì, Mario Rigoni Stern è un grande scrittore, uno dei più grandi del nostro paese, sincero fino allestremo; con questa raccolta ci consegna il suo testamento di uomo che, nei travagli di una vita massicciamente influenzata dalla guerra, ha saputo trovare una via di fuga dallorrore e con essa è pervenuto a un senso umano, ma anche mistico, dellesistenza. In queste pagine che vanno vestendosi di toni crepuscolari cè tutta la consapevolezza che il tempo sta per finire, ma non ci sono né dolore, né rabbia, anzi cè una profonda serenità, proprie di chi, soddisfatto del suo lungo cammino che volge al tramonto, sa che la prossima alba sarà la più luminosa e che porterà uninfinita tanto attesa pace. Imperdibile.
Mario Rigoni Stern (Asiago
1921-2008) ha esordito nel 1953 con Il
sergente nella neve. Ricordi della ritirata di Russia (ultima
edizione «Super ET» 2008), uno dei libri più significativi del
dopoguerra. Sempre presso Einaudi, ha poi pubblicato: Il
bosco degli urogalli(1962), Quota
Albania (1971), Ritorno
sul Don (1973), Storia
di Tönle (1978, Premio Campiello), Uomini,
boschi e api (1980), L'anno
della vittoria (1985), Amore
di confine (1986), Il
libro degli animali (1990),
Arboreto salvatico (1991), Le
stagioni di Giacomo (1995), Sentieri
sotto la neve (1998), Inverni
lontani (1999 e 2009), Tra
due guerre (2000),L'ultima
partita a carte (2002
e 2009), Aspettando
l'alba e altri racconti (2004), I
racconti di guerra (2006)
e Stagioni («L'Arcipelago
Einaudi» 2006, «Super ET» 2008 e «Numeri Primi» 2012). Il suo ultimo
libro, pubblicato postumo nel 2008, è la sceneggiatura del Sergente
nella neve, scritta con Ermanno Olmi.
7/9/2014
Eros
a cura di Aurelio Caliri
In copertina: Salvatore Fiume, Ricordo di Charleston (1983)
Edizioni Arte e Musica Nota: il libro non si trova in libreria, ma può essere richiesto direttamente alleditore ai numeri telefonici: 0931-465616 / 349-1258842
oppure allindirizzo mail:
Erotismo soft e assai piacevole Preliminarmente mi corre lobbligo di una precisazione, dato il tema trattato nei racconti di questa raccolta. Si parla di erotismo e non di pornografia, che sono due cose completamente diverse. Il primo ha a che fare con tutto ciò che riguarda lamore, e cioè agli stati emotivi fisici e mentali che lo stesso genera; la seconda invece si limita a descrivere il rapporto sessuale esclusivamente nella sua parte materiale, tralasciando volutamente laspetto psicologico. Nel primo la fantasia individuale e le allusioni sono predominanti, nella seconda invece è presente solo una carnalità che non lascia spazio a immaginazioni. Inoltre, in campo letterario lerotismo è arte e al riguardo basti pensare a opere di grande valore come Lamante di Lady Chatterley di Lawrence o a Lolita di Nabokov; la seconda non è assolutamente arte e nel migliore dei casi è una sua degenerazione. Ciò premesso, dico subito che Eros è una raccolta di racconti (ma cè anche qualche poesia) con tema lerotismo; si tratta di prose garbate, a volte anche venate di comicità che in nessun caso possono offendere il comune senso del pudore, ma che rappresentano la possibilità di trascorrere piacevolmente alcune ore, insomma quello che potrebbe essere definito un sano svago. Come capita sempre nelle antologie, ci sono brani che potranno piacere di più o di meno, fermo restando il fatto però che non ce ne sono di basso livello letterario. Per quanto sia una questione di gusti le mie preferenze sono andate ad alcuni ed è di questi che intendo parlare, non potendo per ragioni di tempo e di spazio trattare di tutti. A puro titolo conoscitivo, preciso inoltre che della raccolta fanno parte anche due miei racconti: Prima del buio e Maschi, questultimo tratto dal mio Storie di paese. Pelo rosso, di Sebastiano Burgaretta: Federica è una bella ragazza, oggetto del desiderio di tutti i maschi del paese, ma lei, che è un po civetta, preferisce fra tanti un bonaccione un po tonto. Di toni garbati, le descrizioni e le situazioni hanno il pregio di lasciar intendere, sfumando e in tal modo incuriosendo di più. Mariou, di Aurelio Caliri: un trio di musicisti e il gallismo proprio di noi italiani, pronti a vedere nella straniera la preda facile, ma proprio per questo il cacciatore può diventare a sua volta preda. Ironico e con una vena satirica che lo permea in modo assai gradevole. Non si fa in piedi, di Pino Caruso: la scoperta del sesso negli adolescenti trattata con mano leggera, con un filo di pudore che arricchisce artisticamente il brano. Quella sera un poeta cieco, di Matteo Collura: in un mondo del futuro un uomo e una donna che si appartano e che insieme scoprono un pezzo dantiquariato, un libro, una rivelazione che li appassiona, in un canto allamore e alla letteratura. I fratelli Maltese, di Corrado Di Pietro: tratto dal suo romanzo La terra sopra Scibini ha il sapore delle opere di Verga, con una perfetta fusione fra Eros e Thanatos, in una vicenda appunto damore e di morte, in cui i protagonisti si lasciano sopraffare dai sensi. La prima notte di Lucia, di Aurelio Grimaldi: troviamo unalta letteratura, perché Grimaldi immagina la prima notte di Lucia Mondella e di Renzo Tramaglino, i due protagonisti dei Promessi sposi. La psicologia di entrambi, anche dal punto di vista sessuale, è descritta mirabilmente e credo che Alessandro Manzoni, se potesse leggerlo, non potrebbe che essere daccordo. Brani tratti da Mimi Siciliani, di Francesco Lanza: brevi, quasi dei flash, hanno il sapore della scrittura di una volta con una vena satirico-comica che a volte strappa un sorriso e altre provoca una sonora risata. Il Duetto e la Mini, di Antonio Sparatore: qui lerotismo come fantasia supera ogni immaginazione, in quanto legato al sogno ed è un bel leggere. Vanessa per sempre, di Salvo Zappulla e Virginia Foderaro: un classico trio, di due donne e un uomo, ma con unoriginalità nellimpostazione che lo impreziosisce e che, per quanto lungo, finisce con il risultare più che gradevole. Eros, che è impreziosito da numerose illustrazioni che riproducono dei dipinti di Salvatore Fiume, noto pittore siciliano presente con alcuni racconti brevi e qualche poesia (particolarmente bella mi è parsa Mare mio), è una raccolta che nel complesso si presta a essere letta con piacere ed é quindi senzaltro raccomandabile. Gli Autori
Giuseppe Asaro, Barbara Becheroni, Pippo Bella, Sebastiano Burgaretta,
Aurelio Caliri, Pino Caruso, Nicola Colombo, Matteo Collura, Corrado
Di Pietro, Salvatore Fiume, Giorgio Giannone, Aurelio Grimaldi,
Francesco Lanza, Alessandra Leone, Luigi M. Lombardi Satriani,
Giuseppe Mannino, Renzo Montagnoli, Luca Raimondi, Flora Restivo,
Angela Rizzo, Vanni Ronsisvalle, Corrado Sofia, Antonio Sparatore,
Salvo Zappulla e Virginia Foderaro.
4/9/2014
Foibe rosse Né saggio, né romanzo storico Quando finisce una guerra, la relativa storia viene sempre scritta dai vincitori e pertanto è legittimo che sorgano dei dubbi sulla veridicità dei fatti. In seguito, anni dopo, placate le tensioni del conflitto, gli inevitabili asti, qualche storico si prende sempre la briga di scriverne un saggio, cercando di accertare scrupolosamente come andarono veramente le cose. Non mancano, inoltre, altri che finiscono con il contestare la storia ufficiale con argomenti e risultanze che, spesso inesatte, oppure del tutto inventate, mirano, anziché alla ricerca della verità, a sostenere le ragioni del perdente, unoperazione di revisionismo che diventa unantistoria. Ci sono argomenti e fatti che spesso il vincitore ignora e lo fa quasi sempre volutamente, episodi per nulla edificanti che compromettono la visione idilliaca degli eroi buoni e altruisti. Al riguardo la vicenda delle foibe è stata a lungo trascurata, ma per fortuna, da qualche anno, cè un interesse e sono iniziati gli studi, ancora incompleti e contrastanti. Per chi non lo sapesse, la foiba è un grande inghiottitoio, cioè una caverna verticale, tipica del terreno carsico e dellIstria. Le foibe sono tristemente famose per gli eccidi della popolazione italiana avvenuti nella Venezia Giulia e nella Dalmazia nel corso della seconda guerra mondiale e nellimmediato dopoguerra. Lì vi furono gettate le vittime, a volte ancora in vita, per nascondere il crimine e quindi gli assassini ben sapevano quel che stavano facendo. Vi è anche da precisare che la presenza del regime fascista in quei territori, da sempre terre di confine, fu assai oppressiva, macchiandosi di orribili delitti e in questo contesto vendette e contro vendette maturarono e prosperarono, colpendo spesso degli innocenti. Già dopo l8 settembre 1943 i partigiani slavi del partito comunista provvidero a commettere delle vere e proprie stragi, prendendo però di mira elementi italiani di fede fascista, mentre nellimmediato dopoguerra i militi di Tito colpirono gli italiani in quanto tali, onde sradicarli da un territorio che volevano solo per loro. Il libro di Sessi allinizio provvede molto opportunamente a descrivere il contesto storico, anche se rimane in superficie, evitando di approfondire. E lo fa per spiegare il momento in cui avviene il martirio, perché così si può definire, di Norma Cossetto, imprigionata, più volte violentata e infine gettata ancora viva, insieme con altri, in una foiba. Il tutto avviene dopo larmistizio proclamato da Badoglio, nei giorni immediatamente antecedenti loccupazione nazista della zona. Norma, figlia di un possidente terriero, esponente fascista di spicco nellIstria, fascista pure lei (ma non può essere considerato questa una colpa e, se anche lo fosse, mai e poi mai potrebbe giustificare il suo assassinio), studentessa iscritta allUniversità di Padova, che poi, a guerra terminata, le conferirà, congiuntamente ad altri studenti vittime della ferocia nazi-fascista, la laurea honoris causa, è diventata suo malgrado il simbolo, lemblema della tragedia delle foibe. Gli elementi che aveva Sessi per narrare la sua storia erano modestissimi e allora ha cercato di delineare il personaggio con due interviste: una a sua sorella, laltra alla sua più cara amica. E qui cominciano i limiti dellopera, perché è evidente che queste due fonti non possono essere imparziali e al riguardo una cade spesso in contraddizione, sia cambiando lindicazione della materia oggetto della tesi di laurea che Norma aveva in corso di stesura, sia con unaffermazione che lascia stupefatti, quando la sorella dice che i contadini alle loro dipendenze amavano la sua famiglia, cambiando però bruscamente atteggiamento allindomani dell8 settembre 1943. È infatti evidente che è impossibile che tutti improvvisamente da amici possano diventare nemici. E come se non bastasse altri personaggi di famiglia inseriti nel racconto su Norma sono tutti buoni, bravi, di carattere mite, altruisti, insomma individui che era impossibile odiare. Queste caratteristiche dei personaggi sono tipiche delle operazioni di revisionismo, in cui i perdenti sono i migliori uomini del mondo, quando sappiamo per esperienza quanto rari siano gli esseri umani tutti pregi e niente difetti. Aggiungo che le poche testimonianze relative al ritrovamento, due mesi dopo la scomparsa, del corpo di Norma e di altri infoibati con lei sono incomplete e spesso contrastanti e che per giunta non venne effettuata lautopsia. Poiché la materia era poca e le fonti limitate e di scarsa attendibilità Sessi si è provato a implementare la sua opera inventandosi un ipotetico diario scritto da Norma, così che di colpo si passa da uno pseudo saggio a un romanzo storico. In questo modo, però, non rende giustizia alla ragazza, che di giustizia, quella vera, anche se morta da tempo, avrebbe un gran bisogno. Al termine del memoriale, però, a Sessi deve essere venuto il dubbio che tanta enfasi poco storica avrebbe potuto connotarlo come un sostenitore del fascismo, il che, preciso, non è assolutamente vero, ma a scanso di equivoci ha voluto aggiungere una personale postfazione in cui con dovizia di particolari e senza invenzioni cerca di giustificare il clima di conflitti intervenuto in quei territori a causa del feroce dominio italiano, che fece, fra le popolazioni slave, un numero di vittime ben superiore a quello degli infoibati. Mi ha stupito questo improvviso cambiamento di impostazione, perché negli altri libri Sessi, pur concedendosi qualche riflessione personale, non è mai venuto meno al rigore a cui dovrebbe essere improntato il lavoro di uno storico scrupoloso. Insomma, anche questa volta il dramma delle foibe, anziché essere sviscerato, finisce con il presentare più ombre che luci, ed è un peccato, perché chi morì infoibato (un migliaio di persone), innocente o macchiatosi di vari reati, non meritava in ogni caso una fine così orribile, e fare chiarezza sui fatti avrebbe una valenza non solo per la memoria delle vittime, ma anche in funzione preventiva. Infatti, una ricerca attenta e rigorosa volta a portare allo scoperto il perché e il per come questo eccidio avvenne servirebbe a comprendere meglio il fenomeno, al fine di evitare un suo sempre possibile ripetersi, e allora in un certo senso questi poveri morti non sarebbero solo corpi martoriati, ma testimoni e protagonisti di una tragedia, un monito per gli uomini di oggi e di domani. Pur con i limiti, e non sono pochi, di cui ho accennato non mi sento di sconsigliarne la lettura, perché in fin dei conti qualcosa di più, anche se assai poco, potrete sapere sulleccidio delle foibe.
Frediano Sessi
vive e lavora a Mantova. Tra le sue pubblicazioni ricordiamo Il
ragazzo Celeste (1991),
Ritorno a Berlino (1993), Lultimo
giorno (1995), Alba
di nebbia (1998), Nome
di battaglia: Diavolo (2000),
Prigionieri della memoria (2006,
due edizioni), Foibe
Rosse (2007, due
edizioni), Il segreto
di Barbiana(2009) e con Carlo Saletti Visitare
Auschwitz (2011, due
edizioni) tutti editi da Marsilio. Sempre per Marsilio ha curato il
saggio di Michel Mazor La
città scomparsa(1992). È autore inoltre dei romanzi per ragazzi
Ultima fermata: Auschwitz (1996), Sotto
il cielo dEuropa (1998)
e Il mio nome è Anne
Frank (2010), editi
da Einaudi, per cui ha curato anche ledizione italiana definitiva
del Diario di Anne
Frank (1993) e il Dizionario
della Resistenza (2000).
Nel 1999 è stato pubblicato il suo saggio La
vita quotidiana ad Auschwitz (Rizzoli,
tredici edizioni).
1/9/2014
Il sistema periodico
Edizioni Einaudi
Già il titolo mi aveva incuriosito, anche se proprio lo stesso mi rendeva titubante, perché, facendo un collegamento fra gli studi e la professione di Levi (era un chimico) e il sistema periodico degli elementi della tavola di Mendeleev, mi era sorto il dubbio che questo libro potesse essere un trattato di chimica, materia che a scuola ho dovuto studiare perché cera, non perché mi piacesse, a differenza della fisica, per cui nutrivo unautentica passione. Poi, una volta letta questa raccolta di racconti, mi sono dovuto in parte ricredere, perché la chimica ne costituisce solo spunti, visto che per esempio ognuno dei 21 brani porta il nome di un elemento della tavola periodica, in qualche modo ricollegandosi allo stesso. In effetti Levi in essi ripercorre episodi della sua esistenza, lasciando margini limitati alla massima creatività, tranne che in due o tre e comunque lasciando trapelare fra le righe non poco degli studi fatti, circostanza che ha indotto alcuni anni fa un organismo britannico a definire Il sistema periodico il miglior libro sulla scienza che sia mai stato scritto. Se questo può essere un pregio, è però a mio avviso anche un limite, perché il rigoroso e asettico procedere del metodo scientifico viene a urtare inevitabilmente con le possibilità di sviluppare e proporre idee in campo letterario. Certo lautore è particolarmente bravo, ma non può fare a meno di trasferire nella sua opera questo aspetto antitetico e il risultato un po ne risente, così che la fluidità riscontrabile in altri libri di Levi qui si attenua, dando luogo a periodi più lunghi, a una certa prolissità che finisce a volte con il banalizzare largomento. Ciò nonostante e benché la facilità di lettura non sia agevolata, si riesce a procedere, pagina dopo pagina, a volte un po con noia, altre con vero piacere. Peraltro questo è forse un libro, più di altri suoi, di letteratura ebraica, e del resto se in quelli che lhanno reso famoso si poteva cogliere la sua sorpresa di sentirsi ebreo, quindi diverso dai gentili, perché tale era stato il frutto delle leggi razziali, in questopera invece si trova un Levi convinto del suo ebraismo, e al riguardo basta leggere il primo brano (Argon), dove per argomento e per modalità di svolgimento appare chiara la matrice e limpronta dellorigine. Poiché siamo in presenza di racconti, come al solito, ce ne sono che risultano più o meno graditi, fermo restando il livello qualitativo medio piuttosto elevato; in ogni caso, e questo lho scritto anche per il suo romanzo La chiave a stella, siamo lontani come risultato complessivo da Se questo è un uomo, da La tregua e da I sommersi e i salvati, ma ciò non deve meravigliare, poiché quelle sono opere di tale eccelsa qualità da oscurare altre pur valide. Levi aveva un naturale talento letterario, ma il meglio dello stesso è stato profuso nellesperienza diretta della vita nel campo di concentramento, al punto tale che, se si parla di lui con altri, a tutti viene subito in mente Se questo è un uomo. La chiave a stella e Il sistema periodico sono dei buoni libri, ma scontano inevitabilmente la superlativa bellezza di quelli che hanno fatto scoprire lautore al mondo letterario e che assai più di altri ci hanno meglio parlato della Shoah. Da leggere.
Primo Levi (Torino
1919-1987) ha pubblicato presso Einaudi Se
questo è un uomo; La
tregua; Storie
naturali; Vizio di
forma; Il sistema
periodico; La
chiave a stella; La
ricerca delle radici. Antologia personale; Lilìt e
altri racconti; Se
non ora, quando?; L'altrui
mestiere; I
sommersi e i salvati. Sempre da Einaudi sono usciti postumi i due
volumi delle Opere; Conversazioni
e interviste (1963-1987);L'ultimo
Natale di guerra; L'asimmetria e la vita. Articoli
e saggi 1955-1987; Tutti i racconti,
sempre a cura di Marco Belpoliti.
28/8/2014
Grande guerra, piccoli generali
Edizioni Utet Nel primo centenario Questanno si commemora il primo centenario dellinizio della prima guerra mondiale, più conosciuta anche come Grande Guerra, grande per il numero delle nazioni partecipanti e grande anche per il numero delle perdite (allincirca ben 24 milioni). Il tutto cominciò il 28 luglio 1914 con la dichiarazione di guerra dellimpero austro-ungarico al regno di Serbia; a ruota, per il gioco delle alleanze, presero le armi la Francia, il Regno Unito, la Russia, la Germania e limpero ottomano e negli anni successivi lItalia, la Bulgaria, la Romania e gli Stati Uniti (solo per citare i più noti). Allepoca eravamo vincolati alla Triplice Alleanza, costituita appunto da noi, dalla Germania e dallAustria, ma, con il nostro consueto voltagabbana, dopo segrete trattative, passammo di campo e fu così che il 24 maggio 1915 dichiarammo guerra alla sola Austria. Come al solito il nostro esercito non era pronto, né per i mezzi, spesso obsoleti e addirittura mancanti, né, soprattutto, per limpreparazione dei comandanti, gente che ragionava ancora come se si trovasse non nel XX secolo, ma in epoca romana. La mobilitazione avvenne con estrema lentezza, non cera e non ci fu mai un piano strategico, i tentennamenti erano allordine del giorno e fu così che perdemmo unoccasione doro nel primo mese di belligeranza, perché una decisa nostra puntata verso Dobbiaco non avrebbe potuto essere fermata, stante il velo di truppe austriache presenti, mentre il grosso dellesercito imperiale era impegnato contro la Russia. Il libro di Lorenzo Del Boca ripercorre il tragitto di un conflitto orribile, impietoso, in cui i nostri soldati, pur distinguendosi per alto senso del dovere e facendosi in pratica massacrare, si presero costantemente le colpe delle sconfitte, colpe che invece erano dei Comandi Superiori e in primis del Comandante in capo Luigi Cadorna, capace di dissanguare un paese nelle tante battaglie dellIsonzo adottando la medesima tattica dellattacco frontale. Lui, inoltre, insieme a Badoglio e a qualcun altro, è lunico responsabile della disfatta di Caporetto, che volle tuttavia imputare alla vigliaccheria dei soldati. Ci sono pagine e pagine che parlano della vita in trincea, dellassenza della benché minima visione strategica e tattica, delle punizioni, spesso immotivate, dei poveri fantaccini, delle fucilazioni gratuite, delle decimazioni, tanto che verrebbe da pensare che il nemico non era quello che ci fronteggiava, bensì chi decideva scelleratamente nelle retrovie. A Cadorna, poi rimosso dallincarico su pressioni degli alleati e sostituito dal generale Diaz, intitolarono vie e piazze, e ancora ce nè qualcuna che porta il suo nome; dico solo che a lasciare intestato qualche cosa a questo sciagurato è criminale, perché era meritevole di un solo trattamento: degradazione pubblica e fucilazione alla schiena. Insomma, la nostra tradizione che dallUnità dItalia ci vede sconfitti in una guerra sembrava confermata anche nella Prima Guerra Mondiale senza una battaglia vinta, a meno che non si voglia considerare una vittoria la nostra eroica resistenza sul Piave, mirabile esempio di sacrificio di quegli stessi soldati che Cadorna aveva tacciato di vigliaccheria. Poi venne Vittorio Veneto, ma più che una battaglia fu linseguimento delle truppe nemiche, che stremate e consunte, si ritiravano sulle originarie posizioni. Si dice che la storia insegna e forse è vero, ma si vede che lItalia è una cattiva scolara, perché altrimenti non vi sarebbe stata la nostra sciagurata partecipazione alla seconda guerra mondiale. Non siamo un popolo di guerrieri (per fortuna), ma sappiamo fare il nostro dovere; quello che ci manca sono dei capi capaci e onesti, senza i quali continueremo a essere, nel contesto mondiale degli stati, o gli ultimi dei primi, o i primi degli ultimi, insomma di una mediocrità che non riusciamo a toglierci di dosso. Da leggere.
Lorenzo Del Boca è
giornalista professionista. Ha sviluppato la sua carriera presso l�editrice
�La
Stampa�,
iniziando a scrivere sulle pagine provinciali di Novara per
diventarne poi capocronista, inviato speciale ed editorialista. Nel
1996 è stato eletto presidente della Federazione Nazionale della
Stampa e, dal 2001, è il presidente dell�Ordine
Nazionale dei Giornalisti. Polemista, al di fuori delle convenzioni,
talvolta controcorrente, è autore di libri e di saggi che presentano
�l�altra
storia�
del Risorgimento e dellEtà Contemporanea.
25/8/2014
La setta degli angeli
Sellerio Editore Palermo Narrativa romanzo
Un bunga bunga di inizi 900 Scrive lautore, in una nota finale: Questo romanzo volutamente stravolge, fino a renderli irriconoscibili tanto da sconfinare nel campo della pura fantasia, i fatti che realmente accaddero in un paese siciliano, Alia, allinizio del secolo scorso. Un prete, Rosolino Martino, viene deferito allAutorità Giudiziaria per corruzione di ragazze minorenni. Un ex farmacista del luogo, Matteo Teresi, che dalle pagine di un suo giornaletto, <<La Battaglia>>, combatte le prepotenze dei mafiosi, degli agrari e del clero, comincia unindagine su quel fatto e arriva alla strabiliante scoperta che i preti di Alia hanno fondato una setta segreta che <<mobilita giovani fanciulle ancora vergini ed inesperte, e giovani spose, a cui si fa credere che il rapporto sessuale o le stesse pratiche sessuali preparatorie del rapporto, sono uno strumento per acquisire indulgenze divine ed aprire le porte del Paradiso>>, come spiega Gaetano DAndrea, ex sindaco di Alia.. Quindi se lo spunto di questo romanzo è un fatto realmente accaduto, la sua realizzazione è invece frutto di pura creatività, e di quanto avvenne agli inizi del secolo scorso veritieri e conformi sono solo il nome del protagonista, Matteo Teresi, e del suo giornale, nonché il brano di un articolo di Don Luigi Sturzo. Comunque, labilità inventiva di Camilleri è tale da convincersi, pagina dopo pagina, che le cose sono andate esattamente così, anche perché lautore profonde a piene mani, soprattutto nella prima parte, una travolgente verve comica. Insomma, si ride e anche volentieri, cosa non da poco in unepoca in cui lautentica comicità sembra essersi persa per strada. Ma è un riso che alla fine lascia un sapore amaro in bocca, perché, come si potrà leggere, ancora una volta affiora limpegno civile di questo scrittore particolarmente prolifico. E chi si attende un lieto fine, del tipo e tutti vissero felici e contenti se lo scordi, perché se lassenza di verità è un male, il rifiuto di conoscenza della stessa è ancor peggio e così può capitare, come nel libro, che lintegerrimo cittadino che ha scoperchiato le pentole del diavolo venga poco a poco escluso dalla società, un isolamento che non di rado può portare alla morte, e non solo per suicidio, ma anche per omicidio. Teresi, a suo modo, è un eroe, e come tale lo è perché incosciente, non comprendendo la natura dei suoi compaesani che prima lo portano sugli altari e poi lo relegano in un angolo remoto. Toccare la mafia, la nobiltà, il potere economico, il clero, tutte caste in combutta fra loro, significa emarginarsi, magari anche per latteggiamento di chi si voleva proteggere, più incline a un quieto vivere, così che dopo un polverone, in cui sembra che tutto cambi, tutto ritorna uguale, come se non fosse avvenuto niente. La staticità della struttura non può accettare chi mina la stessa e infatti Teresi, anche nella realtà, dovrà andarsene in America. Romanzo godibilissimo, che quasi si divora, accompagnato da una vena dironia e di sarcasmo, La setta degli angeli sembra confermare il concetto che la storia è ripetitiva e che fatti, modalità e risultanze di tanto in tanto si ripropongono. Lorgia dei preti in fondo non era che un bunga bunga dellepoca e quindi cosa è cambiato? Nulla, perché il paese é ingessato e perpetua i suoi difetti in una decadenza inarrestabile. Da leggere, senzaltro, perché è meritevole della massima considerazione. Andrea Camilleri (Porto Empedocle, 1925), regista di teatro, televisione, radio e sceneggiatore. Ha insegnato regia presso lAccademia Nazionale dArte Drammatica. Ha pubblicato numerosi saggi sullo spettacolo e il volume, I teatri stabili in Italia (1898-1918).
Il suo primo romanzo, Il
corso delle cose, del 1978, è stato trasmesso in tre puntate
dalla TV col titolo La
mano sugli occhi. Con questa casa editrice ha pubblicato: La
strage dimenticata (1984), La
stagione della caccia (1992), La
bolla di componenda (1993), Il
birraio di Preston (1995), Un
filo di fumo (1997), Il
gioco della mosca(1997), La
concessione del telefono (1998), Il
corso delle cose (1998), Il
re di Girgenti (2001), La
presa di Macallè (2003), Privo
di titolo (2005), Le
pecore e il pastore (2007), Maruzza
Musumeci(2007), Il
casellante (2008), Il
sonaglio (2009), La
rizzagliata (2009), Il
nipote del Negus (2010,
anche in versione audiolibro), Gran
Circo Taddei e altre storie di Vigàta (2011), La
setta degli angeli(2011), La
Regina di Pomerania e altre storie di Vigàta (2012), La
rivoluzione della luna (2013), La
banda Sacco (2013), Inseguendo
un'ombra (2014); e inoltre i romanzi con protagonista il
commissario Salvo Montalbano: La
forma dell'acqua (1994), Il
cane di terracotta (1996), Il
ladro di merendine (1996), La
voce del violino (1997), La
gita a Tindari (2000), L'odore
della notte (2001), Il
giro di boa (2003), La
pazienza del ragno (2004), La
luna di carta (2005), La
vampa d'agosto (2006),Le
ali della sfinge (2006), La
pista di sabbia (2007), Il
campo del vasaio (2008), L'età
del dubbio(2008), La
danza del gabbiano (2009), La
caccia al tesoro (2010), Il
sorriso di Angelica (2010), Il
gioco degli specchi (2011), Una
lama di luce (2012), Una
voce di notte (2012), Un
covo di vipere (2013), La
piramide di fango (2014).
23/8/2014
La voce degli uomini freddi
Arnoldo Mondadori Editore S.p.A.
Sono rimasto deluso Sono sempre stato un estimatore di Mauro Corona, un eccellente scrittore, le cui opere grosso modo si dividono in due filoni, a volte congiunti: quello che si potrebbe definire memorialistico, e che si traduce in un culto del ricordo, e quello più propriamente narrativo, cioè dove predomina la fantasia creativa. Non saprei dire in quale dei due inserire La voce degli uomini freddi, perché cè si tanta inventiva, non disgiunta tuttavia da eventi accaduti realmente che, se anche non sono riportati con lesatto nome, sono tuttavia facilmente identificabili (basti a pensare al finale che ripropone una tragedia come quella del Vajont). Essenzialmente ci troviamo in presenza di una favola e, come dovrebbero essere tutti gli scritti di questo genere, con una morale ben precisa. Luomo non deve sovrapporsi alla natura, ma vi si deve adattare, come questo popolo freddo che da centinaia di anni resiste al gelo e alla neve, anche destate, al vento fortissimo, a temporali spaventosi e perfino alle valanghe, imparando di volta in volta qualche cosa e traendo così unesperienza, da trasmettere ai posteri, per la continuazione della specie. Guai a chi, per sete di guadagno, vuole forzare la natura, perché questa si scatenerà e a farne le spese saranno solo e sempre gli esseri umani, come testimoniato dalle tragedie che colpiscono ogni anno diversi stati, compreso il nostro. La morale è quindi evidente e senzaltro condivisibile; però mi chiedo una cosa: per esprimere questo concetto così importante che bisogno cera di scrivere la bellezza di 235 pagine? Peraltro, la narrazione, sempre così dinamica nei testi di Corona, qui è monocorde, quasi una nenia ossessivamente ripetuta. Lassenza poi di dialoghi e questo modo di esporre, imbastendo una vicenda con frequenti ripetizioni, finisce con lannoiare chi legge, tanto che mi è venuta la tentazione più volte di chiudere il libro a dove ero arrivato, non andando più oltre. Quello che mi spiace maggiormente è che lidea di fondo è buona, ma purtroppo sviluppata male, con una trama debole che, a differenza di altri romanzi dellautore ertano, si trascina diciamolo francamente in modo penoso. Poi può anche darsi che questo mio giudizio così drastico sia del tutto errato, visto che lopera è finalista a un premio prestigioso come il Campiello di questanno; resta però un fatto e cioè che uno come me, che ha trovato sempre appassionanti i romanzi di Corona, questa volta è arrivato allultima pagina con estrema fatica, nella continua e inutile speranza che qualche cosa cambiasse, che oltre agli uomini freddi anche lautore diventasse un po meno gelido.
Mauro Corona
è
nato a Erto (Pordenone) nel 1950.
21/8/2014
La pazienza di Maigret Traduzione di Margherita Belardetti
Adelphi Edizioni Narrativa romanzo
Un Maigret rilassato Passano gli anni, Maigret è ormai un uomo attempato che da lì a un paio di anni dovrà forzatamente andare in pensione, lasciare quellufficio e quella poltrona al Quai des Orfévres dove è stato per lungo tempo. Dove andrà poi? Nella casetta di Meung sul Loire, che con la moglie va sistemando da diversi anni e dove la domenica precedente, cioè il giorno prima, è stato a zappare lorto e, stanco, ma rilassato, a fare una bella dormita pomeridiana coricato su unamaca. Oggi è lunedì e lui, sereno e tranquillo va al lavoro, ma senza fretta, senza impazienza e di pazienza ne dovrà aver molta per venire a capo di un nuovo caso che gli si prospetta proprio quella giornata con lomicidio di un anziano gangster, apparentemente in pensione, e con il prosieguo delle indagini quasi ventennali su misteriose rapine a gioiellerie. La pazienza di Maigret è un giallo che si fa apprezzare, più che per la trama, per lapprofondita caratterizzazione dei personaggi, per lambientazione quasi filmica e per latmosfera che lo permea. Il celebre commissario, calmo più del solito, tesse una ragnatela con cui avvolgere lentamente e inesorabilmente i colpevoli sia del delitto che delle rapine. Ci sono pagine che poco hanno a che fare con un giallo e che tuttavia danno spessore allopera, come per esempio il pranzo in un bistrot con il giudice Ancelin, un nuovo personaggio che è entusiasta dellabilitò poliziesca di Maigret e che con la sua modestia desta subito simpatia. In questa trattoria, economica, ma dai sapori tradizionali, dove le tovaglie sui tavoli sono costituite da rettangoli di carta goffrata, il menù di giornata scritto con il gesso su una lavagnetta già solletica il palato, perché se ignoro come siano le terrine del Morvan, lossobuco con lenticchie richiama piatti tradizionale della mia regione. E pare di vedere i due fare onore al cibo in questo ambiente semplice e popolare. Non bastasse questo, poiché lomicidio è stato commesso nellappartamento di un condominio, lindagine svolta da Maigret si sviluppa anche con le visite agli inquilini, una serie di ritratti talmente riuscita da ritagliare un angolo, nemmeno nascosto, sul palcoscenico della vicenda. Piano piano, con pazienza, Maigret si trasforma da ragno in gatto, per giocare con i sospetti topolini e praticamente per chiuderli in un angolo, da cui invano si sforzeranno di uscire. Come di prammatica alla fine il commissario riuscirà a prendere due piccioni con una fava, lasciando al giudice Ancelin il privilegio di decidere chi dei due sia lassassino, anche se entrambi colpevoli comunque per le rapine alle gioiellerie. Da leggere.
Georges Simenon,
nato a Liegi nel 1903, morto a Losanna nel 1989,
ha lasciato
centonovantatre romanzi
pubblicati sotto il suo nome e un numero imprecisato di romanzi e
racconti pubblicati sotto pseudonimi, oltre a volumi di «dettature» e
memorie. Il commissario Maigret è protagonista di 75 romanzi
e 28 racconti, tutti pubblicati fra il 1931 e il 1972. Celebre in
tutto il mondo, innanzitutto per le storie di Maigret, Simenon è
anche, paradossalmente, un caso di «scrittore per scrittori». Da
Henry Miller a Jean Pauhlan, da Faulkner
a Cocteau, molti e disparati sono infatti gli
autori che hanno riconosciuto in lui un maestro. Tra questi, André
Gide: «Considero Simenon un grande romanziere, forse il più grande e
il più autentico che
la letteratura
francese abbia oggi»; Walter Benjamin: «
leggo ogni nuovo romanzo di
Simenon»; Louis-Ferdinand Céline:
«Ci sono scrittori che ammiro moltissimo: il Simenon dei Pitard,
per esempio, bisognerebbe parlarne tutti i giorni».
19/8/2014
Amore mio uccidi Garibaldi
Longanesi Editore
Un autentico gioiellino Forse sarà per letà che mi porta a guardare indietro anziché in avanti, forse sarà perche le storie familiari, specie di unepoca lontana, mi sono sempre piaciute, comunque sta di fatto che questo Amore mio uccidi Garibaldi mi ha affascinato. Di per sé può sembrare una storia come tante altre, di un periodo particolare della vita di due coniugi, ma lepoca storica (è lanno 1866), lambientazione, le atmosfere e indubbiamente la mano felice dellautrice sono riuscite a trasformarla in un vero e proprio gioiellino. E credo che in larga parte non sia frutto dinvenzione, poiché qui Isabella Bossi Fedrigotti racconta del bisnonni paterni, vale a dire del conte Fedrigo Fedrigotti, e della principessa Leopoldina Lobkowitz, il primo un italiano di Rovereto in quel tempo ancora austriaca, la seconda boema di un nobile casato di grandi proprietà terriere. Sembra quasi che la terra unisca questi due esseri in un comune destino, ma su piani completamente diversi, perché Fedrigo è un piccolo nobile di campagna, appassionato agricoltore, ma con ben pochi mezzi finanziari, la seconda è una donna che fatica a trovare marito, pur essendo parte di una famiglia assai ricca. Ma se lincontro fra Fedrigo, avvenuto a Vienna quando lì si trovava con il suo reggimento di Ussari (era sottotenente di seconda classe), e Leopoldina, reduce da una promessa di matrimonio venuta meno, può sembrare frutto di calcoli di convenienza di diversa natura, la loro unione dimostrerà negli anni che alla radice del vincolo coniugale ci sono passione e amore. Sono due personaggi che singolarmente non brillano in modo particolare, ma insieme rilucono di una luce viva e dire che sembrano fatti per luno per laltra può apparire perfino superfluo, tante sono le occasioni e i comportamenti che inducono a credere che siano stati una coppia felice. Lonestà e la dignità di Fedrigo, la capacità di Leopoldina di saper rinunciare agli agi, se pur sono virtù innate, si rafforzano nellamore che li lega, un amore che li porta, pur fra tante difficoltà, a superarle, a lottare non tanto per se stessi, ma per la loro famiglia, allargata dalla nascita di un maschietto e di una femminuccia. Nel contesto di questa storia assume particolare rilievo la terza guerra dIndipendenza, quella per intenderci che vide le nostre sconfitte a Custoza in terra e a Lissa in mare. In un Trentino in cui si parla quasi solamente litaliano, le idee risorgimentali sembrano fare breccia di più fra la classe borghese e i nobili, fatta eccezione per Fedrigo, fedele al suo imperatore; lidea di un Tirolo italiano non attecchisce invece fra la povera gente, fra i contadini, la cui fedeltà agli Asburgo forse deriva dal fatto che lesperienza insegna che, cambiando padrone, nulla muta (e solo se va bene) nella loro condizione. Lesercito italiano, sconfitto sul campo, si riscatta con Garibaldi e le sue Camicie Rosse, che,, adottando la tattica della guerriglia, scorrazzano nelle valli Giudicarie e in Val di Ledro. Il generale e i suoi soldati, con la loro passione, che li porta a superare ogni ostacolo, sembrano rappresentare metaforicamente lavvento di un nuovo mondo, in continua evoluzione, in netto contrasto con limmobile e spento impero austriaco, il cui declino è già da tempo iniziato e si concluderà assai più tardi nel 1918 a Vittorio Veneto. Fedrigo e Leopoldina sono parte di di questo stato ormai inerte, incapace di trovare nuovi slanci per rinnovarsi; temono i briganti garibaldini e lui si arruolerà volontario per combatterli. Inizia una fitta corrispondenza fra marito e moglie, un abile espediente per raccontarci di questa guerra e di un mondo che lento si spegne sulle note dei valzer viennesi. Amore mio, uccidi subito questo Garibaldi scrive Leopoldina, come se sopprimendo un uomo si potesse risolvere il problema di una inarrestabile decadenza. Ovviamente Fedrigo non sopprimerà il capo dei briganti, ma dopo larmistizio, beneficiando di una campagna militare in cui tuttavia non ha sparato colpi, assumerà incarichi importanti e ben remunerati. Sia lui che Leopoldina, visceralmente anti italiani, chiuderanno gli occhi prima dellinizio della Grande Guerra e del crollo drammatico dellImpero. Il romanzo, che si legge con facilità e con grande piacere, è veramente bello, affascinante e commovente al tempo stesso, e ha inoltre il grande pregio di essere un preciso e interessante quadro storico. Da leggere, ovviamente.
Isabella Bossi Fedrigotti,
nata a Rovereto da madre austriaca, è giornalista al Corriere
della Sera. Con il romanzo Casa di guerra (1983) è stata
finalista al Premio Strega e al Campiello. Il successo al Premio
Campiello è arrivato nel 1991 con il terzo romanzo, il bestseller Di
buona famiglia. Altri titoli sono Il catalogo delle amiche (Rizzoli,
1998), Cari saluti (Rizzoli, 2001), La valigia del signor
Budischowsky (Rizzoli, 2003) e Il primo figlio (Rizzoli,
2008).
16/8/2014
Le mie montagne
Giangiacomo Feltrinelli Editore Non solo montagne "Come Dino Buzzati potrei scrivere che 'tutte le mattine della vita, alzandomi dal letto e affacciandomi alla finestra della mia camera, ho visto una cerchia di monti. I monti della mia esistenza, stampati non solo nella memoria ma nel profondo delle coscienza, da quei monti strettamente condizionato'. Su quei monti ho conosciuto le guerre della mia vita, la fascista e la partigiana, i miei nemici e i miei maestri, fra cui ritorno in queste pagine". Accade sovente di non leggere lintroduzione di un libro, per svariato motivi, non ultimo quello che la si ritiene forse superflua, o piuttosto capace di influenzare a priori il giudizio. Nel caso di Le mie montagne. Gli anni della neve e del fuoco è invece più che opportuno dare unocchiata allintroduzione, stilata dalle stesso autore, perché così è possibile comprendere lo spirito dellopera, caratterizzata da diversi articoli che solo a prima vista sembrano non avere un filo comune. Giorgio Bocca ha dedicato alle sue montagne un monumento stampato, rilievi inerti nel tempo, ma intorno ai quali ha corso, corre e continuerà a correre la storia. In queste pagine non cè nulla dinventato di sana pianta, ma vengono narrate esperienze personali in relazione a tutto ciò che ha a che fare appunto con le montagne. E così, suddiviso il libro in nove capitoli sulla base delle tematiche, troviamo gli scritti sui primi mesi di guerra sul fronte francese delle Alpi, in cui lo spirito acuto e ironico di Bocca evidenzia ancora una volta la fatuità del fascismo, tutto fumo e niente arrosto, con unimpreparazione bellica che a volte porta perfino a ridere. E poi cè lepoca successiva, cioè quella che si snoda dall8 settembre 1943 al 25 aprile 1945, con questi monti che sono teatro della resistenza, a cui lautore partecipò attivamente, diventando anche un comandante di brigata delle formazioni Giustizia e Libertà. Sempre nelle terre di quei rilievi, oltre alla natura splendida descritta nei capitoli Noi del Monte Bianco e Gli anni degli sci veloci non potevano mancare i personaggi, più noti come Mattei ed Einaudi, e altri quasi sconosciuti, ma non meno interessanti, come Mascarello, il coltivatore di vigneti. Per uno come Bocca, abituato a vivere lontano dalla grande città, la provincia, con il suo mondo chiuso, ma più a misura duomo, rappresenta unoasi di pace al punto da dedicarle un intero capitolo, così come ampia è la trattazione di quel torrente che scende dal Monviso e attraversa tutta la pianura padana, ingrossando sempre più, per finire in Adriatico. Sono belle le descrizioni del corso del Po e della montagna da cui nasce e lautore ha saputo cogliere anche lo spirito delle genti che si affacciano sulle sue sponde. Fiume maestoso, ora ridotto a una fogna a cielo aperto, può sembrare il ritratto di un amico pacioso, ma guai se le piogge autunnali lo gonfiano, perché allora può diventare cattivo e al riguardo riuscito è larticolo sulla famosa alluvione del Polesine; si respira quasi lacqua, immersi nel grigio del cielo e nel marrone torbido dellacqua, palpabile è il dramma, con la gente arrampicata sugli alberi ad attendere i soccorsi, nel freddo di novembre, gente per lo più già povera e ora misera del tutto. Però, Bocca non vuole essere incline alla tristezza e infatti il libro si conclude con uno scritto dedicato alla nazionale di calcio trionfatrice ai mondiali del 1934 e del 1938. Ci si chiederà che cosa centri la nazionale con le montagne ed è presto detto: il suo famoso allenatore Vittorio Pozzo era piemontese ed era un montanaro. Lautore, tuttavia, analizza con disincanto anche il tifo calcistico di quellepoca e dellattuale, concludendo amaramente con queste parole: Notti magiche, notti roventi. La riscoperta di un nazionalismo senza nazione, di un patriottismo senza patria, di unetica senza morale. Un caos appassionante dietro una palla che va dove vuole.. E un ritratto perfetto di noi italiani, una sintesi memorabile, forse impietosa, ma che risponde al vero. Il libro si legge che è un piacere e quindi non posso che consigliarlo, perché si tratta di unopera ottimamente riuscita.
Giorgio Bocca
(Cuneo, 1920 - Milano, 2011) è stato tra i giornalisti italiani più
noti e importanti. Ha ricevuto il premio Ilaria Alpi alla carriera
nel 2008. Tra le sue opere ricordiamo: Storia
dellItalia partigiana (1966); Storia
dItalia nella guerra fascista (1969); Palmiro
Togliatti (1973); La
Repubblica di
Mussolini(1977); Linferno.
Profondo Sud, male oscuro (1993).
Con Feltrinelli ha pubblicato Piccolo
Cesare (2002), Basso
Impero (2003), Partigiani
della montagna (2004), LItalia
lè malada (2005), Napoli
siamo noi (2006), Le
mie montagne (2006), Il
provinciale (2007), È
la stampa, bellezza! (2008),Annus
horribilis (2010), Fratelli
coltelli (2011), Grazie
no. Sette idee che
non dobbiamo più accettare (2012)
e Storia dellItalia
partigiana (2012). Ha
raccontato la sua appassionante vicenda biografica nel
film-intervista di Maria Pace Ottieri e Luca Musella La
neve e il fuoco. Giorgio Bocca si racconta (2011),
edito nella collana Real Cinema/Feltrinelli.
13/8/2014
La moneta di Akragas In copertina: Jean-Pierre Laurent Houël Il tempio di Giunone ad Agrigento (Parigi, Museo del Louvre)
Skira Editore Narrativa romanzo
Un giallo numismatico È indubbiamente strano questo romanzo breve di Camilleri: inizia con una specie di premessa, a metà fra il saggio e il romanzo storico (corre lanno 406 a.C., allorché Akragas viene conquistata e distrutta dai cartaginesi), si sviluppa come giallo in unepoca di molto successiva (siamo nel 1909) e si conclude come una favola, in cui è vero che manca la famosa frase e vissero tutti felici e contenti, ma è sottintesa. Forse è un po troppo in sole 136 pagine, però lautore siciliano, come riportato in una Nota finale, ha inteso raccontare una cronaca, o leggenda familiare, secondo la quale un lontano parente, lontano anche nel tempo, che era medico e appassionato di numismatica ebbe la fortuna di incontrare un giorno un contadino che gli fece vedere, con lo scopo di fargliene dono, una monetina doro che aveva trovato zappando il terreno. Il dottore la riconobbe subito, era la favolosa piccola Akragas; fece per prenderla, ma per la fretta e lemozione cadde da cavallo rompendosi una gamba. Sempre secondo questa cronaca, o leggenda, il medico regalò successivamente la moneta al Re Vittorio Emanuele III che ne era interessato e che contraccambiò con lonorificenza di Grande Ufficiale. Precisa Camilleri che il resto è stato tutto inventato, ma solo dopo che Eileen Romano delleditore Skira aveva fatto opportune ricerche, concludendo che questa cronaca poteva anche non essere solo una leggenda. La precisazione è dovuta e opportuna, perché volta a dimostrare che il contenuto del libro ha unorigine non di pura e semplice creatività, creatività che invece lautore profonde a piene mani realizzando un giallo in piena regola con un investigatore atipico, vale a dire proprio il famoso medico. Premetto che non ci troviamo di fronte a un capolavoro, ma solo a un buon libro e, considerando la considerevole produzione letteraria di Camilleri, direi che non è poco, visto che con tante opere non tutte possono riuscire al meglio. Nel caso specifico la qualità non si discute, lo stile è quello accattivante tipico dellautore siciliano, la vicenda stessa si evolve secondo un filone logico consolidato e che porta alla scoperta del colpevole (in questo caso è un assassino) in modo del tutto convincente; quello che eventualmente stona è quel finale favolistico e passi per lonorificenza, che potrebbe anche rispondere a verità, ma tutta la generosità di Vittorio Emanuele III, notoriamente tirchio, non ci sta. Al lettore certo non può che far piacere un lieto fine, ma questo, così come congegnato da Camilleri, è una forzatura. Si legge, comunque, volentieri e, data anche la relativa lunghezza, in poche ore; in tal senso può costituire unopportunità di svago, senza necessità di impegnarsi troppo e magari sorvolando su una conclusione mielosa che è lunico aspetto fuori luogo di questo romanzo. Andrea Camilleri (Porto Empedocle, 1925), regista di teatro, televisione, radio e sceneggiatore. Ha insegnato regia presso lAccademia Nazionale dArte Drammatica. Ha pubblicato numerosi saggi sullo spettacolo e il volume, I teatri stabili in Italia (1898-1918).
Il suo primo romanzo, Il
corso delle cose, del 1978, è stato trasmesso in tre puntate
dalla TV col titolo La
mano sugli occhi. Con questa casa editrice ha pubblicato: La
strage dimenticata (1984), La
stagione della caccia (1992), La
bolla di componenda (1993), Il
birraio di Preston (1995), Un
filo di fumo (1997), Il
gioco della mosca(1997), La
concessione del telefono (1998), Il
corso delle cose (1998), Il
re di Girgenti (2001), La
presa di Macallè (2003), Privo
di titolo (2005), Le
pecore e il pastore (2007), Maruzza
Musumeci(2007), Il
casellante (2008), Il
sonaglio (2009), La
rizzagliata (2009), Il
nipote del Negus (2010,
anche in versione audiolibro), Gran
Circo Taddei e altre storie di Vigàta (2011), La
setta degli angeli(2011), La
Regina di Pomerania e altre storie di Vigàta (2012), La
rivoluzione della luna (2013), La
banda Sacco (2013), Inseguendo
un'ombra (2014); e inoltre i romanzi con protagonista il
commissario Salvo Montalbano: La
forma dell'acqua (1994), Il
cane di terracotta (1996), Il
ladro di merendine (1996), La
voce del violino (1997), La
gita a Tindari (2000), L'odore
della notte (2001), Il
giro di boa (2003), La
pazienza del ragno (2004), La
luna di carta (2005), La
vampa d'agosto (2006),Le
ali della sfinge (2006), La
pista di sabbia (2007), Il
campo del vasaio (2008), L'età
del dubbio(2008), La
danza del gabbiano (2009), La
caccia al tesoro (2010), Il
sorriso di Angelica (2010), Il
gioco degli specchi (2011), Una
lama di luce (2012), Una
voce di notte (2012), Un
covo di vipere (2013), La
piramide di fango (2014).
10/8/2014
Quota Albania
Edizioni Einaudi Il primo anno di guerra Dallautore di Il sergente nella neve, romanzo celeberrimo sullesperienza dello stesso nel corso della tragica ritirata di Russia, questa nuova opera é la ricostruzione di un anno di guerra, dalla primavera del 1940 a quella del 1941, con due campagne militari, quella di Francia e quella di Grecia. Lo stile scarno, quasi essenziale, rende ancor più drammatiche le scene belliche, soprattutto quelle sui monti innevati dellAlbania, e testimonia ancora una volta di più la follia di un regime, del tutto impreparato a un conflitto moderno, ma che volle egualmente prendervi parte per poter sedere con pochi morti al tavolo della pace. E invece, come sappiano, la guerra non fu breve e le vittime furono tante, anche sul fronte greco-albanese. La narrazione di Rigoni Stern, frutto sue delle annotazioni su due taccuini in questo primo anno di guerra, evidenzia la rassegnazione del soldato italiano a cui si è sempre chiesto troppo in cambio di poco o niente. Le lunghe marce nella neve, il fango che tutto inghiotte, il freddo, la fame, le precipitose ritirate rivivono in queste pagine, non di rado commoventi, anche se lautore non calca il piede sullacceleratore dellemozione; però, si tratta di vita vissuta, di patimenti provati veramente, anche se inferiori a quelli della disperata ritirata di Russia, e quindi il lettore finisce con lessere coinvolto emotivamente. Rigoni Stern non giudica, osserva, annota, si sofferma di tanto in tanto sulla bellezza di quella natura a lui tanto cara, pause di poesia nel fragore degli scoppi e delle urla dei feriti. È già evidente la sfiducia nei confronti di un governo dispotico e anche fellone, ma ciò nonostante questi uomini, che lottano ogni minuto, con armamenti e vestiario inadeguato, compiono il loro dovere di soldati e, soprattutto, di alpini. Non cè odio nei confronti del nemico, dal volto sempre anonimo e si uccide per non essere uccisi, senza eroismi se non quello di una continua quasi inimmaginabile sopportazione della fame, del freddo e delle fatiche. Lautore, che è un portaordini, corre su e giù per questi monti, spesso la notte, ma a volte anche di giorno e negli orari più impensabili, perché gli ordini del comando devono essere trasmessi, in mancanza di radio funzionanti bloccate dal gelo. È giovane e non stima ancora il pericolo, tanto che il suo comandante, un colonnello che ama bastonare i sottoposti, ma che ha già capito che la guerra sarà per tutti unimmensa tragedia, un giorno paternamente gli dice: Io sono ormai vecchio. Tu sei un ragazzo. Devi vivere. Le poche notizie da casa, le lettere che non arrivano più da una ragazza di Venezia di cui è innamorato - ma che non fa per lui secondo i genitori di lei, di ceto sociale ben più elevato -, lamicizia virile che aiuta a tirare avanti, il disprezzo per la viltà delle camicie nere che fuggono davanti al nemico senza combattere, la gioia che si prova quando tutti insieme ci si può mettere intorno a un fuoco a mangiare qualcosa, magari solo delle pannocchie di granturco, sono tutti momenti che rivivono in queste pagine, e sono talmente ben descrittii che il lettore ha limpressione di essere presente. Lopera è molto bella, anche se leggermente inferiore a Il sergente nella neve, ma tutte le eccelse qualità di scrittore di Rigoni Stern emergono nitide facendo sì che la lettura sia sempre gratificante.
Mario Rigoni Stern (Asiago
1921-2008) ha esordito nel 1953 con Il
sergente nella neve. Ricordi della ritirata di Russia (ultima
edizione «Super ET» 2008), uno dei libri più significativi del
dopoguerra. Sempre presso Einaudi, ha poi pubblicato: Il
bosco degli urogalli(1962), Quota
Albania (1971), Ritorno
sul Don (1973), Storia
di Tönle(1978, Premio Campiello), Uomini,
boschi e api (1980), L'anno
della vittoria (1985), Amore
di con fine (1986), Il
libro degli animali (1990),
Arboreto salvatico (1991), Le
stagioni di Giacomo (1995), Sentieri
sotto la neve (1998), Inverni
lontani (1999 e 2009), Tra
due guerre (2000),L'ultima
partita a carte (2002
e 2009), Aspettando
l'alba e altri racconti(2004), I
racconti di guerra (2006)
e Stagioni («L'Arcipelago
Einaudi» 2006, «Super ET» 2008 e «Numeri Primi» 2012). Il suo ultimo
libro, pubblicato postumo nel 2008, è la sceneggiatura del Sergente
nella neve, scritta con Ermanno Olmi.
6/8/2014
Nome di battaglia: Diavolo
Marsilio Editori Storia
Una vicenda allucinante Nei quattro anni che seguirono la fine della seconda guerra mondiale, in un paese come il nostro che era stato dilaniato da una lotta fratricida e che vedeva contrapporsi ora i filoamericani ai filosovietici, non pochi furono gli atti di violenza, frutto spesso da un insano desiderio di vendetta. In particolare, nellEmilia vi fu una zona, ricompresa fra Bologna, Reggio Emilia e Ferrara che venne chiamata Triangolo della morte o anche Triangolo rosso, in cui partigiani e militanti di formazioni comuniste uccisero allincirca 4.500 persone. Il tale contesto il 18 giugno 1946 viene assassinato con un colpo di pistola Don Umberto Pessina, parroco di San Martino Piccolo, in provincia di Reggio Emilia. A prima vista può sembrare uno dei tanti atti di violenza che funestano la zona ed è così, ma ciò che lo differenzia da altri tragici analoghi episodi è la reazione nelle gerarchie ecclesiastiche, perché la Chiesa e il Vaticano colgono loccasione per cercare in qualsiasi modo un colpevole, ma non il colpevole o un colpevole qualunque, bensì uno che serva a sostenere la campagna anticomunista così cara a Pio XII. Allo scopo un grande inquisitore viene trovato in monsignor Beniamino Socche, vescovo di Reggio Emilia, che, con laiuto non certo disinteressato dellinvestigatore capitano Vesce (in seguito diventerà generale dei carabinieri, ottenendo anche unaltissima onorificenza vaticana) e in presenza di un sistema giudiziario che ancora risente della dipendenza politica propria del fascismo, ha per le mani il capro espiatorio ideale. E non è un personaggio sconosciuto, ma un valoroso comandante partigiano (nome di battaglia Diavolo), sindaco comunista di Correggio, stimato anche dagli avversari per la sua rettitudine e lealtà. Viene imbastita così una tela di ragno per accusare del delitto Germano Nicolini, perché così si chiama questuomo di grandi qualità, un comunista non ortodosso, cioè non privo di idee liberali, un buon cristiano, ma non deferente verso una chiesa che troppo ha spartito con il fascismo, un abile stratega militare, ma anche un pacificatore, visto che in quei difficili anni, in cui la maggior parte della gente faceva la fame, istituisce una mensa che possa garantire un pasto al giorno a tanti ex partigiani disoccupati e poveri, e non solo a loro, ma anche agli ex nemici, pesci piccoli che mai si erano macchiati di nefandezze. Così fra false testimonianze, verbali di interrogatori contraffatti, testimonianze vere (come quelle di due dei tre colpevoli), ma che vengono dichiarate false nonostante levidenza dei fatti, il povero Nicolini viene incarcerato, insieme ad altri due disgraziati. La condanna, in tutti i gradi, era scontata, perché nessun elemento probatorio a discarico, benché inoppugnabile, venne accolto, mentre invece le prove di colpevolezza, evidentemente artefatte, furono sempre sostenute e considerate vere. I tre vennero condannati a 22 anni di reclusione, di cui ne furono scontati per fortuna solamente dieci. Oltre al teorema accusatorio del tutto infondato, vi è da rilevare lo strano silenzio del Partito Comunista, che preferì lasciar condannare degli innocenti invece di fare i nomi dei veri colpevoli che ben conosceva. Del resto Nicolini, per quanto famoso, era troppo democratico per essere considerato un autentico comunista staliniano e troppo rivolto a sinistra per classificarlo come un uomo di centro, tutte circostanze che giocarono a suo sfavore. Non fecero però i conti con un essere umano che, più di ogni altra cosa al mondo, desiderava dimostrare la sua innocenza. Con levoluzione politica che portò prima alla fine dello stalinismo, poi a quella dellUnione Sovietica, e con il consolidarsi della democrazia nel nostro paese che condusse a unautentica autonomia dellapparato giudiziario si vennero così a creare i presupposti per pervenire a una seria ricerca della verità. . Si dovrà attendere tuttavia il 1994, allorché alla luce di nuove prove e anche della confessione di uno dei tre veri colpevoli il caso venne riaperto, ci fu un nuovo processo e la piena assoluzione per non aver commesso il fatto. Frediano Sessi ha saputo porre mano alla vicenda assai intricata, riuscendo a delineare un quadro della situazione e di tutto ciò che accadde con encomiabile completezza, dando luogo a un libro che è sì un saggio storico, ma che si svolge incalzante come un romanzo, punteggiato dalle puntuali e condivisibili osservazioni dellautore che ha il pregio nelle prime pagine, più introduzione che capitolo, di saper ben delineare la situazione dellItalia nel primo dopo guerra, documento indispensabile per comprendere il perché di tante violenze. Scorrevole, per nulla greve, Nome di battaglia: Diavolo è uno di quei libri che si leggono con piacere, anche se poi rimane dentro una sorta di rabbia per tanta ingiustizia che nemmeno la piena assoluzione dellultimo processo riesce a mitigare.
Frediano Sessi
vive e lavora a Mantova. Tra le sue pubblicazioni ricordiamo Il
ragazzo Celeste (1991),Ritorno
a Berlino (1993), Lultimo
giorno (1995), Alba
di nebbia (1998), Nome
di battaglia: Diavolo (2000),
Prigionieri della memoria (2006,
due edizioni), Foibe
Rosse (2007, due
edizioni), Il segreto
di Barbiana(2009) e con Carlo Saletti Visitare
Auschwitz (2011, due
edizioni) tutti editi da Marsilio. Sempre per Marsilio ha curato il
saggio di Michel Mazor La
città scomparsa(1992). È autore inoltre dei romanzi per ragazzi
Ultima fermata: Auschwitz (1996), Sotto
il cielo dEuropa (1998)
e Il mio nome è Anne
Frank (2010), editi
da Einaudi, per cui ha curato anche ledizione italiana definitiva
del Diario di Anne
Frank (1993) e il Dizionario
della Resistenza (2000).
Nel 1999 è stato pubblicato il suo saggio La
vita quotidiana ad Auschwitz (Rizzoli,
tredici edizioni).
3/8/2014
Finché il cuculo canta
Disegni di Matteo Corona Narrativa raccolta di racconti
In armonia con la natura Di sera, riscaldati da un fuoco di mughi, nella remota casera Galvana parlavamo un po di tutto: della fortuna, della salute, dei soldi, dei figli, della vita, insomma. Mi lamentavo per lingiustizia del mondo, della mia poca fortuna che in realtà è molta e della sua che è davvero poca. << Non lamentarti disse Ottavio finché il cuculo canta e lo puoi sentire va tutto bene>> Testimone e superstite di un mondo arcaico, in cui luomo era parte integrante e rispettosa della natura, Mauro Corona è approdato al secondo millennio dopo una vita travagliata, dopo la tragedia del Vajont, grazie a una sua filosofia dellesistenza che sa cogliere in ciò che spesso ci rifiutiamo di vedere, o guardiamo superficialmente, un senso profondo che non solo aiuta a tirare avanti, ma consente anche che ciò avvenga con gioia. I profondi silenzi dei boschi in inverno, il fruscio dei ruscelli, la compagnia di autentici amici, la volontà di realizzare realizzando se stessi sono fondamenta inalienabili che reggono solidamente la debole struttura dellesistenza, una scelta di vita non scevra di difficoltà, ma capace di infondere gioia e speranza. Con questa raccolta di racconti Mauro Corona si avvicina ulteriormente alle scelte narrative di un altro grande montanaro, Mario Rigoni Stern, con la capacità, parlando di se stesso, di parlare di tutti gli uomini, dei loro sogni, delle loro paure, delle loro aspirazioni. Sono venti prose, una più bella dellaltra, venti memorie di un tempo che è stato e che probabilmente ma più ritornerà, e in cui la natura è al centro dello svolgimento, perché anche dove sembra che il dominus sia luomo alla fin fine questi non è che un attore che interpreta una parte che al più è da spalla della protagonista, dellassoluta bellezza del creato, delle notti stellate, dei picchi assolati, delle distese di mughi. Lo stile è quello a cui ci ha abituato: scorrevole, né lento né veloce, con ogni tanto qualche pausa breve destinata a un approfondimento. Tante sono le storie raccontate di cui lautore è stato testimone diretto o indiretto e a volte si avverte, ancora dopo anni, lemozione originariamente provata, come nel caso di un racconto particolarmente bello e commovente:La camoscina. Non intendo svelare nulla, ma Corona è capace con quella semplice naturalezza che è propria della poesia di toccare le corde del cuore, non di sfiorarle, bensì di pizzicarle, affinché abbiamo lopportunità di riscoprire in noi quellintima bontà che la furia del progresso pare avere cancellato. E se alcune prose possono apparire meno interessanti, come quelle relative ad alcune sue scalate, dico solo di leggerle con attenzione, perché si finirà con lo scoprire che dietro lindomito alpinista esiste luomo, a tratti spavaldo, più spesso timoroso e sempre, dico sempre, estasiato dalla natura. Temevo che questi racconti, in fondo di vita vissuta, non fossero allaltezza dei suoi romanzi, permeati da una misticità naturale, e invece, con piacere, ho dovuto ricredermi, convincendomi una volta di più che Mauro Corona è uno scrittore di razza, uno di quelli che forse anche nelle opere minori e questa non lo è lascia un segno che non si cancella. Quindi il mio invito è di leggere Finché il cuculo canta, piacevole sotto tutti gli aspetti e in grado di portare, attraverso un crescente entusiasmo, a uno stato di gioiosa serenità.
Mauro
Corona è
nato a Erto (Pordenone) nel 1950.
31/7/2014
Viaggio nella Poesia
Edizioni Helicon Poesia poema Un poema moderno Tutto mi sarei aspettato da Franca Canapini, artista capace di percorrere una linea poetica autonoma, come dimostrato dalle eccellenti prove con Stagioni sovrapposte e confuse e, soprattutto, con Il senso del sempre, tutto ripeto mi sarei aspettato - e con quel tutto intendo una silloge di argomento piuttosto impegnativo - fuorché un poema. Se si presenta arduo scrivere un poemetto, ancor più complessa è la realizzazione di un poema, perché si tratta di una composizione in versi di carattere narrativo, in cui si svolge un determinato tema. Tanto per intenderci poemi sono lIliade, lOdissea, lEneide, con i quali sono narrate storie che in epoca moderna sarebbero più facilmente scritte come romanzi. Nel caso specifico di Franca Canapini non cè ovviamente la pretesa di gareggiare con Omero o con Virgilio, ma il tentativo di riproporre una forma oggi del tutto inusuale; e come le opere di questi maestri oggetto di studio scolastico la struttura di Viaggio nella Poesia è similare, con unInvocazione, il corpo centrale e infine lepilogo. Da Invocazione Dammi parole, Apollo / lilluminazione grande / ché possa ricordarmi che cero / di simbolo in simbolo in simbolo; / restituiscimi la forza / per dare voce alle pietre di Carnac / a Michel doro sulla vetta / agli dei silenziosamente affranti / ai fiumi tumultuosi / delle foreste mute. / . Si tratta del riconoscimento delle difficoltà per lopera da intraprendere, uno sforzo immane impossibile senza laiuto di unEntità superiore, a cui quindi ci si rivolge così come sovente si prega. E indubbiamente il compito è improbo perché, come dice il titolo, è un viaggio dentro la poesia, una sorta di discesa progressiva nel nerbo della stessa, alla ricerca di nuove conoscenze e, in particolare, per scoprirne e identificarne le origini. E se tale percorso comporta un ritorno al passato, alla rivisitazione dellinfanzia, il poema non è scevro da rapidi, a volte improvvisi ritorni a un presente in cui germoglia il seme del futuro. Cè una spiccata originalità, pur permeata a tratti da un istinto epico, e a volte da un riuscito afflato danima ( / Ed ecco la neve /.- ancora la neve / che smussa i colori / i vertici addolcisce e ricama. / ). Sono versi che, per certi aspetti, sembrerebbero ispirati da un Pascoli in un momento di rara felicità, ma la lispirazione è una cosa e la realizzazione è unaltra, così che prevale unautonoma inclinazione che sintetizza dialetticamente il concetto e la situazione che si intendono esprimere, in forma moderna, gradevole e di non difficile interpretazione. E lungo questo viaggio, che sostanzialmente si svolge nellaccostare idealmente il lontano passato e il presente, ed è così che al rapimento di Proserpina si affianca un auto rapimento per amore. Non manca poi una discesa agli Inferi, con una Euridice dei nostri tempi e con il capitolo finale non a caso intitolato I fiori di Proserpina. Oserei dire che Franca Canapini, anziché scendere nel passato del mito ha preferito riportare questo allepoca attuale, realizzando questo poema che è essenzialmente una grande storia di amore immaginato, un impulso improvviso che lha convinta a esaminarsi, a intraprendere questo viaggio, a volte tumultuoso, altre bucolico, dentro se stessa. Non siamo più abituati a leggere poemi, perché ormai non se ne scrivono più, ma se uno cè, ed è questo, se vogliamo riprovare il piacere, pur se accompagnato da una certa fatica, di perderci nelle pagine di un libro, vagando con la mente sul mormorio dei versi, ecco, il poema è servito e sarete accontentati, certo che alla fine sarete pure soddisfatti.
Franca Canapini è
nata, il 17 ottobre 1951, a Chianciano Terme (Si). Dal 1977 vive, con
la sua famiglia, ad Arezzo, dove ha svolto lattività di insegnante
di Lettere. è membro del Consiglio direttivo dellAssociazione Tagete
(Associazione degli Scrittori Aretini) e nel 2013 ha fatto parte
della giuria del Premio Tagete per la Poesia.
13/7/2014
La regina di Pomerania di Andrea Camilleri
Sellerio Editore Palermo
Narrativa raccolta di racconti
Si ride e ci si commuove Inizia lestate, il caldo opprime la giornata, magari si sta in spiaggia e appare necessario far scorrere il tempo, possibilmente nel miglior modo. Ecco, la lettura è il rimedio giusto, soprattutto se si ha la fortuna di scegliere un libro che, senza la necessità di sforzare le meningi, rilassi portando un po di allegria. Dunque, deve essere non impegnativo, facile da leggere e, soprattutto, divertente. Al riguardo La regina di Pomerania e altre storie di Vigàta è proprio quello che va bene. Si tratta di otto racconti, né troppo lunghi, né troppo brevi, insomma della giusta misura, otto storie di paese non collegate fra di loro e quindi autonome al punto tale che, terminata una, si può iniziare con la successiva anche dopo diversi giorni, senza la necessità di doversi rileggere la precedente. In queste prose troviamo un Andrea Camilleri nella sua forma migliore e capace, oltre che di far ridere, anche di commuovere, ed è giusto così, perché in fondo i personaggi devono incontrare la simpatia del lettore, devono essere capaci di divertire, ma anche di toccare le corde del cuore. E i protagonisti non sono figure sciatte, anonime, messe lì a fare da comparsa, ma hanno una ben precisa e ben delineata personalità, insomma attori di una storia che finiremo con il ricordare anche dopo molto tempo che si è letto questo libro. Ne parlo in breve, racconto per racconto, senza nulla svelare, ma solo per dare una piccola sintetica idea. Romeo e Giulietta è una parodia dellomonima tragedia di Shakespeare, con una figura femminile di forte personalità che viene a contatto con un Romeo, che a definirlo imbecille è dir poco. I duellanti presenta un tipico contrasto paesano fra due gelatai, una rivalità non solo commerciale, ma anche in amore, che si trascina nel tempo e che solo un evento, quellevento può troncare. Le scarpe nuove con cui Camilleri ci introduce alla misera condizione di tanti siciliani, quando appunto avere un paio di scarpe nuove era un sogno, e con un personaggio fuori dai generi, un asino veggente e quasi umano a cui il suo ex padrone, antifascista viscerale, ha dato il nome di Mussolini. La regina di Pomerania è una vera e propria perla e narra di una truffa internazionale ben architettata, con un ineffabile e imperturbabile Console onorario che seduce i notabili dellintero paese. La lettera anonima descrive una vera e propria epidemia di lettere non firmate, una moda che induce il professor Bruccoleri, che ne sarà anche vittima, ad analizzare il fenomeno, arrivando a una loro classificazione: lettera anonima che porta a conoscenza di un intero paese un fatto di cui già sa; quella mandata allautorità giudiziaria e quindi è una denuncia; poi cè quella che rivela una storia sconosciuta a tutti e infine lultima che racconta di qualche cosa che non è mai accaduto, ma che ha la possibilità di succedere, e questa è la più pericolosa, perché nessuno è in grado di capire se è vero quanto scritto o è inventato; in verità esiste pure unaltra categoria, quella in cui emerge la volontà di seminar zizzania, di portar male, ma che poi finisce per avere leffetto contrario, come appunto sperimenterà e qui ci sta tutta la commozione il professor Bruccoleri. La seduta spiritica è una parodia dello spiritismo, dei suoi riti, dei suoi personaggi e nel caso specifico con le sue truffe. Luovo sbattuto, in cui Camilleri si cimenta con lerotismo e direi che ci riesce piuttosto bene, delineando in modo impeccabile due protagonisti dalcova in una passione travolgente, che tutto divora, anche la vita. Qui lilarità è molto più sfumata, tranne qualche passaggio, e mano a mano che si procede e si volge al fine della storia la narrazione si fa sempre più seria, in previsione dellinaspettato finale. E arrivo al racconto che mi è piaciuto di più, a Di padre ignoto, un autentico gioiello, in cui i confini fra lapparire e lessere sembrano dilatati nella visione ristretta di un popolino, portato a credere con una fede a prova di bomba, nonostante le evidenze. Amalia Privitera è una santa, oppure una donna di malaffare? Camilleri non giudica, giudica invece lignoranza di una moltitudine paesana che pare priva di buon senso e di un gruppo di notabili, che pilota la circostanza a piacimento. E un racconto che diverte e anche commuove, perché in fondo Amalia Privitera, bella come una Madonna, è una donna sfortunata, segnata dal destino, che inutilmente cerca di contrastare. Scritto come al solito in una sorta di siciliano italianizzato, La Regina di Pomerania e altre storie di Vigata è un gran bel libro, meritevole della più ampia considerazione.
Andrea Camilleri
(Porto Empedocle, 1925), regista di teatro, televisione, radio e
sceneggiatore. Ha insegnato regia presso lAccademia Nazionale dArte
Drammatica. Ha pubblicato numerosi saggi sullo spettacolo e il
volume, I teatri
stabili in Italia (1898-1918).
10/7/2014
Una testa in gioco
Adelphi Edizioni
Narrativa romanzo
I dubbi di Maigret Il nemico pubblico N. 1 dei criminali, il celeberrimo commissario Maigret, è roso dal tarlo del dubbio, perché nel caso del delitto di due donne (una ricca signora e la sua cameriera) tutti gli elementi probatori hanno portato a individuare come colpevole un ragazzone frustrato, tale Heurtin, incriminato, processato e condannato a morte. Listinto naturale, o meglio il fiuto, lo portano a temere di aver preso un granchio e alla fine, a costo di veder vanificate le sue possibilità di carriera e il suo stesso posto, tanto fa che riesce a convincere il giudice istruttore Coméliau a far fuggire limputato, nella convinzione anche che sia lunico modo per poter arrestare eventuali complici, dove quelleventuali è avvertito dal poliziotto parigino come quasi una certezza. Inizia così uno dei più bei gialli scritti da Simenon, con un susseguirsi di eventi che incollano il lettore al libro in unambientazione a tratti crepuscolare delle rive della Senna. Ma se Heurtin è un sempliciotto, magari un po ritardato, non è così lavversario che Maigret incontra nella sua indagine, perché Radek, così si chiama, è un cecoslovacco che ama giocare con la morte, pregno di unautostima che rasenta la follia, lucido tuttavia e talmente intelligente da disseminare falsi indizi e con la pretesa di giocare come un gatto con il topo. Riesce anche simpatico in questa continua tenzone con la polizia, ma sono apparenze, perché dietro i suoi occhi si cela il male solo per il gusto di essere comunque superiore a tutti. Per un po Maigret annaspa, poi comincia a stare al gioco e infine lentamente sgretola la sicurezza del suo avversario, fino a quando gli vibra la stoccata finale. Quindi, come al solito, lintuito del celebre commissario si è dimostrato determinante, evitando che la testa di un innocente rotolasse nel cesto e assicurando alla giustizia e al boia il vero colpevole. E un racconto asciutto, teso come una corda di violino, e che ancora una volta stupisce per la straordinaria capacità di Simenon di sondare la psiche di un criminale. Resta sempre la straordinaria umanità delluomo massiccio e dallo sguardo impenetrabile che risponde al nome di Maigret. Da leggere.
Georges Simenon,
nato a Liegi nel 1903, morto a Losanna nel 1989,
ha lasciato
centonovantatre romanzi
pubblicati sotto il suo nome e un numero imprecisato di romanzi e
racconti pubblicati sotto pseudonimi, oltre a volumi di «dettature» e
memorie. Il commissario Maigret è protagonista di 75 romanzi
e 28 racconti, tutti pubblicati fra il 1931 e il 1972. Celebre in
tutto il mondo, innanzitutto per le storie di Maigret, Simenon è
anche, paradossalmente, un caso di «scrittore per scrittori». Da
Henry Miller a Jean Pauhlan, da Faulkner
a Cocteau, molti e disparati sono infatti gli
autori che hanno riconosciuto in lui un maestro. Tra questi, André
Gide: «Considero Simenon un grande romanziere, forse il più grande e
il più autentico che
la letteratura
francese abbia oggi»; Walter Benjamin: «
leggo ogni nuovo romanzo di
Simenon»; Louis-Ferdinand Céline:
«Ci sono scrittori che ammiro moltissimo: il Simenon dei Pitard,
per esempio, bisognerebbe parlarne tutti i giorni».
7/7/2014
Il lungo viaggio di Primo Levi
Marsilio Editori
Biografia
Primo Levi partigiano Dellesperienza nel lager nazista di Auschwitz Primo Levi ci ha raccontato compiutamente e in modo mirabile, prima di tutto con Se questo è un uomo , poi con La tregua e in un approccio più analitico con I sommersi e i salvati. Ricordo che il narratore torinese era stato arrestato nella notte fra il 12 e il 13 dicembre 1943 ad Amay in valle dAosta nel corso di un rastrellamento della milizia fascista contro i partigiani, di cui faceva parte in una piccola banda affiliata a Giustizia e Libertà, pur non essendo militarmente attivo. Primo Levi è stato descritto da tutti come un uomo mite e sensibile e che ben difficilmente avrebbe fatto ricorso alle armi ove necessario, anche per impreparazione al loro uso. Si era nel periodo in cui era appena avviata la resistenza, spesso più dimpeto che con logica, disorganizzata, con armamento modesto e insufficiente e con i partigiani che sovente non erano ancora addestrati militarmente allo scontro, mentre i loro capi, per lo più, mancavano di conoscenze approfondite di strategia e di tattica. E in effetti, tutti questi elementi lacunosi fecero sì che il rastrellamento riuscisse pienamente. Di questa breve esperienza di lotta in montagna Primo Levi ha sempre parlato molto poco, spesso non dandole importanza e con una certa reticenza. Eppure sarebbe stato giusto che ne scrivesse, perché in fondo costituì il passaggio dallantifascismo innato a quello militante, frutto di una scelta non scevra da notevoli pericoli. Perché questo quasi silenzio? A questa domanda lo storico Frediano Sessi ha cercato di dare una risposta, dopo un lungo lavoro di ricerca negli archivi e di colloqui anche con i sopravvissuti a quel rastrellamento. E probabile che il motivo, se non lunico, almeno il principale, risieda nellesecuzione sommaria di due giovani, più banditi che partigiani, esecuzione a cui Levi fu del tutto estraneo, ma che incise profondamente il suo animo, portandolo a uno stato di prostrazione che lui ben sintetizza nel suo libro Sistema periodico: Adesso eravamo finiti, e lo sapevamo: eravamo in trappola, ognuno nella sua trappola, non cera uscita se non allingiù. Il libro di Sessi così, fra congetture non campate in aria, porta a tutta una serie di vicende, quali anche linternamento nel campo di transito di Fossoli, che mettono Levi in una nuova luce, evidenziando la sua filosofia di vita che gli consentirà poi, anche grazie alla fortuna, di sopravvivere allinferno di Auschwitz. Se lopera si basasse solo su questo risulterebbe già di particolare interesse, ma la capacità di Sessi permette che vada ben oltre, grazie alle sue riflessioni, alle sue osservazioni, la cui portata travalica il fatto in questione, con un giudizio sintetico di quel che fu la Repubblica Sociale Italiana, volto a smentire una volta per tutte che fosse un organizzazione umana a differenza delle feroce Germania nazista. Scrive lautore a pagg. 12 e a pagg. 13 Nonostante le ricerche storiche e la diffusione di molto materiale documentario, ancor oggi la maggior parte degli italiani, quando è in grado di sapere che cosa sia la Repubblica Sociale Italiana (e questo grazie al limitato spazio che gli dedicano i programmi scolastici in vigore) non si rende conto di quanto sia pesante e grave il fardello delle colpe che quella parte degli italiani porta su di sé. Non si tratta oggi, come sembrano sostenere alcuni storici, di trasformare il bravo italiano fascista in un criminale incallito, ma di scorgere nelle scelte e nelle azioni dei repubblicani quella quota di gravosa responsabilità nel sostenere e nel portare avanti autonomamente le azioni criminali delloccupante nazista, nella convinzione che la nuova Italia avrebbe potuto sorgere dal sangue di una polizia politica e razziale radicale. Qualcosa di più di una guerra civile (che ancor oggi viene letta come scontro tra diverse espressioni della storiografia del nostro paese). Così, il fascio italiano repubblicano, proprio come le pratiche di occupazione nazista, segna dopo l8 settembre del 1943, almeno in Italia, una svolta che mostra il volto senza veli del progetto razziale, elaborato con le leggi del 1938. È quindi un con noi, ma a scelta del proclamante, o contro di noi, senza possibili vie di mezzo; è evidente che non di discosta dalla ideologia di una razza superiore, con tutte le conseguenze che purtroppo si manifestarono più marcatamente nel corso della guerra, ma già in misura pesante nel periodo prebellico (basti pensare appunto alle leggi razziali del 1938, anche se già nella persecuzione degli avversari politici si riscontra questa impalcatura capace di reggersi solo sulla violenza, e Levi era un mite, lideale vittima sacrificale). Il libro si chiude con il resoconto, drammatico e commovente, di una visita dellautore ad Auschwitz avvenuta nellottobre 2010. E un ripercorrere lambiente, o quel che resta, così ben descritto da Levi in Se questo è un uomo; certo mancano latmosfera di quegli anni di guerra, le urla delle SS e dei Kapò, il doloroso silenzio degli internati, ma essi rivivono, pare che bussino insistentemente alle nostre orecchie, grazie a quanto scritto da Primo Levi, per non dimenticare, affinché non possa più accadere. Il lungo viaggio di Primo Levi è senzaltro più che meritevole di lettura, anche perché induce a riflettere, elemento indispensabile affinché l olocausto non sia solo una parola del vocabolario.
Frediano Sessi
vive e lavora a Mantova. Tra le sue pubblicazioni ricordiamo Il
ragazzo Celeste (1991),Ritorno
a Berlino (1993), Lultimo
giorno (1995), Alba
di nebbia (1998), Nome
di battaglia: Diavolo (2000),
Prigionieri della memoria (2006,
due edizioni), Foibe
Rosse (2007, due
edizioni), Il segreto
di Barbiana(2009) e con Carlo Saletti Visitare
Auschwitz (2011, due
edizioni) tutti editi da Marsilio. Sempre per Marsilio ha curato il
saggio di Michel Mazor La
città scomparsa(1992). È autore inoltre dei romanzi per ragazzi
Ultima fermata: Auschwitz (1996), Sotto
il cielo dEuropa (1998)
e Il mio nome è Anne
Frank (2010), editi
da Einaudi, per cui ha curato anche ledizione italiana definitiva
del Diario di Anne
Frank (1993) e il Dizionario
della Resistenza (2000).
Nel 1999 è stato pubblicato il suo saggio La
vita quotidiana ad Auschwitz (Rizzoli,
tredici edizioni).
5/7/2014
Quando sorride il mare Floriana Porta Quando sorride il mare è la nuova raccolta della poetessa torinese Floriana Porta, composta da ben cinquantacinque poesie e diciotto haiku, da poco pubblicata per AG Book Publishing. In questa sua nuova opera ritroviamo il classico stile poetico di Floriana Porta che scandaglia fra i vari sentimenti che da sempre agitano e scuotono lanimo umano, questa volta però ispirati dal mare che permette alla nostra poetessa di trasformare in versi poetici quelle immagini dense e vivide che solo esso è in grado di regalare. Si sa bene che il mare possiede un proprio codice e un proprio linguaggio che solo chi è in grado di ascoltare con il cuore e contemplare in silenzio, riesce a percepire e nonostante esso simboleggi da sempre l irrequietezza dell animo per via del suo perenne moto ondoso, il mare in questa raccolta poetica di Floriana Porta è paradossalmente in grado di rilassare l individuo. Tutto ciò forse accade perché inconsapevolmente il mare genera energia positiva che si trasmette di riflesso alle cose e alle persone che lo osservano o forse perché più semplicemente nel mare è custodito il vero grande segreto della felicità eterna. E cosi Floriana Porta traendo spunto dal mare e dai suoi numerosi segreti, esplora il mondo dei sentimenti più intimi e nascosti quasi come se si trattasse di un fondale marino oscuro, profondo e popolato da strane e misteriose creature. E cosi che sentimenti come la sofferenza, la solitudine, la malinconia e la morte grazie alla presenza del mare sembrano mutare forma e fare meno paura allindividuo, lasciando invece posto all energia positiva, alla speranza e al potere dei sogni. Ho apprezzato molto questa breve ma intensa nuova raccolta poetica di Floriana Porta soprattutto per la scelta di utilizzare un elemento cosi semplice e naturale come il mare per scandagliare gli stati d animo, anche quelli più articolati e complessi. Inoltre a colpirmi maggiormente sono stati quel bisogno di silenzio e di solitudine che la lettura di Quando sorride il mare richiede al lettore, semplicemente per poter catturare e apprezzare al meglio tutte le sensazioni positive che esso rilascia e per lasciarsi coinvolgere dalla scia schiumosa dei ricordi e delle speranze più intime affidate da sempre al mare. Floriana Porta grazie alle sue poesie dense e intrise di sentimento fa di Quando sorride il mare un opera che porta con sé tutto l impeto di quel mare che non si ferma dinanzi a nulla e forse è proprio dal mare che dovremmo trarre insegnamento per non fermarci mai dinanzi agli ostacoli e avere sempre la forza di riprovare ma forse in fondo il mare è già dentro ciascuno di noi, bisogna solo saperlo ascoltare. Chiara Ruggiero
4/7/2014
La
masseria delle allodole
Bur Biblioteca Universale Rizzoli
Non nascondo che avevo molte aspettative per questo romanzo della Arslan: lambientazione un po esotica, un genocidio (quello degli armeni) rimasto per troppo tempo sotto silenzio e la vittoria al premio Strega nel 2004 mi avevano appassionato ancor prima di avere per le mani il libro. Forse mi aspettavo chissà cosa, forse mi ero illuso di trovarmi di fronte a un grande e tragico affresco storico, a una di quelle opere di narrativa che tengono inchiodato alla poltrona il lettore fino allultima pagina, con un coinvolgimento emozionale crescente. E invece non ho trovato nulla di tutto questo e mano a mano che scorrevo le pagine, zeppe di personaggi spesso insignificanti, cresceva in me una noia che mi stizziva. Non è che la vicenda di cui si parla sia poca cosa, ma è il modo in cui è raccontata. Aleggia soprattutto la freddezza di un rapporto burocratico che nemmeno si trova nei testi di storia e questo non è un saggio storico, ma un romanzo di vita vissuta dei parenti dellautrice, poiché lei, per fortuna, non è stata direttamente toccata dalla strage turca, avvenuta diversi anni prima che nascesse, peraltro nel nostro paese. Io sono il primo a sostenere che la presenza dello scrittore deve essere sfumata, nel senso che i suoi personaggi debbono avere, almeno in apparenza, la più ampia autonomia, ma se non cè anche la più piccola partecipazione emotiva riesce difficile coinvolgere chi legge, che deve avere la certezza di non assistere a una rappresentazione in cui i personaggi si muovono in modo scoordinato, afono e sovente meccanico. Purtroppo mi sono trascinato allultima pagina fra uno sbadiglio e laltro, chiedendomi ancora una volta che senso ha un premio come lo Strega che fino a quasi tutto il secolo scorso ha saputo riconoscere il giusto merito a opere di valore, ma che da un po di tempo incorona dalloro romanzi banali, non poche volte nemmeno scritti bene. Per quanto ovvio, almeno secondo il mio metro di giudizio, ne sconsiglio la lettura.
Antonia Arslan
è autrice di saggi fondamentali sulla narrativa popolare e la
letteratura femminile tra Ottocento e Novecento. Ha riscoperto le
proprie origini armene traducendo le opere del grande poeta Daniel
Varujan. Nel 2004 ha dato voce alle memorie familiari ne La masseria
delle allodole, premiato con moltissimi riconoscimenti e tradotto in
15 lingue, da cui i fratelli Taviani hanno tratto lomonimo film.
29/6/2014
Il giro del mondo in ottanta giorni
Newton Compton Editori Narrativa romanzo
Un lungo viaggio per scommessa Jules Verne era dotato di una mente particolarmente fervida, al punto da creare romanzi di una fantascienza che si sarebbe tramutata in realtà nellarco di non molti anni. Infatti, fra le sue opere si annoverano Dalla terra alla luna, Ventimila leghe sotto i mari e I figli del capitano Grant. Nondimeno, di tanto in tanto produsse romanzi più in linea con le possibilità della sua epoca, prose di assoluta avventura, fra le quali appunto Il giro del mondo in ottanta giorni. Per questultima si parte da una scommessa stipulata in un club, del valore di 20.000 sterline, somma che si sarebbe potuta incassare solo effettuando il giro del pianeta appunto in ottanta giorni. I mezzi di trasporto sono quelli esistenti allepoca, cioè principalmente nave e ferrovia, anche se Phileas Fogg, questo è il nome del protagonista che porta con sé il fido domestico Passepartout, è poi costretto a fare ricorso a ben altro di alquanto inusuale, quale la slitta e lelefante. Il viaggio non è assolutamente monotono, grazie ai tanti imprevisti che si susseguono implacabili, in una trama densa di avventure che riesce ad avvincere dallinizio alla fine. Riuscirà a vincere la scommessa? Quale esperienza acquisirà Fogg nel corso del viaggio? Come al solito, per rispetto al lettore interessato, non dirò nulla soffermandomi invece su alcune caratteristiche dellopera che, per certi aspetti, rientra, oltre che nei romanzi di avventura, anche in quelli di viaggio, in forza delle splendide descrizioni dei luoghi attraversati. E non crediate che sia un libro solo per ragazzi, perché certe atmosfere, soprattutto orientali, hanno già un loro fascino tale da attrarre con quel velo di mistero anche il lettore più smaliziato. Lo stile, pur improntato a un certo distacco old England, riesce tuttavia a ben delineare avventure e personaggi e se allepoca attuale, dati i mezzi di trasporto correnti, possono far sorridere alcune soluzioni, si sappia che allora non cera di meglio e che questo, che pur sembra poco, era considerato il top del progresso. Oggetto di fortunate trasposizioni cinematografico, Il giro del mondo in ottanta giorni è uno di quei libri, mai grevi, anzi di facile e piacevole lettura, che può rappresentare lo svago di alcune ore spensierate nel corso di una villeggiatura, magari in spiaggia sotto lombrellone.
Jules Verne nacque
a Nantes nel 1828. Nel 1848 si trasferì a Parigi attratto dalla
intensa vita culturale della capitale, ma per ottenere il consenso
del padre dovette continuare gli studi giuridici. Dal 1862, grazie
al successo del primo libro, Cinque settimane in pallone (cui seguìParigi nel
XX secolo, pubblicato solo nel 1994), poté dedicarsi
completamente alle sue due grandi passioni: scrivere e navigare. Dopo
la pubblicazione di circa 60 opere e innumerevoli viaggi, Verne -
ricchissimo e osannato ma sempre discreto e schivo - si ritirò ad
Amiens in seguito a un misterioso attentato in cui era rimasto
ferito. Morì nel 1905. La Newton Compton ha pubblicato Ventimila
leghe sotto i mari, Il giro del mondo in 80 giorni, Viaggio
al centro della Terra e il volume unico I grandi romanzi.
24/6/2014
Pietr il Lettone
Traduzione di Yasmina Mélaouah
Latto di nascita ufficiale del commissario Maigret Che il commissario Maigret abbia portato fortuna al suo autore Georges Simenon è indubbio, con risultati di vendita tali da consentirgli di condurre una vita agiata. Sono ben 75 i romanzi e 28 i racconti in cui compare questo strano poliziotto che si fida solo del proprio istinto e che conduce le indagini non come un investigatore perfetto e impeccabile come Sherlock Holmes; no, lui Maigret per un po brancola nel buio, ma poi scatta il suo intuito e da allora il percorso dellindagine è in discesa e non cè più scampo per il colpevole. Settantacinque romanzi sono tanti, con alcuni particolarmente riusciti e altri pochi in verità di standard non elevato, ma in ogni caso di facile lettura e particolarmente graditi a una vasta platea di lettori di ogni continente. È quindi del tutto naturale che abbia cercato il primo libro in cui nasce ufficialmente il commissario Maigret e lho trovato, perché Pietr il Lettone è il primo giallo, datato 1931, in cui lo si vede allopera. Per quanto ovvio, Simenon si è impegnato a fornirci una descrizione abbastanza dettagliata del personaggio (Maigret non somiglia ai poliziotti resi popolari dalle caricature. Non aveva né baffi né scarpe a doppia suola. Portava abiti di lana fine e di buon taglio. Inoltre si radeva ogni mattina e aveva mani curate. Ma la struttura era plebea. Maigret era enorme e di ossatura robusta. Muscoli duri risaltavano sotto la giacca e deformavano in poco tempo anche i pantaloni più nuovi.). Maigret ha quindi una struttura enorme, è un uomo robusto, sempre con la pipa in bocca, determinato nelle sue indagini, ma già in questo ultimo giallo ha unaltra caratteristica: una carica umana che lo porta a non ledere la dignità degli altri, anche quando questi sono dei criminali. È sposato, ma la moglie é presente solo nellombra, tranne che nelle ultime pagine; dalla descrizione del commissario emerge un particolare curioso: data la stagione autunnale in cui è ambientata la storia, quando esce mette in testa un cappello, ma non un cappello qualsiasi, né un borsalino, né un berretto o un basco, bensì una bombetta. Come prima opera, poi, questa ha quasi le cadenze di un thriller mozzafiato (laiutante di Maigret viene assassinato, lo stesso commissario viene ferito seriamente) e i colpi di scienza sono incalzanti, a differenza dellandamento più tranquillo dei successivi episodi. Non sto a indicare la trama, perché è complicata, ma molto ben articolata, e con un finale in un certo senso inaspettato, anche se a guardar bene del tutto logico. Sono pagine che si leggono con piacere e il trovarsi di fronte per la prima volta a questo mitico protagonista aggiunge emozione allemozione, e viene da subito spontaneo tifare per lui nelleterna lotta fra il bene e il male. Quindi, Pier il Lettone è senzaltro meritevole; trascorrerete un po di tempo in modo assai piacevole, perché di Maigret ce nè uno solo e quello che cè basta e avanza per regalare ai lettori un sano svago.
Georges Simenon,
nato a Liegi nel 1903, morto a Losanna nel 1989,
ha lasciato
centonovantatre romanzi
pubblicati sotto il suo nome e un numero imprecisato di romanzi e
racconti pubblicati sotto pseudonimi, oltre a volumi di «dettature» e
memorie. Il commissario Maigret è protagonista di 75 romanzi
e 28 racconti, tutti pubblicati fra il 1931 e il 1972. Celebre in
tutto il mondo, innanzitutto per le storie di Maigret, Simenon è
anche, paradossalmente, un caso di «scrittore per scrittori». Da
Henry Miller a Jean Pauhlan, da Faulkner
a Cocteau, molti e disparati sono infatti gli
autori che hanno riconosciuto in lui un maestro. Tra questi, André
Gide: «Considero Simenon un grande romanziere, forse il più grande e
il più autentico che
la letteratura
francese abbia oggi»; Walter Benjamin: «
leggo ogni nuovo romanzo di
Simenon»; Louis-Ferdinand Céline:
«Ci sono scrittori che ammiro moltissimo: il Simenon dei Pitard,
per esempio, bisognerebbe parlarne tutti i giorni».
20/6/2014
Dal silenzio delle campagne
Prefazione di Fernando Bandini
Poesia
·
Venuto dalle campagne, poiché lì vi è nato da famiglia contadina, lormai inurbato Camon, affrancato dal percorso di studi effettuato e dallattività di insegnante che nulla ha a che fare con il mondo rurale, in unepoca in cui quella millenaria civiltà dei lavoratori dei campi si è conclusa, volge lo sguardo allintorno sui nuovi comparsi (gli agricoltori), ma anche suscitando il ricordo di un tempo passato e che mai più ritornerà. Nasce così questa raccolta di poesie, mai cedevoli al lirismo, ma volte, come è scritto anche nel sottotitolo, a riportare in versi raccontini del mondo agreste, alla luce anche di nuovi eventi che si innestano in una realtà sorta forse confusamente, ma che é la civiltà del benessere, in cui non si soffre più la fame, si fatica meno, ma anche si vive alla giornata, depauperati dalle radici di un passato e perciò figli di nessuno. È così che lopera presenta delle sottosillogi tematiche ( Dagli allevamenti di tori; Dalle fattorie; Dalle città e dalle periferie), realizzando in pratica un fine trattato sociologico in versi. Il substrato, il palcoscenico è quello di un Nord-Est che anni fa faceva la fame, ma che ora imborghesito si pasce di ricchezza, continuamente perseguita, in una desertificazione del senso etico da cui nascono nuovi mostri (stupratori, assassini, serial killer). Se con i suoi primi romanzi, in cui così bene ha descritto la civiltà contadina e la sua scomparsa, Camon non si era fatto certo amici al suo paese, con questa raccolta di poesie, radicata in un territorio più ampio, deve avere accresciuto in modo sostanziale i suoi nemici e solo per il semplice fatto che raccontare la verità non è per niente facile e le conseguenze sono sempre di forti contrasti quando questa viene a toccare qualcuno. Da questopera esce un quadro della grettezza propria dei nuovi agricoltori, travolti dallidea di far sempre più soldi, orfani del senso della famiglia, della religione e anche della patria. E qui non vorrei che qualcuno pensasse che gli antichi richiami nazionalisti e fascisti di Dio, patria e famiglia fossero il nocciolo di tutta lopera, perché si sbaglierebbe di grosso. Camon non ha un concetto retorico di questi tre stilemi, ma avverte tangibilmente che laver rinunciato a una famiglia patriarcale, dove ognuno dei componenti era in funzione degli altri, laver abdicato al senso pregnante di una religione rifugio per i propri problemi e maestra di vita, laver circoscritto la patria solo alla propria azienda, mezzo e fine del tutto, non può che portare a un inaridimento in cui possono albergare tutte le pulsioni possibili, e soprattutto quelle distruttive ( Da terre sante e assassine: / Di lui non sappiamo tutto. / Stuprava le vittime col pugno / e col calcagno, / faceva cose che i periti / coprono col segreto, / per paura che lumanità / sentendole faccia un salto indietro. / . E questa poesia, piuttosto lunga, non a caso rappresenta lepilogo, un monito con il quale il poeta, in precedenza assai meno drammatico, anzi ironico, richiama la sua gente - ma che è tutta la gente facente parte della civiltà post-contadina - a un riesame della propria coscienza, se questa esiste ancora. E forse una conclusione che non mi aspettavo, anche se logica, ma questo avviene alla luce delle precedenti poesie venate da unironia quasi ludica, in cui difetti e sfregi sono così ben descritti in versi tanto da ricavare limpressione che lautore sia lì davanti a te, e quindi con un tono conviviale, da moderno cantastorie. E se di ironia si tratta, credo proprio che comprenda anche una buona dose di autoironia, unancora di salvezza per prendere sul serio, ma non troppo, la vita, come il personaggio di Il lupo della steppa, di Hermann Hesse. Divertono questi versi, ma pungono, piano piano scavano dentro al punto da chiedersi alla fine come mai abbiamo potuto ridurci così, immemori del passato, apatici nel presente, incapaci di programmare un futuro che non sia solo quello di far soldi a ogni costo. Van bene gli sghei, perché quando non ci sono e servono sono dolori, ma ridurre tutta una vita allunico valore monetario è sprecarla inutilmente. Aggiungo che è uscito in questi giorni, edito sempre da Garzanti, lebook Dal Silenzio delle campagne ( 4,90), comprendente anche la silloge Liberare lanimale di fatto totalmente irreperibile in forma cartacea. Lambientazione di queste poesie è sempre il mondo contadino, ma si aggiunge unulteriore finalità, rappresentando una coscienza storica di quanto avvenuto in un ancor non lontano passato. Sono scampoli di ricordi di vita vissuta, con ritratti anche struggenti, come in Mia madre, oppure versi che straziano, che segnano le carni, che incidono lanima come quella che dà il nome allintera silloge, dallimmensa profondità e con una chiusa che da sola vale lintera opera: Non possiamo ancora reagire al male:/ occorrono interi millenni / per liberare da noi lanimale. Opera antecedente a Dal silenzio delle campagne, con un Camon più giovane, non è pervasa dallironia di cui ho accennato, anche se a tratti affiora, ma allepoca il disincanto era probabilmente solo agli inizi Da leggere entrambi, non ve ne pentirete.
Nota: per chi desiderasse maggiori e ulteriori approfondimenti può
leggere la mia intervista autore presente su Arteinsieme al seguente
link:
Ferdinando Camon è
nato in provincia di Padova. In una dozzina di romanzi (tutti
pubblicati con Garzanti) ha raccontato la morte della civiltà
contadina (Il quinto stato, La vita eterna, Un
altare per la madre Premio Strega 1978), il terrorismo (Occidente,Storia
di Sirio), la psicoanalisi (La malattia chiamata uomo, La
donna dei fili), e lo scontro di civiltà, con l'arrivo degli
extracomunitari (La Terra è di tutti). È tradotto in 22 paesi.
Il suo ultimo romanzo è La mia stirpe (2011).
17/6/2014
Marian Izaguirre Traduzione di
Tiziana Gibilisco Cè un luogo a Madrid dove tutti i destini si incontrano, le storie prendono vita e i sogni mai realizzati trovano unaltra possibilità. E una libreria Madrid, anni Cinquanta. «Mi manca la vita quando era nostra » Lola lo ripete spesso al marito Matías, ripensando ai giorni pieni di libri, progetti e idee, prima che la guerra civile del 1936, cambiasse la faccia e le strade della città, e distruggesse in un colpo solo le loro vite, la loro casa editrice, e i loro sogni. Ora Lola e Matías hanno una piccola libreria, incastonata in un vicolo seminascosto della città. Una libreria di libri già letti: libri usati, passati di mano in mano e di vita in vita, che Questa è la presentazione de La vita quando era nostra di Marian Izaguirre un libro ricco di sfumature, perchè è tenero, nostalgico, struggente, pieno di vita e di morte, di ricordi, di tutto quello che contrassegna una vita, delle vite, in un intreccio inestricabile e anche doloroso. E' difficile trovare in un libro di narrativa una gamma così ricca di moti d'animo, sentimenti ed emozioni, in uno stile semplice, ma intenso sullo sfondo di una guerra sfumata dal tempo, ma che ancora è impressa in chi ne è stato coinvolto e ne porta le ferite interiori. La giovane coppia senza figli Lola e Matías racchiudono segreti, che non possono e non vogliono confessare a se stessi, li accomuna un passato bellico che ne ha stravolto lo stile di vita, nutrono un devoto amore per i libri e questi saranno il tramite di un incontro inusuale e misterioso. Matìas con le braccia cariche di libri va nelle case di alcune persone e proprio in questi giri per la città madrilena lo vede una donna e, incuriosita, inizia a seguirlo. Alice, il nome della donna, un inglese che da 13 anni vive in Spagna, da quel giorno come un'ossessione vuole conoscere quell'uomo. Grazie alla piccola libreria sistemata in un vicoletto nascosto alla vista dei passanti e grazie ad un libro esposto in vetrina che Lola e Alice leggeranno insieme (la storia contenuta in questo libro non si può anticipare, altrimenti sarebbe spoiler...), proprio quello sistemato su un leggìo, nascerà un'amicizia tra le due donne che hanno in comune un passato entrambe pesante vissuto durante la dittatura franchista e troveranno il coraggio di rivelare. Gli anni trascorsi come un sipario si apriranno alla vista del lettore e quelli di Lola saranno poi elaborati per cui potrà tornare ad essere come prima della guerra, mentre per Alice è una rievocazione di ricordi tragici, ma anche affascinanti perchè intrecciati con un mondo di letterati, artisti pieni di talento e stravaganze, sarà come acquisire consapevolezza di sé e maturità. La descrizione di Madrid in quegli anni '50, le sue strade, i suoi vicoli, i suoi caffè è come in un film a 3D. E poi Londra, Parigi viste attraverso gli occhi di Alice, città che avevano impresso nel suo cuore vicende ineludibili e ne avevano forgiato lo spirito. Una storia quella di La vita quando era nostra delicatissima e magica declinata al femminile, anzi due storie straordinarie di vita vissute in cui la bellezza dell'amore e della complicità femminile e il potere della lettura ne esaltano l'essenza. È vero che i libri non possono salvare il mondo, ma possono essere un rifugio sicuro dalle impervietà esistenziali, ridare coraggio e confortare la solitudine quando è un peso... Ed è intorno a questo tema che il romanzo costruisce la sua tessitura. Il romanzo si chiude con una breve ed intensa poesia lirica. Si spazzano i cocci del cuore
16/6/2014
Kafka e il mistero del processo
Prefazione di Massimo Maugeri Semplicemente geniale Ecco, sono arrivato con trepidazione allultima riga, chiudo il libro e pure gli occhi, perché a dire che sono emozionato è poco; la verità è che sono entusiasta, perché mai, e ripeto il mai, mi era capitato di leggere qualche cosa di così grandioso. Guardo la copertina e leggo il nome dellautore: Salvo Zappulla. Mi viene spontaneo chiedermi se sia lo stesso Salvo Zappulla che conosco e che ha già scritto In viaggio con Dante allinferno, un buon libro, ma nemmeno paragonabile per qualità a questo. La trama, per quanto assai complicata, avvince dallinizio alla fine, con quellidea geniale di base di uno scrittore di modesto livello che, pungolato dal suo editore, si mette dimpegno per scrivere il libro che gli darà la celebrità e per far questo sconvolge il suo solito modus operandi, trasformando il protagonista Pedro Escobar, rozzo scaricatore di porto secondo lidea originale, in una persona completamente diversa, personaggio che si stacca dallautore, assume una propria autonomia, di fatto dando inizio a uno dei più bei romanzi apparsi sulla scena mondiale. Non aggiungo altro sulla vicenda che presenta di volta in volta le caratteristiche di genere del fantasy, del thriller e anche del mainstream, mai in contrasto fra di loro, ma anzi perfettamente amalgamate. E come nel Processo di Kafka lautore verrà sottoposto a giudizio sulla base di una orrenda macchinazione, poiché il nuovo Pedro Escobar procede come una mina vagante, inquinando i testi sacri della letteratura, modificando trame e personaggi, con inevitabile crisi delleditoria, a tutto vantaggio delle grandi compagnie televisive che intendono, in accordo con i governi di tutto il mondo, arrogarsi il diritto di acculturare le genti, rendendole di fatto supine alla volontà dei potenti. Si sa, infatti, che un popolo con poca cultura, o con una cultura a senso unico, è assai facile da governare. E questo è uno dei messaggi del romanzo, il più importante, un severo monito a non lasciarsi condizionare, a conservare la volontà e la capacità di riflettere, ad amare la vera letteratura, rinunciando a quegli autori che di fatto sono imposti solo per fini esclusivamente commerciali e a leggere o rileggere invece le opere di quei poeti e narratori che hanno lasciato un segno indelebile. Non è un caso se Pedro Escobar colpisce, fra i tanti bravi scrittori, Flaubert, trasformando Madame Bovary in una puttanella da quattro soldi, Dumas facendo diventare quattro i Tre moschettieri, Andersen sostituendo alla piccola fiammiferaia una vecchietta che vende accendini che non funzionano e che parla con accento napoletano, Buzzati, impedendo di fatto al sottotenente Drogo di iniziare la sua lunga attesa perché i tartari, di sorpresa, hanno attaccato e distrutto la fortezza. Il libro vuole essere quindi anche un omaggio a questi artisti, le cui opere sono ormai immortali, e fra questi geni non poteva mancare Italo Calvino a cui sarebbe senzaltro piaciuto che fra Le città invisibili ci fosse anche quella zappulliana della Ragione, un sogno di come dovrebbe essere il vivere in comunità. Sono sincero se dico che non ci sono parole per poter descrivere limmenso piacere che si prova leggendo Kafka e il mistero del processo, e se il termine capolavoro può sembrare inflazionato, preciso tuttavia che in questo caso è senzaltro pertinente. Zappulla è riuscito a ritagliarsi un posto su misura nellOlimpo dei grandi della letteratura, con pieno merito, dando prova di una maturità artistica straordinaria. Mi sembra perfino superfluo aggiungere che ne raccomando la lettura; per parte mia, sono sicuro che a breve lo riprenderò in mano, per riassaporare lo stesso piacere che ancora avverto nello scrivere questa recensione.
Salvo Zappulla è
nato il primo marzo 1961 a Sortino (SR), dove tuttora vive. I suoi romanzi sono stati corredati da schede didattiche e adottati come testi di narrativa nelle scuole medie. E il presidente dellassociazione culturale Pentelite che organizza la Mostra Mercato delleditoria siciliana a Sortino; è il presidente del Concorso Letterario Nazionale Città di Sortino. Cura annualmente la rivista Pentelite. Collabora alla pagina culturale del quotidiano La Sicilia, alla rivista I siracusani, al quindicinale La voce dellIsola. Nel 2006 si è classificato secondo con un testo teatrale inedito al premio MassimoTroisi.
Kafka ed il mistero del processo è
la sua prima pubblicazione con Melino Nerella Edizioni.
12/6/2014
Le rotte del vento di Maria Teresa Santalucia Scibona Prefazione di Renzo
Montagnoli Raffaelli Editore Poesia Estatico abbandono Dalle sommità dellAppennino scende il vento, precipita in forre oscure, da cui poi risale per rotolare lungo le chine delle dolci colline senesi e infine va a placare la sua irruenza, distendendosi nellamena e bucolica campagna toscana. Viene e porta con sé voci armoniche, versi soffusi di languida malinconia che lesile, ma ferma mano di Maria Teresa Santalucia Scibona ha segnato su fogli di carta bianca che ora svolazzano, sinsinuano in ogni pertugio, fino a quando trovano una finestra aperta e, quasi per miracolo, si ricompongono sul mio tavolo. Ed è così che li leggo, ancora odorosi di resina di pino, ancor olezzanti delle mille essenze vitali di una natura che mi par di sentire amica. E sono damicizia queste poesie, dedicate quasi tutte a persone con cui lautrice è riuscita a entrare in sintonia, tanto che lhanno ispirata. Per quanto i temi discussi siano i più vari, di questa natura cè più di una traccia, cè anzi un estatico abbandono da cui riemergere per mostrare, quasi con stupore, quanto immensamente lanima sia stata nutrita, coccolata, vezzeggiata dallassoluta bellezza e perfezione del creato, di cui i versi possono solo darci unidea, per quanto sapientemente esposta (Altrove, in un altro emisfero / la notte abbandonò lalcova. / Il giorno ancora assopito, / salutava lalba mollemente / adagiata nel divano di stelle. / oppure ancora / Nel tramonto ramato / non vera alcuno, oltre me / nella silente solitudine. / Cresceva il desiderio di calarmi / fra gli spazi votivi dellanima, per godere con lo stupore / di bimbo, lincanto del creato.). Fra laltro, la lirica che ho sopra riportato, oltre a essere esplicativa di quel concetto di estasi, nellambito della produzione di Maria Teresa Santalucia Scibona mi sembrano che con altre di questa raccolta possano costituire ancora una volta una significativa conferma di una spiccata predisposizione per unanalisi attenta del destino umano, come appare più evidente nella poesia che dona il titolo allintera silloge. Mi riferisco a Le rotte del vento, dedicata Giampaolo Rugarli, noto narratore italiano. Credo che valga la pena di riportarla per intero: Nel mare ondeggiante / la carena silente / solca i flutti linfrange. / Senza indizio riga / la traccia del tragitto. / Ospiti di scarsi giorni, // anche noi corrucciati / bramosi gaudenti / di terrene delizie / navighiamo a vista / eludendo ignari / le rotte del vento. In pochi versi concisi è riportata la vita di ogni uomo con una metafora di un Titanic che procede senza una meta ben precisa, cercando, inconsapevolmente, di evitare quelle rotte del vento che poi sono frutto della natura, rientrano in un disegno complesso, imprevedibile e incomprensibile, su cui si basa tutto il Creato. È tuttavia la sensibilità individuale che ci conduce a esprimerci mediando ciò che intendiamo dire con ciò che osserviamo e quello che i nostri occhi vedono è la perfezione assoluta della natura, di cui noi stessi siamo umile parte. E questa osservazione è frutto di una trascendenza che ci porta a vedere anche e soprattutto con lanima. A proposito di metafora, forse più che in altre sue raccolte, questo tropo è ben presente ed è il ricorso alla natura una via quasi obbligata per esprimere concetti e sensazioni. Peraltro, da una poetessa come Maria Teresa Santalucia Scibona tutto è lecito attendersi, fuorché la banalità, i versi fini a se stessi, il compiacimento nel cercare astruserie, nellimbarazzare il lettore con concetti incomprensibili. No, questo poetare non rientra nel suo DNA; è presente in lei invece una forza vitale, un carattere indomito, nonostante che la salute non lassista, uno stimolo, direi, che linduce a rendere particolare e originale, e ovviamente artistico, ogni tema trattato, anche il più comune, tanto comune da poter sembrare a una disamina superficiale di scarso o nullo interesse. Ne è una ulteriore conferma anche questa raccolta, come in Gli intrusi, unaltra metafora che sulle ali di Esopo tratta con riuscitissimo artificio il tema spesso abusato dei difetti del progresso. Insomma, se mi è stato chiesto di prefare questa raccolta, io ho accettato, ma per quanto cerchi di porre in evidenza questo o quel pregio nulla posso di più di quello che il lettore riuscirà, in tutta libertà, a cogliere leggendo, perché non cè nessuna difficoltà interpretativa, i versi scorrono come un tranquillo torrente al piano, i concetti sono ben sviscerati, senza possibilità che sorgano dubbi, il piacere di unarmonia strutturale completa è sempre presente. Potrei aggiungere: che cosa è possibile pretendere di più? E infatti è proprio così, ma, mentre chiacchiero e volgo con la penna alla fine, un colpo di vento improvviso mi scompagina i fogli, li solleva e invano li rincorro mentre svolazzando escono fuori e paiono accodarsi a uno stormo di migratori. Dove andranno? Non posso saperlo, quel che è certo è che loro non eluderanno le rotte del vento.
M. Teresa Santalucia Scibona
è nata e vive a Siena. Impegnata da anni in organizzazioni per la
diffusione della poesia in Italia, nel 2005 la Biblioteca
Universitaria senese della Facoltà di Lettere e Filosofia, ha
istituito un Fondo Letterario a suo nome. Nel 2000, dal Concistoro
del Mangia, è stata insignita di medaglia d'oro di civica
riconoscenza, per alti meriti culturali. Nel 2009 il Comitato
Direttivo Idilio Dell'Era, le ha assegnato il Premio alla Carriera "Idilio
Dell'Era".
11/6/2014 Andrea Camilleri 10/6/2014
In Sicilia
Longanesi Editore
Lirredimibilità In Sicilia è uno strano libro, che potrebbe sembrare un cahier de voyage e in parte lo è ma con una finalità ben diversa da quella di mostrare le immagini di una terra che indubbiamente presenta molte attrattive. Tuttavia il paesaggio è uno scenario di una rappresentazione teatrale i cui attori sono gli abitanti dellisola, coloro per i quali è anche ragionevole supporre che esista una ben precisa correlazione con lambiente naturale in cui si trovano a vivere. Collura, nato ad Agrigento, ma che vive ormai da molto tempo a Milano, compie così un viaggio nella sua terra natia, un viaggio che potremmo senzaltro definire sentimentale, ma che unisce alle emozioni del cuore la logica e fredda razionalità della mente, che finisce con il porre ben in evidenza le profonde contraddizioni degli abitanti dellisola, contraddizioni che, a ben guardare, sono in forme e misure diverse proprie di tutti gli italiani. E nemmeno lui è immune dalle contraddizioni, tanté che il libro non è definibile come genere in modo esatto, anche perché non pochi sono i suoi aspetti letterari, con espliciti riferimenti a grandi autori siciliani, in primis Tomasi di Lampedusa e Luigi Pirandello. È quindi più che logico chiedersi il perché della stesura di questo libro, il perché di questa ricerca quasi ossessiva per comprendere le caratteristiche di una popolazione che è sempre stata dominata, che ha sempre avuto tanti padroni, al punto da considerare gli abitanti gli inquilini dellisola. A tratti ridente, e assai più spesso aspra, questa terra ha forgiato anche il carattere delle sue genti, in balia di questo o quel dominatore, di una dinastia e di unaltra, sempre interessata a sfruttare i suoi possedimenti. Il siciliano sembrerebbe non avere lorgoglio di essere tale, come del resto litaliano, e quindi con un sentimento di nazionalità assai limitato. Ma Collura non è un disfattista, é solo un uomo che cerca la verità, come hanno fatto tanti altri autori siciliani (al riguardo basti pensare a Leonardo Sciascia che al cogliere ciò che si cela sotto lapparenza ha improntato tutta la sua produzione letteraria). Certo sentimentalmente è legato alla sua terra, ma appunto non vuole tacerne le incongruenze, tanto che il libro inizia a Portella della Ginestra, luogo che il 1° maggio 1947 fu teatro della strage compiuta da Salvatore Giuliano e dalla sua banda. Portella della Ginestra è un nome gentile, di quelli che fanno pensare a un panorama ameno, a un luogo quasi panteistico, e invece sarà sempre associato a un orrendo fatto di sangue. Il viaggio poi prosegue a Cassibile, llocalità in cui fu siglato larmistizio durante la seconda guerra mondiale e di quel posto storico, dove sotto una tenda il generale Castellano, plenipotenziario italiano, appose la sua firma a quella resa senza condizioni, non resta traccia, non cè nemmeno una stele, una targa a ricordare il fatto e questo costituisce lo spunto per parlare della Sicilia come terra di conquista. Sono tanti i luoghi e tante le occasioni, e non mancano le presenze di autentiche eccellenze letterarie, che ogni tanto si affacciano sulle pagine (Luigi Pirandello, Tomasi di Lampedusa, Sciascia, Brancati, tanto per citarne alcuni). E pagina dopo pagina si disegna limmagine di un popolo dalla natura irredimibile (come scriveva Tomasi di Lampedusa nel Gattopardo), al pari del paesaggio su cui in perfetta sintonia si muove, personaggi di una commedia della vita dalle infinite rappresentazioni, uomini e donne, in perenne contraddizione con ciò che è e che non dovrebbe essere e con ciò che non è che invece dovrebbe essere. Da leggere, per meglio conoscere non solo la Sicilia e i suoi inquilini, ma anche noi, al pari inquilini dellItalia.
Matteo Collura è
nato ad Agrigento nel 1945. Autore, fra laltro, del bestseller
Sicilia sconosciuta (Rizzoli 1984, 1997) e della versione teatrale
del romanzo di Sciascia Todomodo,
scrive articoli di cultura per il Corriere della Sera e vive a
Milano.
6/6/2014
Nero su nero
Edizioni Adelphi
Nulla gli sfuggiva Precetto per coloro che indagano nei misteri della Sicilia: se scoprite qualcosa, fatene subito la più larga divulgazione; è il solo modo per mettervi al sicuro. Anche se è un segreto fra voi e la persona che ve lha confidato, non tenetelo per più di unora: entro unora, appunto, la persona che ve lo ha confidato può cadere preda di pentimenti, di rimorsi; può rientrare nel grembo della sua chiesa dietro confessione e non senza penitenza. È nel 1979 che Sciascia pubblica Nero su nero, una specie di diario che comprende forse le pagine più feroci dellautore siciliano, in cui la sua capacità di analisi raggiunge vertici elevatissimi; nulla sfugge ai suoi occhi attenti delle vicende del nostro paese e in una serie di riflessioni, o addirittura anche di epigrammi riesce a delineare, senza remore e impietosamente, un quadro nitido dellItalia, lo stato dagli eterni fascismi nel suo periodo più oscuro e per certi versi tragico, quel decennio avviato nel 1969 con luccisione del poliziotto Antonio Annarumma, in quelli che poi furono giustamente chiamati gli anni di piombo. Non manca la caustica ironia, atta altresì stemperare fatti gravi ancor oggi avvolti nella nebbia, e al riguardo riporto di seguito la perla del cretino di sinistra: Intorno al 1963 si è verificato in Italia un evento insospettabile e forse ancora, se non da pochi, sospettato. Nasceva e cominciava ad ascendere il cretino di sinistra; ma mimetizzato nel discorso intelligente, nel discorso problematico e capillare. Si credeva che i cretini nascessero soltanto a destra, e perciò levento non ha trovato registrazione. Tra non molto, forse, saremo costretti a celebrarne lEpifania. A volte si tratta quasi di appunti, di note a fatti di per sé insignificanti, altre invece sono pertinenti ad accadimenti piuttosto noti. Ciò che però sorprende è lintento letterario che Sciascia sembra voler dare a questi suoi pensieri, pur senza tralasciare quella sua innata e portentosa capacità di analisi che lo ha sempre portato a mettere in discussione le verità ufficiale, per scendere in profondità, svelando nuove e spesso contrastanti altre verità. Si potrebbe dire che è uno Sciascia a tutto campo, ma pessimista, avviato inesorabilmente verso i suoi ultimi giorni, deluso ammesso che si fosse veramente illuso da unItalia incapace di perdere il suo difetto ben cronicizzato, quello di essere un paese senza verità. E in uno scrittore che tanto ha amato ricercare la verità, laver constato non solo limpossibilità di ottenerla, ma una persistente volontà di celarla deve essere stato quasi un trauma. Del resto, proprio le vicende degli anni di piombo, di quella serie sanguinosa di attentati che vanno da Piazza Fontana alla stazione di Bologna, delitti di cui ancora si sa poco, soprattutto sui mandanti, conferma tragicamente che quanto appurato da Sciascia è un male congenito del nostro paese. Evidenzio nuovamente la stupefacente capacità di analisi, perché se è relativa soprattutto a fatti notori, non manca quella di eventi che non sono stati di certo di dominio pubblico, accadimenti che si potrebbero definire privati, come incontri casuali, o stralci, a memoria, di colloqui le cui parole, dense di significato, sarebbero volate nelloblio se Sciascia non avesse provveduto a immortalarle in questo libro, spesso ironiche, alcune volte umoristiche (Si parla di politica. Il contadino mio vicino e mio amico a un certo punto dice: Una volta, qui in paese, cera una famiglia di buoni mastri-muratori. Io avevo bisogno di murare e sono andato da loro. Mi dissero: noi non possiamo, abbiamo molto da fare; ti mandiamo Merulla un muratore che conoscevo. E io dissi: e cè bisogno che me lo mandiate voi, Merulla? Ci vado io, a chiedergli di venire a lavorare da me. Fa una pausa e poi spiega la parabola: Io ho votato sempre partito comunista; ma alle ultime elezioni, il 13 maggio, mi sono detto: e che bisogno ho di farmi portare dal partito comunista alla democrazia cristiana? Ci vado io.) Di spunti per unanalisi ce ne sono tanti e i più svariati, da quelli che necessitano di più pagine a quelli per i quali bastano poche righe, secche, lapidarie (E ormai difficile incontrare un cretino che non sia intelligente e un intelligente che non sia cretino. Ma di intelligenti cè stata sempre penuria; e dunque una certa malinconia, un certo rimpianto tutte volte ci assalgono che ci imbattiamo in cretini adulterati, sofisticati. Oh i bei cretini di una volta! Genuini, integrali. Come il pane di casa. Come lolio e il vino dei contadini.). Insomma, in buona sostanza, ce nè per tutti i gusti in questo libro, scritto in modo gradevole, accattivante, come solo Sciascia sa fare, quasi che fosse lì davanti a noi a raccontare. Da leggere, senza ombra di dubbio.
Leonardo Sciascia (Racalmuto,
8 gennaio 1921 Palermo, 20 novembre 1989). E stato autore di saggi
e romanzi, fra cui: Le
parrocchie di Regalpietra (Laterza,
1956), Il
giorno della civetta (Einaudi,
1961), Il consiglio
dEgitto (Einaudi,
1963), A ciascuno il
suo(Einaudi, 1966), Il
contesto (Einaudi,
1971), Atti relativi
alla morte di Raymond Roussel(Esse Editrice, 1971), Todo modo (Einaudi,
1974), La scomparsa di Majorana (Einaudi,
1975), I pugnalatori (Einaudi,
1976), Candido, ovvero
Un sogno fatto in Sicilia (Einaudi,
1977), Laffaire Moro (Sellerio,
1978), Il teatro della
memoria (Einaudi,
1981), La sentenza
memorabile (Sellerio,
1982), Il cavaliere e
la morte (Adelphi,
1988), Una
storia semplice (Adelphi,
1989).
3/6/2014
Artemisia
Introduzione di Giuseppe Leonelli
Narrativa romanzo Da donna a donna Mi piace larte in generale, pur non essendo particolarmente competente, e in particolare la pittura, per la sua immediatezza, per le sensazioni che si imprimono allistante quando si ha occasione di guardare un bel dipinto. Fra i tanti pittori mi ha sempre colpito, per la drammaticità delle sue opere e per i sapienti giochi di luce, Michelangelo Merisi, più conosciuto come il Caravaggio. Nellinteressarmi a lui ho incontrato una pittrice vissuta nella prima metà del XVII secolo e che, a suo modo, riprendeva nelle sue tele lo stile caravaggesco. Il suo nome è Artemisia Gentileschi, una donna, quindi, che ha operato in unepoca in cui ancora lessere femmina costituiva una evidente subordinazione al maschio, limitandone le possibilità insite nella sua personalità. E in effetti, se pur brava nella sua arte, molto della sua fama è dellesser stata un personaggio che, molto in anticipo sui tempi, ha rivendicato il diritto a una pari dignità, e non solo con la sua professione, ma anche con i suoi comportamenti. E evidente che ho avvertito la necessità di conoscerla maggiormente e al riguardo non poco è stato scritto su di lei, e in questo Artemisia di Anna Banti e uno di questi libri, anche se per impostazione e struttura non è tanto unopera di storia dellarte, quanto piuttosto un omaggio a unantesignana nella lotta per lemancipazione femminile. La narratrice, sulla base di ricerche di archivio e di opere pittoriche, ricostruisce la vita di questa grande artista, conferendo al suo scritto un alto valore letterario, intrecciando due periodi temporali. Infatti il manoscritto di Artemisia era già pronto in un cassetto nel 1944, quando andò perduto durante la battaglia di Firenze con la distruzione della casa in cui risiedeva la Banti, che finita la guerra lo riscrisse, memore di quanto era accaduto con la perdita di questo suo prezioso lavoro. E così, in una città devastata dal conflitto, si aggira la narratrice, con il ricordo della vita di Artemisia. Passato e presente non sono più due entità distinte, ma si uniscono nella drammaticità dellesistenza della pittrice e in quella di una città ferita dalla guerra. Anna Banti, pur in preda allo sconforto per quel libro perduto, trova una nuova energia, una motivazione più forte di quella per cui laveva scritto, e cioè far riemergere dalloblio del tempo la figura di Artemisia, di questa donna che fra mille difficoltà raggiunse una sua indipendenza e la cui arte è stata il simbolo di un riscatto per tutte le donne. La Gentileschi ha lottato, ha infranto barriere secolari, anteponendo a tutto, alla famiglia, alla sua stessa esistenza, quellarte che ha finito per renderla immortale. Da donna a donna, da scrittrice a pittrice, in un certo senso autore e protagonista finiscono con lincontrarsi in più punti e la Banti rende un omaggio a questa antesignana dellemancipazione femminile, ricordandola, tracciandone con mano lieve, ma ferma, la storia della sua vita. Sono due personalità di epoche diverse, ma il piglio battagliero, la forte motivazione di rivendicare tramite la propria arte (per una la pittura, per laltra la scrittura) la libertà di potersi realizzare le accomuna. Scritto con uno stile impeccabile, anche se qualcuno potrà rimarcare luso di un italiano che ai tempi attuali può apparire obsoleto (ma nostra lingua è quella e non certi sproloqui che si incontrano in non pochi romanzi doggi, infarciti da neologismi e anglicismi spesso fuori luogo), venato da una soffusa malinconia, il romanzo si svolge come un ciclo di pale daltare, una serie di quadri, di figure ritratte a parole che impreziosiscono ulteriormente lopera. Quel che colpisce di più, data la particolare complessità della struttura, è però la levità, una mano leggera che finisce con lavvincere il lettore, che, pagina dopo pagina, avverte chiara la sensazione di trovarsi di fronte a qualche cosa di unico, a un libro profondo e assai gradevole.
Anna Banti (pseudonimo
di Lucia Lopresti)
nacque a Firenze il 27 giugno 1895 e morì a Ronchi di Massa il 2
settembre 1985. Scrittrice e traduttrice, sposò nel 1924 il critico
darte Roberto Longhi con il quale fondò la rivista Paragone,
della quale diresse a lungo la sezione letteraria. Tra i suoi libri
più noti Artemisia (1947), Le
donne muoiono (1951)
Premio Viareggio e i racconti raccolti in Campi Elisi (1963). Celebri
e bellissime anche le traduzioni dei classici inglesi e francesi tra
cui Thackeray,
Colette, Fournier, Austen,
Woolf e la curatela del Meridiano dedicato a Defoe.
27/5/2014
Presagio
Sellerio Editore Palermo
Narrativa romanzo
I giorni prima delluragano Questo romanzo storico esce proprio nellanno in cui si celebra il primo centenario dello scoppio della Grande Guerra, un conflitto che, al di là di quello che costò in milioni di vite umane, segnò una svolta epocale, con la fine dellEuropa quale entità capace di dominare la scena planetaria, con la caduta di tante monarchie, con lavvento di un regime comunista e negli anni immediatamente successivi alla sua fine con il sorgere in Italia del fascismo e in Germania del nazismo che portarono al secondo grande scontro mondiale. Andrea Molesini ha colto questa occasione per imbastire unopera strutturata come una tragedia greca (un prologo, tre atti e un epilogo), ambientando la trama nella sua Venezia, allepoca meta di soggiorno della più facoltosa nobiltà e borghesia europea. Quella descritta non è una città da cartolina, anzi è limitata al Lido e allisola di San Servolo, lisola dei matti, sede appunto del manicomio. Lautore, tuttavia, non si limita solo a proporre una vicenda su quelli che furono gli ultimi giorni di pace, ma va ben oltre, scende nei meandri dellanimo umano per evidenziare quanto ineluttabili appaiano le grandi e piccole scelte nel destino di ognuno e tanto qui a maggior ragione si comprende come siamo solo dei predestinati. Non è un caso quindi se lopera è introdotta da una frase di Rainer Maria Rilke (Il futuro entra in noi, e si trasforma in noi, molto prima di accadere); questa epigrafe, scritta dal grande poeta di lingua tedesca proprio in quel periodo, significa in buona sostanza che ogni essere umano sa, sia pure inconsciamente, quel che è prima che lo diventi. E una premessa drammatica e ben calza allo svolgimento di questo bellissimo romanzo. Se fino a ora ho esposto lopera nelle sue linee generali, ritengo opportuno adesso dare qualche notizia in più, affinché il lettore si faccia unidea più precisa. È il luglio del 1914, il 28 giugno Gavrilo Princip a colpi di pistola aveva spento a Sarajevo le vite dellArciduca Francesco Ferdinando, erede al trono di Austria-Ungheria, e di sua moglie Sofia, lo stato febbrile volto a una guerra, già in atto da tempo, ha colto nellattentato ai reali loccasione propizia per concretizzarsi. Schermaglie diplomatiche, più che altro dimostrative, animano quel mese di luglio, ma ciò che già da tempo era stato deciso trova finalmente il suo sbocco in una guerra che è il disperato tentativo per monarchie ormai obsolete di contrastare la loro naturale fine, ed é così che queste (impero russo, impero austro-ungarico, impero turco-ottomano e lancor giovane, ma troppo tardi instaurato impero germanico) buttano sul tavolo da gioco della storia le loro consunte carte, così che il 28 di luglio scoppia la prima guerra mondiale. A Venezia, allHotel Excelsior, il gran mondo riempie di frivoli cicalecci i saloni, esponenti di unepoca, chiamata Belle Epoque, in cui tutto sembra eternamente spensierato, in cui, dietro un paravento di eleganza e nobiltà, si cela un profondo malessere, una povertà di valori destinata, prima o poi, a esplodere. Molesini avrebbe potuto parlarci di questi sconosciuti per spiegarci quei giorni, ma anziché scrivere un romanzo corale, come i suoi due precedenti, preferisce imperniare la sua trama su due soli protagonisti, il commendator Spada, proprietario dellHotel e una sua avvenente cliente, la marchesa Margarete von Hayek. Luomo non è insensibile al fascino della nobile dama, ma è un pragmatico e comprende che per lui ella può rappresentare solo un esaltazione dei sensi e non un vero e proprio amore, e di ciò ne trae profitto, accompagnandosi con lei senza patemi, ma con impeti carnali. Lei è una femmina fatale, pericolosa quindi, e depositaria di un segreto che, una volta svelato, ce la mostra in unaltra luce. In questo contesto intimo la mostruosa macchina volta allinizio di una guerra acquista sempre più velocità, fino a quando il 28 luglio lAustria dichiara guerra alla Serbia, che ha rifiutato un ultimatum impossibile da accettare secondo il buon senso. Il discorso con cui il commendator Spada comunica ai suoi ospiti, seduti a tavola per la cena, linizio delle ostilità è per me la parte più bella del libro e già da sola giustifica la lettura dellopera. Non cè retorica nelle parole dellalbergatore veneziano, ma tanto giudizio e soprattutto umanità. Sono pagine che si leggono con vivo piacere, provando unindicibile emozione. Quella dichiarazione di guerra risuona nel silenzio generale del salone come una condanna per gli appartenenti a un mondo che da lì a pochissimo sparirà e della Belle Epoque, in cui tutto sembrava possibile purché lo si volesse, non resterà che un vago ricordo e i dipinti del can can di Toulouse-Lautrec. Nel romanzo di Molesini questo passaggio, questa fine di unera è ben descritta, benché sembri toccare solo le anonime comparse del suo libro. Per i due protagonisti e soprattutto per la marchesa la convinzione che sia stato spazzato via un modo di vivere la vita in nuce già esiste in loro, nella loro storia damore senza speranza, nella estrema sensualità di lei, secondo un copione già noto, ma con una sua peculiarità: lei tende ad autodistruggersi, magari coinvolgendo altri, come un presagio, lo stesso che sotto forma di incubo accompagna le notti del commendatore, con quella bestia che è in noi ed è pronta ad azzannarci. Guai a contrastarla, perché in fondo la guerra è lemblema di quella bestialità che ci è propria e solo con la consapevolezza che è tipica dellartista che si limita a osservarla e a descriverla è possibile non essere dalla stessa sopraffatti. Romanzo che mette allo scoperto la più recondita natura delluomo, Presagio è scritto con signorilità, senza mai trascendere e anzi misurando le parole una per una (stupendi al riguardo i duelli verbali fra i due protagonisti), è volto a un messaggio universale, a una ricerca della verità, a quel Wahrheit con cui inizia il libro, che si chiude con un finale enigmatico, ma segnato da una profonda pietà. Se limpianto è teatrale, in un contesto di crescente tensione in cui par già di udire i tuoni delle cannonate, Molesini ha il pregio indiscutibile di accompagnare a una tragedia una vena poetica di cui sia i due protagonisti che lintero libro beneficiano ampiamente, e questo ha effetto anche sul lettore che giunto allultima pagina ricava netta la sensazione di aver letto qualche cosa di molto diverso dal solito, di avere per le mani unopera di grande valore letterario, una di quelle che, benché riferita a unepoca, è senza tempo, stupenda oggi come lo sarà domani.
Andrea Molesini ha
pubblicato con Sellerio Non tutti i bastardi sono di Vienna,
che nel 2011 ha vinto, tra gli altri, il Premio Campiello e il
Premio Comisso, tradotto in inglese, francese, tedesco, spagnolo e
molte altre lingue, La primavera del lupo (2013) e Presagio (2014).
24/5/2014
L'ombra del bastone
Arnoldo Mondadori Editore S.p.a. Delitto e rimorso * Lultima notte a Erto in quel po che ho dormito, ho sognato mia mamma che mi faceva un po di posto nel suo letto perché ero congelato dal freddo. Mi ha detto: Vieni qui che ti scaldo come quando eri piccolo. Ma intanto che montavo dentro il paglione per scaldarmi, è arrivata sua sorella, la zia delle formiche in bocca, e gli ha detto a mia mamma di non farmi posto nel letto perché io non mi sarei scaldato mai più. Ormai ero fatto di ghiaccio e se mi faceva entrare nel suo letto avrei ghiacciato anche lei, e sarebbe morta congelata come Jacon Piciol. Ma mia mamma non voleva sentir ragioni e mi ha preso per una mano per portarmi a scaldare nel letto. Allora la zia che beveva, con la faccia come scheletro della morte, mi ha preso per un braccio e con uno strattone mi ha tirato via da mia mamma urlando che era rivato il tempo di finirla che copassi gente, ne avevo copati abbastanza, adesso era ora che qualcuno mi copasse anche me perché mi era entrato il diavolo nel sangue e non sarebbe saltato fuori se non con la mia morte.* Mauro Corona ha scritto tre romanzi che costituiscono una trilogia, chiamata Trilogia della Morte, in quanto questa è sempre incombente e non sono mai a lieto fine per il protagonista principale. Per uno strano caso ho letto dapprima il secondo (Storia di Neve), poi il terzo (Il canto delle manére) e infine per ultimo quello che è invece è il primo. Mi riferisco a Lombra del bastone, una trama che, per come è riportata, può anche far pensare che rispecchi un fatto realmente accaduto e al riguardo già dallinizio la vicenda appare verosimile, poiché è scritto che a casa del narratore ertano si presenta un tizio della piana friulana per consegnare un vecchio quaderno del 1920 trovato in un pertugio di una stalla e che è scritto come un diario. Le pagine sono rovinate dal tempo, appiccicate luna allaltra, come incollate, ma Corona è paziente e con calma le separa. E proprio un diario che riporta la storia del suo estensore, che peraltro si firma (Severino Corona, detto Zino), e proprio questo nome incuriosisce ulteriormente Mauro Corona, in quanto pensa, non a torto, che si possa trattare di un parente. Con calma trascrive il testo, rispettando la lingua un po sgrammaticata e intervenendo solo per tradurre qualche parola che lì è in dialetto. Nasce così uno dei più bei romanzi che sia uscito dalla penna di Corona, un testo avvincente e che ha il pregio della spontaneità, come se proprio fosse stato stilato da questo Severino Corona, il che indurrebbe proprio a confermare lautenticità del fatto e, se pur qualche dubbio mi rimane, non vedo per quale ragione non possa essere reale e non un parto di fantasia. Magari ci sono aggiustamenti nella trama, accostamenti temporali là dove non si rispettava un preciso ordine logico, ma appaiono come i necessari interventi per consentire un agevole e piacevole lettura di un evento accaduto. Non so se questo valga per altri, ma nel mio caso dico in tutta sincerità che quando ho per le mani un testo di questo autore è come se la quotidianità venisse meno, é come se, allimprovviso, ritornando indietro nel tempo, annullassi la percezione temporale. E così le pagine scorrono come un torrente pacioso nel piano, di certo aiutate da uninvidiabile fluidità della scrittura, da una concatenazione di eventi che non lasciano tempi morti, dallo spettacolo forte, austero di una natura incontaminata che ormai sembra preistoria. In questa natura, aspra, selvaggia, a volte poeticamente fiabesca, si aggirano personaggi oggi introvabili, pure loro selvaggi, ancorati a tradizioni, riti e superstizioni proprie di una civiltà ormai scomparsa. E un mondo dove tutto appare agli estremi, in cui le passioni, quali lamore, sono violente, quasi animalesche, dove si nasce in miseria, si vive faticando e anche penando e si muore per disperazione. La storia di questo Severino Corona, che ha assassinato un uomo, marito della sua amante, un uomo che è sempre stato suo amico e che con il trascorrere del tempo vive nellangoscia del rimorso è quanto di più realistico, e anche struggente, che mi sia capitato di leggere. E in questa trama si trovano personaggi che saranno i protagonisti degli altri due romanzi della trilogia, figure che accennano una luce al bagliore che invece esploderà quando a loro sarà dedicato un intero libro.
Ci si commuove sin dora alla vicenda di Neve, di questa bimba unica
nata in un inverno di copiose precipitazioni nevose, si resta fra
lincredulo e lo sgomento per la vecchia Melissa, la strega murata
nel ghiaccio, si avverte il freddo dei gelidi inverni, si assapora
laroma degli abeti tagliati, nelle orecchie risuona il fluire del
torrente Vajont, si sogna a occhi aperti lasciando scorrere le
immagini che le pagine propongono e alla fine, chiuso il libro, si ha
una netta sensazione di appagamento, come se quella storia fosse la
storia che da tempo si aspettava di leggere.
Mauro Corona è
nato a Erto (Pordenone) nel 1950.
21/5/2014
Tempo di uccidere Ed.
Rizzoli
Nell' epigrafe compare un passo dell'Ecclesiaste ...tempo di uccidere e tempo di sanare; tempo di... Tempo di uccidere è il primo libro di Ennio Flaiano scritto dietro le affettuose insistenze di Leo Longanesi e pubblicato nel 1947; con questa opera lo scrittore vinse il premio Strega. Da questo libro è stato tratto un film del 1990 con la regia di Giuliano Montaldo. La storia è ambientata in Africa, verso la fine della brutale conquista italiana in Etiopia. Protagonista è un ufficiale italiano, emblema di un carattere universale che accomuna chi condivide un destino simile. Pur in una collocazione storica ben precisa, i fatti si svolgono come sospesi nel tempo in un'atmosfera surreale in cui i luoghi naturali diventano parte degli smarrimenti della ragione del protagonista. Il tenente si trova suo malgrado implicato in una guerra nazionalista, inane ed aggressiva dove il concetto di popolazioni incivili e dunque inferiori è il centro motore delle motivazioni. Sono tristi animali incapaci di avere altri pensieri oltre quelli suggeriti dalla più elementare natura. Il giustificazionismo della colonizzazione, nella realtà sterile, in una guerra inutile, spinge i soldati ad uccidere come un meccanismo inevitabile ed inarrestabile. In un'Africa che di esotico non ha nulla (Flaiano non ama l'Africa dei vincitori fascisti, se in una terra nasce la iena ci deve essere qualche cosa di guasto), tra paesaggi aridi in cui si slargano valli e forre e altopiani con alberi senza frutti, gli Italiani conquistatori spadroneggiano, violentano ed uccidono e concedono il documento di sottomissione a chi non si ribella. Tutti gli accadimenti non avvengono in presa diretta, ma attraverso il continuo arrovellarsi dei pensieri del tenente in una serie concatenata di azioni, il mal di denti che gli permette una breve licenza, l'incidente dell'autocarro, il sentiero su cu si inerpica, un labirinto inestricabile, l'uccidere poi una donna accidentalmente ferita e poi soppressa come si fa con gli animali, due tentati omicidi prima ad un dottore e poi ad un maggiore che traffica in loschi affari. La guerra è rappresentata come fondale del romanzo, ma non per questo meno cruenta, il protagonista un imbelle, meschino e codardo, forse così gli eventi bellici l'hanno ridotto, ai sensi di colpa, che semmai solleticano appena la sua coscienza, subentrano sempre degli alibi per tutto quello che compie. Quegli afrori che emana la terra misti a quelli dei cadaveri, l'immagine di Mariam, la bella etiope, dal turbante bianco che si lava in una delle pozze, accosciata come un buon animale domestico sono le ombre della sua mente obnubilata dalle tensioni a cui è sottoposto. La pietà verso la giovane uccisa è frammista all'imperativo Dovevo ucciderla, molte ragioni mi consigliavano di ucciderla, tutte ugualmente forti. A sua discolpa c'è la vanità della vita alla quale si aggrappa disperatamente, l'amore per la moglie lontana e la paura di essere stato contagiato dalla lebbra. E' un girone infernale la sua avventura africana, i 40 giorni che trascorrerà nella valle, come una preda inseguita e nascosta, con Johannes, l'ex ascaro dai silenzi misteriosi come la sua terra che vive da solo nel villaggio sterminato, sarà biblicamente la quaresima dei suoi peccati e come un lavacro che monderà e assolverà ogni sua colpa. Infatti nessuno lo cerca per i suoi delitti e nessuno ha aperto un'indagine a suo carico né alcuna denuncia: Il prossimo è troppo occupato coi propri delitti per accorgersi dei nostri (le parole del sottotenente con cui s'intrattiene al campo). Tempo di uccidere come esplicita il titolo nella guerra uccidere è un salvacondotto per la pace...
Come afferma Maria Bellonci una
delle fondatrici del premio Strega, è un'avventura
dell'anima, una vicenda della coscienza nella quale lievita il dramma
sotto gli stimoli delle cieche ed incongue circostanze.
In questo
romanzo così enigmatico, il realismo sfuma in allegoria e in questo
senso l'intricato viaggio che intraprende il protagonista è l'oscuro
percorso di un'anima che sembra aver perso il fine di esso:
una singolare parabola di umana
colpevolezza voluta dal fato e cancellata dal caso.
Così come il libro si presta a molteplici interpretazioni che sono i
riflessi dell'ambiguità umana così per tante ragioni si rivela una
lettura estremamente attuale: nella concezione della guerra, una
realtà di abbrutimento, senza scopo, nella ripugnanza che Flaiano
esprime per la guerra e la vita militare, nello stile sobrio e netto,
così sottile e penetrante frutto di un'acuta e lucida intelligenza.
Un romanzo classico e moderno che invita a leggere i grandi romanzi
del passato e non sempre quelli contemporanei che danno, spesso, solo
aggiornamenti per sbandierate Presentazioni di libri o
conversazioni da salotti pseudoletterari e non spunti di riflessioni
e di indurre a guardarci dentro.
La città di Miriam
Marsilio Editori
Credo di sapere tutto sulle donne, cosa pretendono, di che cosa si accontentano, dove vogliono arrivare, compreso il limite cje loro stesse non pensavano di abbattere. Perché, inversamente a loro, io non perdo il controllo, e ho più appreso dalle recenti disavventure che dai passati successi. Mi sciamano davanti senza mai giungere a toccarmi direttamente, come gli odori e i suoni durante lovattamento. Corre lanno 1972 quando Fulvio Tomizza pubblica La città di Miriam, terzo romanzo, dopo La quinta stagione e Lalbero dei sogni, in cui è protagonista Stefano Marcovich, giovane profugo istriano di origini contadine, e che rappresenta, sotto molti aspetti, lautore stesso. I riferimenti personali, infatti, hanno riscontri frequenti con la vicenda narrata. In particolare, come nel libro, Tomizza nel 1954, quando la Zona B del Territorio Libero di Trieste, compresa Materada dove risiede, passa alla Jugoslavia, lui emigra, viene in Italia e si trasferisce a Trieste. È lì che conosce Laura Levi, di cui si innamora e che poi sposerà ed è sempre a Trieste, che finirà per eleggere a sua dimora, che inizia a occuparsi di scrittura. Infine, precisi e puntuali i riferimenti, i tradimenti coniugali presenti nel libro non sono frutto di pura invenzione, perché Tomizza, benché amasse la consorte, si dedicava a non infrequenti scappatelle. E se è vero che nel lavoro di qualsiasi scrittore ispirazioni e svolgimenti sono frutto di esperienze personali, la circostanza è ancor più probante nel caso dellautore istriano. Anche in questo libro è presente quel senso di non appartenenza che accompagnò Tomizza per tutta la vita, poiché lItalia altro non era che un paese che lo ospitava, con cui condivideva la lingua e anche una parte della cultura, ma lui restò sempre profondamente istriano, legato a quella terra aspra e selvaggia eternamente di frontiera. Ma La città di Miriam non è solo un romanzo sullimpossibilità di sentirsi membro naturale e a tutti gli effetti di una nuova patria, è anche, soprattutto, unopera sullamore coniugale, su quei tradimenti di cui Miriam è vittima incolpevole, la dolce serena Miriam, unaffascinante figura femminile tratteggiata con sincero affetto e anche devozione. Non è rara lironia che pervade il romanzo, come quando il protagonista cerca delle giustificazioni, puerili e improbabili, per i suoi tradimenti e devo dire che, considerata la vena autobiografica, pur non avendo potuto conoscere Tomizza, sono portato a immaginarlo come un uomo in bilico fra felicità e infelicità, fra soddisfazione e insoddisfazione, insomma un essere umano, strappato a forza dalle sue origini, trapiantato in un mondo vicino territorialmente, ma lontano dai suoi usi e costumi, uno straniero a tutti gli effetti, anche a se stesso. Di gradevole lettura (lo stile di Tomizza alterna sempre una narrazione fluida, a volte cruda, con parentesi di di dolcezze poetiche), La città di Miriam è un romanzo che merita di essere letto, capace comè di venire incontro a molte delle aspettative di un normale lettore, che di certo, nel prendere le difese di Miriam, non si sentirà tuttavia capace di biasimare con durezza Stefano.
Fulvio Tomizza (Giurizzani di Materada, Umago,
26 gennaio 1935 - Trieste, 21 maggio 1999). Figlio di piccoli
proprietari agricoli, dopo la maturità classica, si trasferì a
Belgrado e a Lubiana, dove iniziò a lavorare occupandosi di teatro e
di cinema. Ma nel 1955, quando l'Istria passò sotto la Jugoslavia, Tomizza,
benché legato visceralmente alla sua terra, si trasferì a Trieste,
dove rimase fino alla morte. Scrittore di frontiera, riscosse ampi
consensi di pubblico e di critica (basti pensare ai numerosi premi
vinti: nel 1965 Selezione Campiello per La quinta stagione,
nel 1969 il Viareggio per L'albero dei sogni, nel 1974, nel
1986 e nel 1992 ancora Selezione Campiello rispettivamente per Dove
tornare, per Gli sposi di via Rossetti e per I rapporti
colpevoli, nel 1977 e nel 1979 lo Strega e quello del Governo
Austriaco per la letteratura Europea per La miglior vita. Ha
pubblicato: Materada (1960), La ragazza di Petrovia (1963), La
quinta stagione (1965),Il bosco di acacie (1966), L'albero
dei sogni (1969), La torre capovolta (1971), La città
di Miriam (1972), Dove tornare (1974), Trick, storia di
un cane (1975), La miglior vita(1977), L'amicizia (1980), La
finzione di Maria (1981), Il male viene dal Nord (1984), Ieri,
un secolo fa (1985), Gli sposi di via Rossetti (1986), Quando
Dio uscì di chiesa (1987), Poi venne Cernobyl (1989), L'ereditiera
veneziana (1989), Fughe incrociate (1990), I rapporti
colpevoli (1993), L'abate Roys e il fatto innominabile (1994), Alle
spalle di Trieste(1995), Dal luogo del sequestro (1996), Franziska (1997), Nel
chiaro della notte (1999).
20/5/2014
Ci vediamo lassù Pierre Lemaitre E. Mondadori 2014 Titolo originale Au revoir là-haut Traduzione di Stefania Ricciardi Vincitore del Prix Gongourt 2013
Questo romanzo di ampio respiro narrativo trae il titolo dalle ultime parole scritte dal soldato Jean Blanchard, fucilato per tradimento il 4 dicembre 1914, (è stato riabilitato il 29 gennaio 1921) alla moglie. Ti do appuntamento in cielo dove spero che Dio ci riunirà. Ci rivediamo lassù, mia diletta moglie... Siamo sul fronte francese, nell' imminenza dell'armistizio del novembre 1918; la Grande guerra sta per finire, ma non la sorte miserrima di molti reduci. Tutti i morti mietuti nel conflitto, più di 35 milioni, aspettano una degna sepoltura, non la retorica dei caduti, tanti, troppi giovani vittime sacrificali in nome di un distorto senso di patriottismo. In tutta la storia è insito il non senso della guerra, l'orrore delle trincee, la paura continua ed opprimente delle esplosioni delle granate e i colpi inferti dalle baionette. La brutalità della guerra è descritta con grande realismo, non gli onori e i vanti di atti di eroismo, ma fango, freddo, sporcizia, malattie, amputazioni, mutilazioni, cadaveri putrescenti e l'aria ammorbata dalla polvere e dal frastuono delle mitragliatrici. Le vite di due soldati Albert Maillard ed Édouard Péricourt s'ncroceranno durante l'assalto contro i crucchi, l'ultimo di Quota 113: Édouard nel tentativo di salvare la vita di Albert sotterrato in una buca è irrimediabilmente sfigurato in volto da una scheggia di granata grossa come un piatto fondo, abbastanza spessa e a una velocità vertiginosa. Su di loro aleggia maleficamente la figura del tenente, d'Aulnay-Pradelle, aristocratico sprezzante e brutale, tanto prestante nell'aspetto fisico quanto sordido nell'animo. Uomo abietto, selvaggio e primitivo, pur di ricoprirsi di gloria ordina un'inutile missione di ricognizione, che trasforma in un'azione d'offensiva sacrificando volutamente delle vittime. Albert è un giovane ed insicuro impiegato di banca, Édouard è di famiglia ricca e potente, dai modi eccentrici, sa esprimersi con il disegno manifestando notevoli doti artistiche, si porta dentro un difficile rapporto paterno. Dopo il congedo Albert per un forte senso di riconoscenza non abbandona Édouard al suo destino, lo assisterà devotamente, perchè si sente responsabile della sua grave e permanente menomazione fisica, il viso, dal naso in giù è una voragine a cielo aperto. In una Parigi sovraffollata di reduci che non sa cosa farsene, Édouard intontito dalla droga, in uno stato perenne di estrema prostrazione, non vuole mostrarsi alla sua famiglia sia per le orrendo aspetto fisico sia per un non risolto e difficile rapporto con il padre; infatti risulta morto in quanto per pietosa acquiescenza Albert aveva aiutato l'amico a cambiare identità scambiandola con quella di un soldato morto. Il romanzo si sviluppa con le vicende del Tenente Pradelle promosso capitano che per circostanze fortuite sposerà la sorella di Édouard, Madaleine, costui manovrerà loschi traffici, malversazioni ai danni dello Stato e delle vittime di guerra che culmineranno nello Scandalo delle esumazioni militari. Per Albert e Édouard sarà una discesa negli inferi, una estenuante fatica per soffocare i fantasmi dell'esperienza bellica che l'uno ha impresso nell'animo e l'altro in maniera indelebile anche nel fisico. Quasi come una sfida al mondo e agli uomini che li hanno privati della loro anima, essi organizzeranno la grande truffa dei monumenti ai caduti: Il ricordo patriottico. Édouard e Albert s'inventano una società fittizia che vende falsi monumenti ai caduti, in tal senso inviano ai comuni limitrofi a Parigi l'offerta di queste commesse, una serie di disegni con tutti i dettagli minuziosi di forme, misure e utilizzo di materiali con pagamento anticipato di una quota. Una volta ricevute le commissioni e le somme corrispettive, sarebbero scappati defraudando così le amministrazioni pubbliche e migliaia di sottoscrittori, ma rivelando anche quanto di insana speculazione si nascondesse dietro le celebrazioni e gli onori ai caduti. Ci rivediamo lassù è un romanzo dalle tinte forti, realistico e crudo, con accenti anche ironici e sarcastici, scava a fondo non tanto sulle dinamiche della guerra quanto sulle conseguenze di essa, nefaste per tutti. In primis, per coloro che hanno perso la vita, il cui ricordo sono migliaia di croci che affollano prematuramente tanti cimiteri, per i reduci devastati nel fisico e nella mente, come se la guerra non fosse mai finita, tanti ridotti a relitti umani segnati per sempre, altri simili a belve feroci, losche figure di approfittatori, convinti che la guerra offre nuove opportunità, altri ancora che si reiventano un'esistenza sviluppando un'inventiva geniale non potendo contare solo sulle pensioni assegnate dallo Stato. La guerra è come se non fosse mai finita, è un po' come in trincea. C'è un nemico che non vedi mai, ma che senti con tutto il suo peso. Dipendi da lui. Il nemico, la guerra, la burocrazia, l'esercito, sono tutte cose un po' simili, nessuno ci capisce niente e nessuno sa risolverle una volta per tutti.
Lemaitre in una maestoso affresco
francese che richiama alla memoria la grande narrativa europea ci
porta a conoscenza, con documenti storici alla mano,
il business
della guerra
1914-1918.
19/5/2014
Di buona famiglia
Longanesi Editore
Premetto che non avevo mai letto nulla di quanto scritto da Isabella Bossi Fedrigotti e così per cominciare ho preso in mano questo romanzo, solleticato anche dal fatto che ha vinto il Premio Campiello. E unopera, questa, per certi aspetti atipica, stante unimpostazione senzaltro originale, divisa comè in due parti pressoché uguali come lunghezza e ognuna delle quali porta il nome di una delle due sorelle protagoniste. Nella prima Clara, la minore, ormai avanti con gli anni, parla a se stessa e il suo è un continuo volgersi allindietro per raccontarsi la vita trascorsa, in quella dimora in cui tuttora abita. Di nobile famiglia asburgica, con i genitori tesi a ripetere la stessa esistenza condotta dai loro avi, la donna si è costretta a una identità consona e conforme alle tradizioni di famiglia, in una acquiescenza e obbedienza che sembrerebbero spontanee, innate; in pratica si è trascinata negli anni senza un impeto di vitalità, ma solo ligia al cliché di un mondo in cui tutto è regolato da consuetudini che tendono a cristallizzare il tempo in un unico lunghissimo istante. Non si è sposata, anche se ha avuto un promesso sposo, ovviamente non di sua libera scelta, ma questi per ben due volte il giorno del matrimonio ha disertato laltare e lei ha continuato a vivere nellillusione che, prima o poi, si sarebbe deciso a compiere quel passo, da lei visto come unistituzione propria di ogni donna di buona famiglia. Virginia, la maggiore, a cui è dedicata la seconda parte e che parla in prima persona, è invece una ribelle, una apparente anticonformista, che ha un desiderio di libertà che si identifica con la sua ricerca disperata di un amore, anche di convenienza, che la tolga da quel mondo così noioso e ripetitivo. Ora è anche lei nella vecchia casa, con Clara, ad ascoltare silenzi che pesano come macigni Le loro non sono voci, sono urla, ricordi frammentari di unesistenza che probabilmente vorrebbero non fosse mai stata, entrambe quindi insoddisfatte. Il contrasto latente fra i due caratteri finisce con lesplodere, così che si ha limpressione di trovarsi di fronte alla sorella buona e alla sorella cattiva, ma quella buona è lobbediente Clara e quella cattiva la ribelle Virginia? O forse è il contrario? A una prima lettura è immediata la simpatia per Clara, ma in seconda battuta questa quasi certezza pare incrinarsi, e non sono riuscito a parteggiare in questo conflitto per luna o per laltra, anche se trovo in Clara una femminilità tipicamente familiare. Letà, però, smusserà il dissidio, pur non risolvendo i contrasti di fondo e se anche Virginia lancia quasi un anatema secondo il quale è suo il desiderio di morire per prima, in modo che Clara, definitivamente sola sia costretta a compatirsi, chi ne esce vincitrice è proprio questa, ma non ci può essere soddisfazione in unesistenza monotona, in una vita vissuta per metà. Il romanzo è una bella prova di stile, perché non era facile condurre questa contrapposizione non su uno stesso piano, ma su piani separati, in un sottile gioco a cui il lettore piano piano finisce con il partecipare, non come protagonista, ma come giudice. E nulla vieta che le risultanze possano essere diverse da individuo a individuo e sia sempre possibile ribaltare le proprie impressioni, quasi come in un giallo in cui il presunto colpevole e il probabile innocente si confondono. Considerata però la tematica e anche le particolari sensibilità delle due protagoniste finisce con lessere un libro che può essere maggiormente apprezzato e compreso da un pubblico femminile e senza che con questo non possa risultare gradito ai maschi, che tuttavia probabilmente non saranno in grado di cogliere sottigliezze peculiari dellaltro sesso.
Da leggere.
15/5/2014
Comallamore
Arnoldo Mondadori Editore S.p.A.
Solo buone intenzioni Comallamore è un romanzo colmo di buone intenzioni, rimaste però per lo più tali. Certo, parlare della pazzia, dei matti, avvicinarli, cercare di entrare nella loro mente è un compito arduo, di notevole difficoltà anche per un esperto psichiatra e Riccarelli non lo era; però, molto opportunamente ha preferito accostarsi a questo argomento non scientificamente, perché gli sarebbe stato impossibile, ma con la forza dellamore, che sicuramente non gli mancava e con la sua sublimazione, con quella pietà merce tanto rara ai giorni nostri. La trama è una di quelle che ben si presta a costituire un romanzo avvincente, perché un uomo anziano, a una giornalista che gli chiede dei matti del Pianoro e del partigiano Collamore, racconta in pratica la sua storia, la sua vita di povero sciancato per un incidente giovanile di gioco, la sua impossibilità a proseguire gli studi di laurea in medicina per limprovvisa morte del padre, il suo conseguente e necessario avviamento al lavoro, trovando unoccupazione presso il manicomio che confina con la sua casa, da cui osservava questi poveri pazzi trascinare stancamente e stranamente le loro esistenze. Beniamino, questo è il nome delluomo, diventerà medico sul campo, senza dover ricorrere a conoscenze specifiche, ma amando questi matti, cercando di comprenderli e di alleviare la loro sofferenza come bene gli aveva insegnato il dottor Rattazzi, contrario a una certa medicina ufficiale e in particolare alla pratica dellelettrochoc. Siamo negli anni del fascismo che precedono la seconda guerra mondiale, che poi arriverà sconvolgendo quel piccolo mondo e contrapponendo la pazzia dei pazienti con la follia di un conflitto. Quindi cerano tutti gli ingredienti per poter scrivere un grande romanzo, ma purtroppo le intenzioni, pur buone, sono rimaste tali, senza i necessari approfondimenti, se non una serie di abbozzi di problematiche. Per esempio, secondo me Riccarelli avrebbe dovuto andare più a fondo sulla pazzia della guerra, e non limitarsi alla ferocia di un ufficiale tedesco, perché qualsiasi conflitto rivela il peggio di ogni essere umano e questo non è necessariamente il fanatico nazista della seconda guerra mondiale. Lantitesi della malattia mentale e di quella bestialità che emerge con la guerra sono argomenti troppo importanti per essere appena accennati. Inoltre, senzaltro influenzato dalle sue condizioni di salute, Riccarelli inonda di tristezza il suo scritto, con una evidente inclinazione a cercare di portare alla commozione, alle lacrime. Ciò che balza però subito agli occhi è la narrazione, prolissa, tanto da diventare monotona, con ben pochi dialoghi, una narrazione che a volte sembra tipica di un esordiente, con svolazzi poetici e digressioni che spezzano il ritmo pur lento della prosa, finendo con laffaticare inutilmente il lettore, che, più che restare avvinto, viene frastornato da sentimenti spiegati e rispiegati, non di certo con poche misurate parole. Posso comprendere che non pochi siano influenzati dalle dolorose vicende dei protagonisti, ma un romanzo, per essere veramente valido, non deve cercare di fare facile presa calcando la mano sui sentimenti, che pure è giusto che ci siano, purché vengano trattati con moderazione. Insomma, limpressione che ho ricavato é che Riccarelli, di fronte a una tematica così interessante, abbia impostato non bene la struttura dellopera, che di certo non posso definire una delle sue più riuscite. In particolare si è molto lontani dallequilibrio di Un uomo che forse si chiamava Schulz, o di Il dolore perfetto. Leggere si può leggere e forse qualcuno non avrà da fare le mie osservazioni; comunque resta il fatto che Riccarelli ha perso unoccasione per scrivere qualche cosa di unico e irripetibile.
Ugo Riccarelli (Ciriè,
Torino, 1954 - Roma 2013), di famiglia toscana, ha pubblicato Le
scarpe appese al cuore (Feltrinelli
1995, nuova edizione Oscar Mondadori 2003), Un
uomo che forse si chiamava Schulz (Piemme
1998, premio Selezione Campiello, nuova edizione Oscar Mondadori
2012), Stramonio (Piemme
2000, nuova edizione Einaudi 2009), i
racconti di Pensieri crudeli (Giulio Perrone 2006), Diletto (Voland 2009)
e Garrincha (Giulio Perrone 2013),
il saggio Ricucire
la vita (Piemme
2011) e, per Mondadori, L'angelo
di Coppi (2001), Il
dolore perfetto (2004,
premio Strega), Un mare
di nulla (2006), Comallamore (2009), La
repubblica di un solo giorno (2011)
e L'amore graffia il
mondo (2012, premio
Selezione Campiello).
12/5/2014
Nuovi poemetti a cura di Renato Aymone
Arnoldo Mondadori Editore S.p.A. Alla ricerca della perfezione
Da Pietole: / VIRGILIO! O tu, cui partorì la madre /nei campi, al sole, dentro un solco aperto / dal curvo aratro per il pio frumento; / o tu, che avesti per gemello un pioppo / che si levò su tutti gli altri al cielo, /sì che ai suoi rami si stessean le nubi: / appiè del dio, chiuso nell'aureo musco, / venìan le incinte, e i loro blandi voti / s'unìan lassù col pigolìo dei nidi: / Questa raccolta, pubblicata nel 1909, è la naturale continuazione dei Primi poemetti, stampati quattro anni prima, ed è dedicata agli studenti dei licei e delle università in cui Pascoli insegnò. Lungi dallessere un semplice coacervo di poesie scollegate fra loro è una vera e propria silloge mirata in cui si amplia ulteriormente il tema della vita contadina, pur presentando componimenti, peraltro di notevole pregio, avulsi da questa tematica. È questo il caso di La Vertigine, con la quale si discerne del mistero della vita e del profondo senso di smarrimento cosmico, in una continua ricerca dellAssoluto come soluzione a una inanità che sempre incombe sulluomo, secondo unottica tipica del decadentismo ( /Oh! se la notte, almeno lei, non fosse! / Qual freddo orrore pendere su quelle / lontane, fredde, bianche azzurre e rosse, / su quell'immenso baratro di stelle! / ). Non mancano ovviamente poesie dedicate alla vita agreste, come Tra le spighe (Il grano biondo sussurrava al vento. / Qualche fior rosso, qualche fior celeste, / tra i gambi secchi sorridea contento. /...), un caleidoscopio di immagini in cui si avverte un certo rimpianto per quel mondo in cui Pascoli è nato e che necessariamente con gli studi è stato costretto a lasciare. Ma sono parentesi atte a stemperare quel pessimismo che lo attanaglierà per tutta la vita, in un senso di precarietà e di incompiutezza che lo costringeranno a unesistenza tormentata, di cui così bene si tratteggia nella biografia Giovanni Pascoli. Tutto il racconto della vita tormentata di un grande poeta, scritta da Gian Luigi Ruggio. I Nuovi poemetti sono unopera del tutto particolare, stante la notevole dimensione quasi narrativa dei testi, e la metrica adottata, la terzina dantesca, un omaggio alla lui tanto cara Divina Commedia. Però, se Dante Alighieri aleggia con il suo stile, è pure presente lispirazione di Virgilio, attesa la visione bucolica della vita dei campi, che giunge a trasfigurarsi in unimmagine mistica, un luogo sicuro in cui rifugiarsi per lasciar fuori il dolore proprio dellesistenza. Ed é al più grande poeta latino che dedica lultimo componimento della raccolta, quel Pietole in cui si ripercorre il tema delle Bucoliche, con visioni di indubbio effetto, ricreando latmosfera della magia della natura. Pascoli, che ha ormai anni di esperienza sulle spalle, cerca anche un formalismo che tende alla perfezione, consapevole di essere sì debitore ai suoi grandi maestri Dante e Virgilio, ma al tempo stesso avvertendo la capacità di raffrontarsi con loro. Se cè unopera della maturità, e questa cè sempre in ogni artista, i Nuovi poemetti ne costituiscono un chiaro esempio, un lavoro meditato, prima ancora di essere sofferto, con cui stupire, prima dei lettori, lautore stesso. E non è uno scopo velleitario, perché limpressione che si ricava è proprio quella di trovarsi di fronte a unopera di grande eccellenza, forse irripetibile per il perfetto equilibrio fra forma e sostanza; per questo motivo mi sento di consigliarla vivamente, perché si troverà un Pascoli così completo, da sembrare lontano dai pur validi componimenti giovanili, da quella Cavalla storna, croce e delizia del nostro apprendimento scolastico. Giovanni
Pascoli nasce a S.Mauro di
Romagna il 31 dicembre 1855. All'età di dodici anni perde il padre,
assassinato da ignoti; a questa tragedia, se ne aggiunge unaltra,
perché la famiglia è costretta a lasciare la tenuta di cui il padre
era amministratore, perdendo la tranquillità economica di cui
fruiva. Ma le disgrazie si rincorrono e così in poco tempo Pascoli
perde la madre, una sorella e due fratelli; prosegue gli studi a
Firenze e poi a Bologna. Nella città felsinea aderisce alle idee
socialiste, fa propaganda e viene arrestato nel 1879; nel 1882 si
laurea in lettere. Insegna poi greco e latino a Matera, Massa e
Livorno, cercando di riunire attorno a sé i resti della famiglia e
pubblicando le prime raccolte di poesie: "L'ultima passeggiata"
(1886) e "Myricae" (1891).
9/5/2014
Il canto delle manére
Arnoldo Mondadori Editore S.p.A. Quando tornano i ricordi dellinfanzia il cerchio si chiude
*Le foglie dei faggi na volta cadute si arriccia fino a toccarsi i
bordi, ma prima vien giù leggere, con un tic tic, come gocce sulle
frasche. *Ma adesso che tornava al paese dopo tanto tempo, Paula francesxca gli veniva incontro come na figura lontana che avanza pian piano, si vicina e prende forma. Lui la vedeva come trentatré anni prima, bella e senza padroni, libera come lacqua del Vajont che corre e nissuno la ferma. Per quello gli piaceva, per quello laveva persa.* Non credo sia umanamente possibile descrivere quello che ho avvertito quando sono arrivato allultima riga di questo romanzo. Ci provo, comunque: una specie di emozione, una sorta di urlo interiore che saliva dallo stomaco e che poi si spegneva sulle labbra. Non è proprio così, ma si avvicina a questa sensazione per nulla sgradevole e anzi assai appagante. Per quanto non legga in modo sistematico le opere di Mauro Corona e anzi la mia conoscenza letteraria di questo autore sia per ora limitata a I fantasmi di pietra, a Il volo della martora e a Storia di neve, oltre a questo Il canto delle manére, mi accorgo di trovarmi di fronte a un narratore di eccelse qualità, che forse non potrà essere considerato come uno di quei geni che lasciano un segno indelebile in campo letterario, ma che comunque è capace di portare il lettore a una vera e propria catarsi, e ciò non è poco, è anzi molto, perché non sono molti quelli dotati di tale qualità. Fino a oggi ero convinto che il suo capolavoro, basandomi ovviamente su quelli che ho letto, fosse I fantasmi di pietra, ma devo ricredermi, perché Il canto delle manére, che descrive la vita di Santo Corona della Val Martin, riassume in sé tanti e notevoli pregi. Lesistenza tribolata di questo boscaiolo e di tutti i boscaioli assume i toni di unepopea, in quattrocento pagine che si divorano e che si vorrebbe che non finissero mai. La vicenda è ricca di colpi di scena, ma ciò che più conta è la caratterizzazione esemplare del protagonista e dei comprimari, ognuno ben definito nella sua personalità fatta di pregi e di debolezze. Sono uomini scolpiti nel legno, in quello stesso legno che faticando e rischiando tagliano nei boschi, sono uomini che amano, gioiscono, piangono, sono preda dellodio e vittime dellamore, sono uomini veri che è sempre più difficile incontrare. E su tutto la natura, a volte dolce, altre feroce, come sempre, una natura che Corona, più che descrivere, dipinge; in essa figura la coralità dei personaggi, perché se è vero che si parla quasi sempre di Santo Corona, cosa sarebbe lui se accanto non avesse uomini come Augusto Peron, Franz Keil, o donne come Giovanna e Paula, tanto per citarne solo alcuni? Infatti i caratteri dei comprimari servono bene a evidenziare quello del protagonista, un uomo teso a raggiungere una posizione di privilegio, a far soldi, tanti soldi, sacrificando a questo effimero scopo perfino la sua esistenza e accorgendosi da vecchio di non aver vissuto. Le scene del bosco dinverno o in autunno, il lavoro delle squadre di boscaioli, le bevute allosteria, perfino le unioni carnali senza un vero amore che contraddistinguono Santo Corona sono una serie di quadri dipinti con le parole. In alcuni casi, lasciando libero sfogo alla mia fantasia, mi sono sentito perfino di fare un paragone fra certe immagini così stupendamente descritte e le pellicole cinesi del grande regista Zhang Ymou, in primis La foresta dei pugnali volanti, ma anche Lanterne rosse, Hero e La città proibita. Infatti, ho riscontrato la stessa capacità di ricreare unatmosfera che si potrebbe senzaltro definire magica. Mi sembra superfluo aggiungere che la lettura di Il canto delle manére è più che raccomandata.
Mauro Corona è
nato a Erto (Pordenone) nel 1950.
30/4/2014
Il sogno dalmata
Arnoldo Mondadori Editore Lultimo libro È indubbio che Tomizza possa essere considerato uno scrittore di frontiera e come tale si é adoperato nei suoi libri per descrivere la vita, per nulla tranquilla, degli abitanti dellIstria, trapiantati qui nel XVII secolo dalla Dalmazia e dallAlbania, quasi un regalo della Serenissima che, oltre a sottrarre allinfluenza turca quelle popolazioni, trovò il modo di non renderle parte integrante della Repubblica, facendo balenare il sogno di una terra in cui avrebbero finalmente potuto stare senza alcun patema danimo. Il terreno è brullo, richiede immani sforzi per cavarne qualche cosa di che vivere, ma i nuovi arrivati non si danno per vinti in partenza, si danno invece da fare e poco a poco quella landa inospitale diventa una zona in cui poter finalmente piantare le radici. Ma la zona è di periferia, soggetta a non infrequenti invasioni e anche il padrone ogni tanto passa di mano, con limpero asburgico succeduto alla repubblica veneta, e a sua volta seguito dalloccupazione italiana. Tutte esperienze che presentano aspetti positivi e negativi, non come quella solo negativa che si ha finita la seconda guerra mondiale, allorché Tito impone la sua lingua e la sua illiberale visione politica. Ancora una volta Tomizza ci parla della storia del suo popolo, travagliata, e anche senza speranza e di quella nuova patria, rimasta infine una chimera, e lo fa in un modo inconsueto, con un libro che non è un saggio storico e nemmeno un romanzo storico; è invece unanalisi sofferta della propria condizione, con il desiderio di potervi tornare un giorno, ma non come ospite, bensì come padrone di quei quattro sassi. Più che in altre sue opere si avverte il dolore per questa posizione di un popolo che racchiude due anime, quella dalmata e quella istriana, probabilmente acuito dal sentore dellavvicinarsi della morte, tanto che il libro sarà pubblicato postumo, e in questa luce può anche essere interpretato come un testamento, di ciò che è stato e di ciò che avrebbe potuto essere. Non ha la forza di Materada, né la sublime poesia de La miglior vita, eppure Il sogno dalmata lascia egualmente il segno e chiude la produzione letteraria di uno che può essere giustamente considerato uno dei maggiori autori del secolo scorso. In questo senso vale la pena di leggerlo, cercando di cogliere il tratto poetico che di tanto in tanto caratterizza mirabilmente la sua scrittura, consapevoli che costituisce il suo commiato, ancora una volta e fino ultimo da uomo coerente e amante della libertà. Fulvio Tomizza (Giurizzani di Materada, Umago, 26 gennaio 1935 - Trieste, 21 maggio 1999). Figlio di piccoli proprietari agricoli, dopo la maturità classica, si trasferì a Belgrado e a Lubiana, dove iniziò a lavorare occupandosi di teatro e di cinema. Ma nel 1955, quando l'Istria passò sotto la Jugoslavia, Tomizza, benché legato visceralmente alla sua terra, si trasferì a Trieste, dove rimase fino alla morte. Scrittore di frontiera, riscosse ampi consensi di pubblico e di critica (basti pensare ai numerosi premi vinti: nel 1965 Selezione Campiello per La quinta stagione, nel 1969 il Viareggio per L'albero dei sogni, nel 1974, nel 1986 e nel 1992 ancora Selezione Campiello rispettivamente per Dove tornare, per Gli sposi di via Rossetti e per I rapporti colpevoli, nel 1977 e nel 1979 lo Strega e quello del Governo Austriaco per la letteratura Europea per La miglior vita. Ha pubblicato: Materada (1960), La ragazza di Petrovia (1963), La quinta stagione (1965),Il bosco di acacie (1966), L'albero dei sogni (1969), La torre capovolta (1971), La città di Miriam (1972), Dove tornare (1974), Trick, storia di un cane (1975), La miglior vita(1977), L'amicizia (1980), La finzione di Maria (1981), Il male viene dal Nord (1984), Ieri, un secolo fa (1985), Gli sposi di via Rossetti (1986), Quando Dio uscì di chiesa (1987), Poi venne Cernobyl (1989), L'ereditiera veneziana (1989), Fughe incrociate (1990), I rapporti colpevoli (1993), L'abate Roys e il fatto innominabile (1994), Alle spalle di Trieste(1995), Dal luogo del sequestro (1996), Franziska (1997), Nel chiaro della notte (1999).
28/4/2014 Amore lontano 24/4/2014
Labate Roys e il fatto innominabile
Bompiani Editore Un Tomizza minore Fulvio Tomizza è un narratore di particolare spessore e mi ha incantato con romanzi stupendi fra i quali cito soprattutto La quinta stagione, Materada, La miglior vita e Franziska. Sostanzialmente è uno di quegli autori che, legato alla propria terra dorigine, ne ripercorre la storia, soprattutto quella del XX secolo e solo raramente si avventura in epoche di molto precedenti. Con Labate Roys e il fatto innominabile si porta nel XVI secolo, in luoghi ben diversi dai suoi soliti, anche se abbastanza prossimi e con una vicenda che parte da un fatto reale tutto sommato non di particolare rilievo, ma comunque che può interessare per le sue peculiarità. Si tratta quindi una storia antica, di un contrasto protratto nel tempo fra due ecclesiastici. In breve di seguito riporto alcuni cenni che danno indicazioni sulla trama. Alessandro Roys, le cui origini sono spagnole, è labate della decadente abbazia di Summaga; vedovo, con prole, è pervenuto a quellincarico grazie a un vero e proprio mercanteggiamento messo in opera dal fratello, altro ecclesiastico piuttosto influente in Vaticano. Luomo non più giovane, ma dal carattere per nulla remissivo, intrattiene una relazione, che si potrebbe definire non proprio quieta, con una serva di nome Cecilia, ma non si limita a questo, perché infatti la fa prostituire, traendone guadagni. Fra liti, abbandoni e ritorni, cè una definitiva rottura allorché Cecilia se ne va con un altro uomo, evento che labate non può sopportare, né come maschio, né soprattutto come protettore e allora per vendetta si inventa una pratica erotica che la stessa, definita ormai una fattucchiera, praticherebbe usando addirittura gli oli santi. Cè ovviamente odore dinquisizione, ma la denuncia al vescovo di Concordia, Pietro Querini, viene insabbiata. Non corre buon sangue fra i due uomini, per non dire che si detestano cordialmente, ma se prima era una sorta di antipatia ora finisce per il diventare un contrasto acceso che culmina alla fine in unindagine del più alto prelato sul Roys, anche per lattiva collaborazione al riguardo di Cecilia e di sua madre. In pratica labate viene accusato di essere lispiratore della pratica sacrilega e innominabile, ma luomo è abile e sa difendersi bene, sfruttando tutte le possibilità procedurali che di volta in volta si presentano. Nulla viene detto sullesito dellindagine, ma si comprende poi che è sfociata in un nulla di fatto, perché dopo alcuni anni accade che il vescovo Querini faccia visita pastorale allabbazia, il cui titolare è ancora labate Roys e si rileva che nulla è cambiato, con le solite raccomandazioni di porre rimedio allo stato di degrado delledificio di culto e le consuete reiterate promesse di provvedere, puntualmente disattese. Come è possibile notare, più che una storia è una storiellina, eppure anchessa ha un suo significato, perché in un mondo in cui il potere regola il corso delle cose anche un vescovo non può imporsi a un subordinato, quando questi ha un fratello che a Roma conta, e poi in fondo una schermaglia inconcludente finisce con il dare un po di sapore a una vita asfittica di due comprimari nel multiforme organico degli ecclesiastici. Non è certo molto e qualche cosa di più era lecito attendersi da uno scrittore del calibro di Tomizza; comunque Labate Roys e il fatto innominabile è uno di quei testi scorrevoli che si leggono anche con un certo piacere e che consentono di trascorrere alcune ore senza un particolare impegno.
Fulvio Tomizza (Giurizzani di Materada, Umago,
26 gennaio 1935 - Trieste, 21 maggio 1999). Figlio di piccoli
proprietari agricoli, dopo la maturità classica, si trasferì a
Belgrado e a Lubiana, dove iniziò a lavorare occupandosi di teatro e
di cinema. Ma nel 1955, quando l'Istria passò sotto la Jugoslavia, Tomizza,
benché legato visceralmente alla sua terra, si trasferì a Trieste,
dove rimase fino alla morte. Scrittore di frontiera, riscosse ampi
consensi di pubblico e di critica (basti pensare ai numerosi premi
vinti: nel 1965 Selezione Campiello per La quinta stagione, nel
1969 il Viareggio per L'albero dei sogni, nel 1974, nel 1986 e nel
1992 ancora Selezione Campiello rispettivamente per Dove tornare,
per Gli sposi di via Rossetti e per I rapporti colpevoli, nel 1977 e
nel 1979 lo Strega e quello del Governo Austriaco per la letteratura
Europea per La miglior vita. Ha pubblicato: Materada (1960), La
ragazza di Petrovia (1963), La quinta stagione (1965),Il bosco di
acacie (1966), L'albero dei sogni (1969), La torre
capovolta (1971), La città di Miriam (1972), Dove tornare (1974), Trick,
storia di un cane (1975), La miglior
vita(1977), L'amicizia (1980), La finzione di Maria (1981), Il male
viene dal Nord (1984), Ieri, un secolo fa (1985), Gli sposi di via
Rossetti (1986), Quando Dio uscì di chiesa (1987), Poi venne
Cernobyl (1989), L'ereditiera veneziana (1989), Fughe
incrociate (1990), I rapporti colpevoli (1993), L'abate Roys e il
fatto innominabile (1994), Alle spalle di Trieste(1995), Dal luogo
del sequestro (1996), Franziska (1997), Nel chiaro della
notte (1999).
22/4/2014 I giorni e
le strade 14/4/2014 La mia casa 10/4/2014 La marcia di Radetzky 6/4/2014 Giovanni Pascoli. 4/4/2014 Maigret e il corpo
senza testa 28/3/2014 Il conte di
Montecristo
23/3/2014
Notti sullaltura a cura di Salvatore Silvano Nigro
Sellerio editore Palermo
Narrativa romanzo Un viaggio fantastico
Il trasferimento a Frosinone per motivi di lavoro e così di fatto
lallontanamento non certo temporaneo dalla sua natia Mineo devono
aver costituito per Giuseppe Bonaviri una sorta di trauma, giacché la
sua arte creativa è come stimolata dal sogno di un impossibile
definitivo ritorno. Si aggrappa così alla memoria che con il
trascorrere del tempo si sfoca inevitabilmente, creando dei vuoti,
degli scompensi, in cui tuttavia, per la necessità di un riflesso
continuo, inserisce, partendo da unoggettiva realtà, parti di
fantasia. La sua Sicilia, così, diventa mitica, a metà via fra storia
e fiaba, e il paese che lo vide nascere si trasfigura in una mistica
Shangri-La, un paradiso perduto, un angolo ben protetto nella sua
mente in cui rifugiarsi ogni volta che se ne abbia necessità. È
questo il vero sogno, loasi ricostruita in sé, ambientazione di
tanti suoi romanzi fatti di un caleidoscopio di immagini di una sorta
di mondo primordiale in cui si sfoga e si amplia la sua naturale e
accentuata predisposizione per la metafisica. In questi lavori
rientra questo Notti sullaltura, pubblicato nel 1971, cioè
dopo La divina foresta, che è un vero e proprio poema
biologico, come ebbe a suo tempo a definirlo Italo Calvino. Di certo
lautore sanremese fu un notevole estimatore di Bonaviri, anche per
una certa comunanza di ispirazione, pur se con realizzazioni e
approfondimenti diversi. Tuttavia, se La divina foresta aveva
entusiasmato Calvino, questo Notti sullaltura, pur frutto di
un suo largo apprezzamento, fu oggetto anche di qualche critica, come
per esempio per una certa complessità, non disgiunta da una struttura
disomogenea, appunti che in parte condivido e che rendono non facile
la lettura dellopera, facendo perdere soprattutto il filo della
storia e di fatto costringendo spesso a ritornare su punti
precedenti. Quella plasticità armonica che è propria della Divina
foresta è solo presente a tratti, forse anche perché Bonaviri ha
voluto costruire un grande mosaico di sogni, in cui confluiscono
elementi naturali e primordiali, in un continuo scorrere di
sensazioni che riverberano come i risultati del certosino lavoro di
un grande alchimista. Cè tanto e tanto, per non dire troppo, ed è
un peccato perché questo immaginario ritorno a Mineo dellautore
sotto le spoglie di Zephir avrebbe tutte le carte in regola per
stupire ed avvincere già da subito. Il ripercorrere la propria
infanzia in un mondo incantato, fatto di valli e di boschi, abitatiti
da una miriade di uccelli e da alberi rari, il viaggio che si
concretizza in unesperienza fantastica, il paese natio visto come
riparo sicuro dai mali del mondo sono temi costanti della poetica di
Bonaviri, e dico poetica non a caso, perché la sua prosa, per stile e
invenzioni, è una prosa poetica, di grande ed appagante effetto. La
vicenda, in sé e per sé, può sembrare poca cosa, ma è il suo
svolgimento che delinea la qualità dellopera, ciò che sottende e che
conduce piano piano in una realtà parallela che non può non turbare
prima, e avvincere poi.
Giuseppe
Bonaviri, nato nel 1924 a Mineo, in provincia di Catania,
è scomparso nel 2009. Primo di cinque figli di un sarto, Bonaviri ha
vissuto per anni a Frosinone dove ha esercitato la professione di
medico. Fra le sue opere più note, tutte ora pubblicate da questa
casa editrice: L'incominciamento(1983), Il dottor Bilob (1994), Il
vicolo blu (2003), L'incredibile storia di un cranio (2006), Il sarto
della stradalunga (2006), La divina foresta (2008) e Notti
sull'altura (2009).
19/3/2014
Poemi conviviali
Edizioni Einaudi Un Pascoli che non finisce di stupire
Va dato atto a Giovanni Pascoli di averci lasciato un'ampia e
variegata produzione poetica, ampia perché numerose sono le raccolte
composta ognuna da un consistente numero di liriche, variegata
perché, pur nel solco del decadentismo, e quindi con una visione
della vita improntata al pessimismo, i temi trattati non sono
ripetitivi. Che l'autore romagnolo fosse un gran conoscitore della
letteratura greca e di quella latina, non vi è dubbio, tanto che le
insegnava, dapprima agli istituti superiori e poi all'università ,
anzi era così ben ferrato nella bellissima lingua degli antichi
romani da vincere più volte il difficile concorso di poesia latina
che si teneva ogni anno in Olanda. Questo piccolo preambolo non
introduce tanto a liriche scritte in latino, ma a una raccolta di una
ventina di componimenti pubblicata nel 1904 e in cui vengono
rievocati personaggi mitologici e dell'antichità . Quindi si tratta di
un unicum nella produzione di Pascoli, ma di particolare e
rilevante valore. Sono opere appunto riunite in unico volume, ma che
in buona parte già in precedenza erano state pubblicate su Il
convito, un'elegante e raffinata rivista diretta da Adolfo de
Bosis e a cui partecipava anche Gabriele D'Annunzio. Ed è appunto dal
nome di questa rivista che questi poemi prendono il titolo; degni di
apparire su quelle pagine si presentano nel complesso come il frutto
dei profondi studi classici di Pascoli, ma se l'estetica, attraverso
una veste letteraria impeccabile, è un colpo d'occhio ineguagliabile,
del tutto innovativi sono i contenuti. Eppur si parla di personaggi
noti, di protagonisti di opere immortali, ma la rivisitazione degli
stessi da parte del poeta romagnolo fa sì che, oltre a farceli
sentire vivi, spezzi quell'alone di mistero e di magia che li
circonda e ce li faccia sentire vicini, nelle loro umane e naturali
debolezze. È indubbio che ciò che rattrista l'autore è quella
contemporaneità che anziché rappresentare un segno del progresso,
sancisce una regressione a cui pare non esservi rimedio. I vizi
capitali della società pascoliana sono l'ingiustizia, il caos, una
costante e progressiva disumanizzazione, contrastati con una presa di
posizione radicale e decisa che, per esempio, in Alexandros di
traduce in un'aspirazione all'oltre. Giovanni Pascoli
nasce a S.Mauro di Romagna il 31 dicembre 1855. All'età di dodici
anni perde il padre, assassinato da ignoti; a questa tragedia, se ne
aggiunge un'altra, perché la famiglia è costretta a lasciare la
tenuta di cui il padre era amministratore, perdendo la tranquillità
economica di cui fruiva. Ma le disgrazie si rincorrono e così in poco
tempo Pascoli perde la madre, una sorella e due fratelli; prosegue
gli studi a Firenze e poi a Bologna. Nella città felsinea aderisce
alle idee socialiste, fa propaganda e viene arrestato nel 1879; nel
1882 si laurea in lettere. Insegna poi greco e latino a Matera, Massa
e Livorno, cercando di riunire attorno a se i resti della famiglia e
pubblicando le prime raccolte di poesie: "L'ultima passeggiata"
(1886) e "Myricae" (1891).
11/3/2014
Lucien Leuwen Introduzione, traduzione e note
di Lanfranco Binni Garzanti Libri
Un romanzo antieroico
I grandi romanzi di Stendhal sono
Il rosso e il nero e
La Certosa di Parma, a cui
sarebbe aggiungerne un terzo, che, rimasto incompiuto, è stato
pubblicato postumo. E del resto basta arrivare all'ultima pagina di
Lucien Leuwen per
comprendere che l'autore non aveva l'intenzione che terminasse lì,
tanto è evidente la cesura, una chiusura netta in un discorso che
induce il lettore a pensare a un errore. Purtroppo non è così, perché
l'opera, che forse avrebbe potuto riuscire la migliore fra quelle
scritte da Stendhal, non poté essere ultimata per la sua improvvisa
morte avvenuta nel marzo del 1842. Da ciò che ha scritto, ed è molto,
è più che logico pensare che questo romanzo della maturità avrebbe
potuto essere il suo capolavoro assoluto, frutto come gli altri di
un'attenta analisi dell' epoca, in cui si riflette più che mai il suo
pensiero critico, con una nota malinconica velata da una sottile
ironia. E dato che la
storia presenta sempre dei ricorsi, a scorrere questa pagine, in cui
così sapientemente Stendhal è riuscito a darci un quadro chiara della
Francia sotto Louis Philippe - una repubblica succeduta alla
monarchia e che, come tale avrebbe dovuto essere progressista, e che
invece si concretizzò in una restaurazione senza speranze di
cambiamento - viene da pensare ai giorni nostri, al quadro di
corruzione, di apparenze sotto cui si cela il niente, a una realtà
che supera perfino la fantasia e che spegne il benché minimo ideale,
il più esiguo sogno, in una certezza atroce che se esiste l'oggi, non
ci sarà che un domani uguale al grigio odierno.
Lucien Leuwen è un antieroe, non certo nel senso militare del
termine; infatti, anziché cercare di affermare la propria
personalità , resta inerte e timoroso della realtà ; la sua vita è una
parabola di insuccessi a cui va incontro con rassegnazione; eppure,
cresciuto nell'ambiente dell'alta borghesia finanziaria, a lui è
aperta ogni porta e così
da tenente dei lancieri nella modesta cittadina di Nancy, dove ha
modo di conoscere e di frequentare una vedova bella, nobile, di
spirito reazionario, riesce a diventare segretario d'ambasciata a
Roma. Il suo problema è la convinzione di vivere in un mondo che non
gli appartiene. E' evidente che con una base simile, nonostante i
rilevanti appoggi, sia inevitabile che vada incontro a delle
sconfitte, costretto a essere partecipe di quella società che non
ama, succube delle costanti pressioni del padre, che è un ricco
banchiere, nonché un affarista politico.
In questa condizione finisce con il diventare un vero e
proprio ipocrita, non tanto per procurarsi dei vantaggi, quanto per
la necessità di non doversi ribellare al genitore e all'ambiente,
azione che richiederebbe un coraggio che lui non ha.
In una costante di tutta la narrativa stendhaliana c'è molto di
autobiografico ed è così anche in questo romanzo, a partire dal
padre, che ha una strana rassomiglianza di comportamento con quella
del genitore dell'autore, ma anche Lucien Leuwen ha qualcosa di Henry
Bayle, come la carriera diplomatica che è comune (ricordiamo che
Henry Beyle fu console francese a Civitavecchia, in rappresentanza di
quel paese, la cui classe dirigente detestava, quindi con
un'ipocrisia nemmeno tanto celata); vedo rassomiglianze anche nel
rapporto amoroso del protagonista con Batilde de Chasteller, il cui
nome non a caso è pressoché uguale a quello della donna più amata da
Stendhal ( Matilde Dembowski ).
Insomma, una volta di più ci si rende conto di come il grande
narratore francese nelle sue opere abbia profuso non solo le sue
idee, ma abbia trasposto anche parte dell'esistenza, una serie di
autoritratti parziali e perfino, come in Lucien Leuwen, una
confessione della propria condizione, uno sfogo di chi avvertiva la
sua estraneità a un'epoca, ma che tuttavia cercava di esservi ben
presente, traendone anche vantaggi.
Vien da dire, pertanto, che questo fenomenale scrittore ha di fatto
scritto e riscritto, nei suoi romanzi, la sua autobiografia, e con
una sincerità a volte perfino commovente, come in
Vita di Henry Brulard; i
suoi personaggi sono la sua immagine speculare, magari un po'
deformata da una curvatura dello specchio, ed è per questo,
nonostante il parto di fantasia che già inizia dal nome, che ne
avvertiamo l'autenticità , senza forzature, come appunto nel caso di
Lucien Leuwen.
Come sarebbe potuto andare a finire se non fosse venuto a mancare?
Senz'altro con un ritorno a Parigi, ma poi per quel che sarebbe stato
delle esistenze di Lucien Leuwen " Henry Bayle non può che restare
una lunga serie di pagine bianche.
Stendhal, pseudonimo di Henri Beyle, nasce a Grenoble
il 23 gennaio 1783 e muore a Parigi il 23 marzo 1842. Convinto
sostenitore della rivoluzione, alla caduta di Napoleone assume un
atteggiamento di condiscendenza con la restaurazione intervenuta, in
contrasto con le sue idee, ma indispensabile per poter vivere;
preferisce soggiornare lontano dalla Francia, in Italia, dove svolge
l'attività di Console, di scarso interesse, ma abbastanza
remunerativa per consentirgli di dedicare la maggior parte del suo
tempo alla narrativa. Fra le sue opere ricordiamo Lucien Leuwen,
Cronache italiane, La badessa di Castro, Dell'amore, la Certosa di
Parma e la sua migliore Il rosso e il nero.
4/3/2014
Primi Poemetti
Casa Editrice Guanda Poesia
Nel solco del Decadentismo
Il titolo della raccolta,
Primi poemetti, potrebbe trarre in inganno, poiché non si tratta
della prima opera scritta e pubblicata da Giovanni Pascoli (la prima
è stata Myricae nel 1891),
bensì della seconda, edita nel 1897 in una versione ridotta,
comprendente solo venti liriche e intitolata semplicemente Poemetti,
a cui seguirono altre tre edizioni ( del 1900 incrementata a 45
poesie, del 1904 che ha il titolo definitivo di
Primi poemetti e del 1907
che non presenta variazioni rilevanti). Quest'opera è probabilmente
quella che più tende al Decadentismo, considerati i temi della morte,
della corruzione, della decadenza, e più in generale per una chiara e
forte presa di posizione nei confronti dei limiti della civiltà
moderna. Occorre tenere presente che al riguardo Pascoli ha idee non
confuse e ha sempre mantenuto una visione della poesia come di un
rifugio sicuro che protegge dal mondo circostante. Questa nuova
raccolta, fra l'altro, a differenza di
Myricae, che pure è
stupenda, è meno frammentaria, è più organica nell'impostazione del
messaggio che l'autore intende portare avanti. Del resto nella sua
prefazione originaria Pascoli espone il fine dell'opera, riaffermando
l'importanza della Natura. La contrapposizione di una vita più a
misura d'uomo, semplice e non avulsa dalle sue innate e radicate
predisposizioni, senza con ciò invocare una mitica Arcadia, ha il
significato di dare una misura alle cose e alle azioni affinché
rientrino sempre in un circolo virtuoso
di cui l'uomo è parte come artefice e come beneficiario. Un
altro tema affrontato è quello del mistero, già presente in
Myricae, ma che qui è
caratterizzato da maggior approfondimento e da un'esposizione
senz'altro più comprensibile. E infine Pascoli delinea un'ulteriore
tema che è quello della solidarietà fra tutti gli uomini e lo fa
metaforicamente, ma in modo che risulti più facilmente intellegibile,
con i versi dei rondoni che soccorrono le rondinelle portando loro da
mangiare.
Giovanni Pascoli nasce a S.Mauro di Romagna il 31 dicembre
1855. All'età di dodici anni perde il padre, assassinato da ignoti; a
questa tragedia, se ne aggiunge un'altra, perché la famiglia
è costretta a lasciare la tenuta di cui il padre era amministratore,
perdendo la tranquillità economica di cui fruiva. Ma le disgrazie si
rincorrono e così in poco tempo Pascoli perde la madre, una sorella e
due fratelli; prosegue gli studi a Firenze e poi a Bologna. Nella
città felsinea aderisce alle idee socialiste, fa propaganda
e vienearrestato nel 1879; nel 1882 si laurea in lettere. Insegna poi
greco e latino a Matera, Massa e Livorno, cercando di riunire attorno
a se i resti della famiglia e pubblicando le prime raccolte di
poesie: "L'ultima passeggiata" (1886) e "Myricae" (1891).
2/3/2014
Il sindaco con due mogli Albus Edizioni Narrativa romanzo
Lei, lui, lei
Premetto che la vicenda narrata di per se non è originale, perché di
matrimoni in cui il marito, invaghitosi di un'altra donna, tradisce
la moglie e questa, venutane a conoscenza, non lo lascia, ce ne sono
parecchi. L'autore, che vive nella Svizzera italiana, in calce al
libro asserisce che quanto narrato risponde a verità e che la strana
tresca gli è stata raccontata da una dei protagonisti, per l'appunto
l'amante, e di ciò non ho motivi di dubitare, perché casi simili sono
non poco frequenti.
Duilio Parietti nasce
a Luino, in provincia di Varese nel 1958. A diciotto anni viene
colpito dal... "virus" della radio, che diventerà il suo principale
hobby e, ben presto, anche la sua principale attività professionale.
26/2/2014
La nera signora
Giovane Holden Edizioni
Poesia
A volte il titolo di una raccolta dice poco
sul tema trattato, ma in questo caso
La nera signora è già
di per se esplicativo. Certo non ci sono i richiami o le paure, per
non dire le angosce, di scritti e di affreschi di epoca medievale,
con quel "memento mori" che ossessivamente viene ripetuto per
rammentare che la vita terrena non è eterna.
Tiziana Monari nasce a Monghidoro in provincia di Bologna. Piccolissima si trasferisce con
la famiglia a Prato, anche se trascorre ancora lunghi periodi con i
nonni nella quiete della montagna. Segue studi umanistici letterari,
ama leggere, girare il mondo (ha visitato 67 paesi tra cui Australia,
Nuova Zelanda, Indonesia, Giappone, Corea, Malesia,Thailandia,
Cambogia,Laos, Cile, Argentina, Perù, Bolivia, Stati Uniti, India,
Canada) e fare lunghe passeggiate nei boschi con il suo cane. Scrive
poesie e racconti solo da pochi anni. " Dalla partecipazione ai premi
di poesia iniziata dall'anno 2007 l'autrice ha ricevuto ad oggi più
di 200 riconoscimenti tra primi, secondi, terzi premi oltre a premi
speciali, trofei, premi della critica, della giuria , menzioni,
segnalazioni." Le sue poesie sono presenti in numerose antologie e
riviste letterarie.
Sito web:
www.tizianamonari.it
19/2/2014
Non si fa mai giorno Sellerio editore Palermo Narrativa raccolta di racconti
Una raccolta inferiore alle aspettative
Mi rincresce dover constatare come l'autore del bellissimo romanzo
Il giudizio della sera non si riconfermi per livello qualitativo con
questa raccolta di racconti intitolata
Non si fa mai giorno.
Preciso, peraltro, che ancora una volta ho notato la notevole
difficoltà dei narratori italiani di scrivere delle prose brevi,
quali appunto novelle o racconti, che siano in grado di appassionare
il lettore; ciò vale soprattutto per i contemporanei, perché in
passato, sia pur sporadicamente, ci sono stati scrittori validi in
questa tipologia e al riguardo basti pensare a Verga e D'Annunzio, e
più recentemente a Sciascia.
14/2/2014
I promessi sposi
a cura di Ferruccio Ulivi
Newton Compton Editori
Narrativa romanzo
Sempre attuale
Croce e/o delizia di tanti studenti delle scuole superiori è indubbio
che I promessi sposi, al di là dei suoi meriti, sia
un'opera conosciuta proprio perché inserita nei programmi
d'insegnamento scolastico. Ma perché studiarla, perché questa e non
un'altra? Credo che il motivo risieda soprattutto nell'uso esemplare
della nostra lingua, un italiano doc potrebbe dire qualcuno, e su
questo fatto non ci sono dubbi, perché mai prima d'allora era stato
scritto un romanzo avulso da inflessioni di idiomi locali, oppure con
un ricorso così particolareggiato e preciso alla grammatica, con una
certosina ricerca di termini che per l'appunto dovessero dare luogo a
un lavoro impeccabile, un preciso riferimento per chi poi avesse
voluto mettere nero su bianco le sue idee in un linguaggio
comprensibile e scorrevole per ogni italiano, dal siciliano al
piemontese.
Alessandro Manzoni nasce
a Milano nel 1785. Figlio del conte Pietro e di Giulia
Beccaria, viene educato nei collegi dei padri Somaschi e Barnabiti,
finché nel 1805 raggiunge la madre a Parigi, dove soggiorna fino al
1810 entrando in contatto con gli i deologues repubblicani e
stringendo amicizia con il filosofo Claude Fauriel. Nel 1808 si sposa
con Enrichetta Blondel e due anni dopo, nel 1810, si converte al
cattolicesimo. Seguono anni di intensa attività letteraria e di
intensi contatti con gli ambienti del romanticismo milanese: ne nasce
la poesia dei primi Inni sacri (1812-15) e delle odi politiche (Marzo
1821, 1848, e Il cinque maggio, 1821) e l'interesse per un rinnovato
teatro tragico, svincolato dai canoni del classicismo (Il conte di
Carmagnola, 1820, e Adelchi, 1822). Nel 1823, dopo un'ulteriore prova
di poesia liturgica (Pentecoste, 1822), termina il Fermo e Lucia,
prima e provvisoria stesura del romanzo storico a cui si era dedicato
fin dal 1821 e che sarà pubblicato quattro anni più tardi con il
titolo I promessi sposi (1827). A partire da questa data diminuisce
la sua attenzione per i problemi letterari: gli anni trenta sono
segnati da una lunga serie di lutti familiari (morte della moglie e
di alcuni dei suoi dieci figli) e dalla lunga revisione linguistica
del romanzo, la cosiddetta "risciacquatura dei panni in Arno",
avviata dal soggiorno fiorentino del 1827 e portata a termine nel
1840, con la pubblicazione a fascicoli dell'opera, integrata
dall'appendice sulla Storia della colonna infame. Sempre più convinto
dell'impossibilità di conciliare invenzione letteraria e adesione al
"vero storico" (Del romanzo storico, 1850), negli anni successivi
Manzoni, pur godendo di grande fortuna già presso i contemporanei,
abbandona del tutto l'attività letteraria; nominato senatore a vita
nel 1861, vota a favore della liberazione di Roma (1864) ed è
presidente della Commissione parlamentare sull'unità linguistica.
Nell'anniversario della sua morte, avvenuta a Milano nel 1873,
Giuseppe Verdi compone e dirige la Messa da requiem.
10/2/2014
Il segno rosso del coraggio
Traduzione di Alessandro Barbero
Dall'adolescenza alla maturità
C'è un romanzo che ho letto per la prima volta molti anni fa e che mi
è rimasto impresso nella mente, perché ha caratteristiche proprie di
tale rilevanza da farne un autentico gioiello.
Stephen Crane
(Newark, 1 novembre 1871 " Badenweiler, 5 giugno 1900).
6/2&2014
Mastro Don Gesualdo a cura di Sergio Campailla
Newton Compton
Editori
Narrativa romanzo
La roba, nient'altro che la roba
Secondo romanzo
del Ciclo dei Vinti, Mastro Don Gesualdo, pubblicato
nel 1889,è senz'altro una delle opere più conosciute fra quelle
scritte da Giovanni Verga e, a mio parere,è la sua migliore. Il
maestro del verismo ha qui raggiunto infatti una perfezione
stilistica e di analisi raramente riscontrabile, delineando la storia
di un uomo che si è fatto da se, che con il duro e costante lavoro ha
raggiunto una invidiabile posizione di agiatezza che è il simbolo del
suo successo. Ma l'essere riuscito ad arrivare a un traguardo
insperato comporta solo amarezze, con il suo gruppo familiare che
pretende sempre di più e che è avido delle sue ricchezze e con i
nobili, casta già all'epoca in decadenza, che si ostinano, chiusi a
riccio nei loro tramontanti privilegi, a considerarlo solo un
parvenu, a trattarlo con distacco, se non addirittura a
disprezzarlo ostentatamente.
Giovanni Verga
nacque nel 1840 a Catania, dove trascorse la giovinezza. Nel 1865 fu
a Firenze e successivamente a Milano, dove venne a contatto con gli
ambienti letterari del tardo Romanticismo. Il ritorno in Sicilia e
l'incontro con la dura realtà meridionale indirizzarono dal 1875 la
sua produzione più matura all'analisi oggettiva e alla resa narrativa
di tale realtà . Morì a Catania nel 1922. Di Verga la Newton Compton
ha pubblicato I Malavoglia, Mastro-don Gesualdo, Storia
di una capinera, Tutte le novelle e Tutti i romanzi, le
novelle e il teatro.
2/2/2014
Tutte le donne che ho dentro
Albus Edizioni
Poesia
L'universo femminile La produzione poetica nazionale è gigantesca e quindi è facile imbattersi in involontarie ripetizioni di svolgimenti di tematiche. E' proprio questa situazione, che non di rado indispettisce il lettore, una delle cause che rendono poco appetibili i libri di questo genere e che di conseguenza ne limitano la diffusione. Tuttavia, a volte, capita di imbattermi in spiccate originalità , come nel caso di questa silloge di Elisabetta Comastri, particolare per il tema (le personalità femminili) e per la qualità dello svolgimento, con versi ben strutturati, con proposizioni mai urlate, anzi contraddistinte da una gradevole levità . Sì, Tutte le donne che ho dentro è il panorama femminile che l'autrice percepisce nel suo intimo ed èun po' un ripercorrere situazioni probabilmente personali che, comuni tuttavia a tante, danno luogo a una proiezione di un campionario femminino di ampio respiro e senz'altro convincente, perché queste figure, a cui sono improntate le varie liriche, sono palpabili, presenze che emergono dalla grigia quotidianità per rivendicare la loro peculiarità . Troviamo infatti l'adolescente, la madre, l'amante e altro ancora, ben delineate, con ognuna un suo destino, ma accomunate da quella percezione che è specificamente femminile e di cui l'uomo, l'essere maschile, ha più una sensazione che un'approfondita ed esatta comprensione. Proprio per questo ritengo quest'opera di particolare utilità per gli uomini, perché trascende la poesia in se stessa per diventare una fine analisi psicologica. Con ciò non intendo dire che la lettura non sia consigliabile anche alle donne, che possono facilmente ritrovarsi in queste protagoniste, ma che il libro è un'occasione propizia affinchè i maschi possano meglio capire l'universo femminile. E questo è già uno dei meriti della silloge, ma se consideriamo poi l'equilibrio strutturale delle singole poesie, l'ordine logico con cui si susseguono e infine il pathos che talora riescono a creare, ce n'è abbastanza per esprimere un giudizio più che positivo e per consigliarne la lettura. Di questo avviso, in ordine ai meriti, devono essere stati anche i giurati della seconda edizione del Concorso internazionale Poetando, tanto da assegnare all'opera il primo premio. Non conosco le altre sillogi che vi hanno partecipato, ma di certo questa ha ampi e tali elementi positivi da giustificare l'importante riconoscimento.
Elisabetta Comastri
è nata a Perugia nel 1964. Ha frequentato
le scuole, fino al Diploma di Liceo Classico, a Spoleto, dove ha
vissuto con la propria famiglia dal 1970.
Vari suoi componimenti
sono stati antologizzati in diverse riviste letterarie e raccolte
poetiche o di narrativa dalle case editrice "Pagine" "Montedit",
Albus Edizioni, Edizioni Nuovi Poeti, Progetto-Cultura (antologia,
quest'ultima, del premio Nazionale Quaderni di Linfera, prefata da
Maria Luisa Spaziani), Editrice Zona, Ibiskos e altre ancora. Ha
pubblicato le seguenti raccolte di poesie: "Il volo" + CD, Morlacchi,
Perugia, 2005; "Der Flug",Morlacchi, Perugia, 2006 (versione tedesca
de "Il volo"); "Di pura madre", Comune di Leonforte, 2010; "Tutte le
donne che ho dentro", Albusedizioni, Napoli, 2010.
Nel 2009 è stata
insignita del premio Talegalli dalla Associazione Amici di Eggi "
Spoleto, quale riconoscimento per la sua attività di scrittura e per
il contributo alla vita culturale della sua città , con la seguente
motivazione:
Elisabetta vive tuttora
a Spoleto, in una casa in campagna nei pressi della città , insieme ai
suoi quattro figli.
27/1/2014
Un uomo che forse si chiamava Schulz Arnoldo Mondadori Editore
Narrativa
Bruno Schulz, un piccolo grande uomo
Da Pag. 128 " Eravamo, invece, pesci alla mattanza e percorrevamo
con diligenza i corridoi sempre più stretti della nostra tonnara. La
nostra vita fu capovolta e catapultata in un'altra dimensione e lo
spazio in cui muovevamo i nostri passi sempre più incerti si ridusse
di giorno in giorno, asservito al trionfo dei regolamenti, consumato
insieme alle nostre personalità . Non fummo più persone, ma classi,
tipologie e numeri diligentemente trascritti sulle carte e i
diagrammi, appesi nelle sale della vecchia casa comunale.
Bruno Schulz, nato a Drohobycz il 12 luglio 1892 ed ivi morto il 19
novembre 1942, fu un pittore e scrittore polacco, di famiglia ebrea.
A quanto si sa era un uomo che eccelleva nel dipingere, ma era anche
uno straordinario narratore, come testimoniato dal suo libro Le
botteghe color cannella, una originale autobiografia trasformata
in una fantasiosa leggenda dell'infanzia.
Ugo Riccarelli (Ciri
è,
Torino, 1954 - Roma 2013), di famiglia toscana, ha pubblicato Le
scarpe appese al cuore (Feltrinelli
1995, nuova edizione Oscar Mondadori 2003), Un
uomo che forse si chiamava Schulz (Piemme
1998, premio Selezione Campiello, nuova edizione Oscar Mondadori
2012), Stramonio (Piemme
2000, nuova edizione Einaudi 2009), i
racconti di Pensieri crudeli (Giulio Perrone 2006), Diletto (Voland 2009)
e Garrincha (Giulio Perrone 2013),
il saggio Ricucire
la vita (Piemme
2011) e, per Mondadori, L'angelo
di Coppi (2001), Il
dolore perfetto (2004,
premio Strega), Un mare
di nulla (2006), Comallamore (2009), La
repubblica di un solo giorno (2011)
e L'amore graffia il
mondo (2012, premio
Selezione Campiello).
24/1/2014
Ventimila leghe sotto i mari
Introduzione di Fabio Giovannini
Narrativa romanzo Il misterioso capitano Nemo
Nelle mie rilettura di romanzi che mi avevano appassionato da ragazzo
non poteva mancare Ventimila leghe sotto i mari, una
delle opere più riuscite di Jules Verne, scrittore francese piuttosto
fecondo.
Jules Verne
nacque a Nantes nel 1828. Nel 1848 si
trasferì a Parigi attratto dalla intensa vita culturale
della capitale, ma per ottenere il consenso del padre dovette
continuare gli studi giuridici. Dal 1862, grazie al successo del
primo libro, Cinque settimane in pallone (cui seguìParigi
nel XX secolo, pubblicato solo nel 1994), pote dedicarsi
completamente alle sue due grandi passioni: scrivere e navigare. Dopo
la pubblicazione di circa 60 opere e innumerevoli viaggi, Verne -
ricchissimo e osannato ma sempre discreto e schivo - si ritirò ad
Amiens in seguito a un misterioso attentato in cui era rimasto
ferito. Morì nel 1905. La Newton Compton ha pubblicato Ventimila
leghe sotto i mari, Il giro del mondo in 80 giorni, Viaggio
al centro della Terra e il volume unico I grandi romanzi.
22/1/2014 I tre moschettieri Introduzione di Giorgio Manganelli Edizioni Einaudi Per il re e per la Francia! Fra i numerosi libri letti da ragazzo ce ne
sono alcuni che sono rimasti ben impressi nella mia memoria per
l'entusiasmo che mi ingenerarono, tanto che ora, in età assai più
avanzata, mi è venuto voglia di riprenderli in mano per verificare se
l'ampia e positiva impressione allora avuta potesse trovare conferma
anche oggi. Dico subito che per alcuni ho dovuto ravvedermi, mentre
per altri ho provato lo stesso grado di soddisfazione e fra questi vi
è appunto I tre moschettieri, un romanzo che l'autore scrisse
nel 1844 e che ebbe un tale successo da dar vita a una trilogia,
comprendente appunto I tre moschettieri, Vent'anni dopo
e Il visconte di Bragelonne. Alexandre
Dumas (1802-1870),
scrittore e drammaturgo francese,è autore di numerosi romanzi di
argomento storico che ebbero molto successo e che pubblicati a
puntate sui giornali dell'epoca contribuirono alla grande diffusione
del romanzo d'appendice. Tra le sue opere sono da ricordare Il
conte di Montecristo, I
tre moschettieri e
la sua continuazione Vent'anni
dopo, La
regina Margot, Robin
Hood. Nel 2004 Einaudi ha
pubblicato nei "Millenni" Viva
Garibaldi.
20/1/2014
Dal tramonto all'alba
Albus Edizioni
Poesia
Una soddisfacente raccolta antologica
È indubbio che il tramonto sia stato, sia e continuerà ad
essere un momento del giorno del tutto particolare, con quella luce
che lenta si spegne fra gli ultimi bagliori del sole; e fonte di
ispirazione per numerosi artisti, proprio per quella tenera
malinconia che si insinua dentro di noi fino ai più reconditi recessi
dell'anima e che ci raccoglie in noi stessi, ci fa avvertire un
fremito che solo con il calare delle tenebre si assopisce, perché
inizia una nuova parte della giornata, la notte, con la sera che è la
sua avanguardia. Sono tanti i poeti che hanno inteso esprimere
l'emozione di un giorno che si chiude per lasciare spazio
all'intimità della casa, della famiglia e per consentire il giusto
riposo a cui con il sonno lasciarsi andare, facendo emergere, come
per magia, i sogni, frutti inconsapevoli di nostre altrettanto
inconsapevoli elaborazioni mentali. È lunga la notte, con il suo buio
che tutto avvolge con l'ampio mantello, ma alla fine la luce ritorna,
s'affaccia di nuovo il sole a oriente e tutto ricomincia. Tramonto,
notte, alba, tre momenti che si ripetono da milioni di anni, tre
momenti, se paragonati all'immensità del tempo, che generano
inevitabilmente sensazioni e che inducono i poeti a esprimerle in
versi. È appunto Dal tramonto all'alba il tema di
questa antologia poetica curata da Daniela Cattani Rusich, che
raccoglie le liriche, non poche, di numerosi autori, ognuno dei quali
ha esposto il suo sentire di fronte a queste realtà temporali, come
già hanno fatto molti altri anche in un lontano passato.
Gli Autori
18/1/2014 Il Flauto magico e
la luna di neve Il fascino magico dell'estremo oriente Ammetto che
l'estremo oriente ha sempre rappresentato per me un mondo misterioso,
con tradizioni così difformi dalle nostre, con stili di vita del
tutto particolari e propri di civiltà millenarie che, pur in un
rapido progresso, hanno saputo conservare quanto di buono era
presente nel loro lontano passato. In ambito letterario anche le
poesie hanno svolgimenti e tematiche del tutto peculiari e al
riguardo basti pensare all'haiku, una forma tipicamente giapponese,
diffusasi tuttavia rapidamente nel mondo occidentale. Massimo Baldi,
nato a Torre del Greco (Napoli) nel 1966. Ha pubblicato cinque libri di poesia: "Le
quattro stagioni di un viaggiatore solitario" (Edizioni Creativa,
2009), "Il canto della felicità " (Lulupress, 2011), "Omaggio a Lucio
Dalla" (Lulupress, 2012)", "Il susino magico e il lago di giada" (Lulupress,
2013)" e "Il flauto magico e la luna di neve" (Edizioni Creativa,
2013)". Sito WEB:
16/1/2014
Per chi suona la
campana
Traduzione di
Maria Napolitano Martone
Arnoldo Mondadori
Da John Donne a Ernest Hemingway
Non è un caso se
il titolo di questo romanzo è tratto da una poesia del famoso poeta
inglese John Donne (Nessun
uomo è un'Isola, /intero in se stesso. /
Ernest Hemingway (Oak
Park, Illinois, 1899 - Ketchum, Idaho, 1961), tra i più grandi
scrittori anglosassoni del Novecento, ha ricevuto il premio Nobel per
la letteratura nel 1954. Giornalista e corrispondente di guerra, ha
partecipato alla guerra di Spagna e alle due guerre mondiali. Amante
dell'avventura, del rischio, delle forti emozioni e della festa, ha
vissuto tra l'altro a Parigi e Cuba. È morto suicida.
15/1/2014 "Il portagioie misterioso" romanzo fantasy di Maristella Angeli Sezione: Narrativa Autori: Maristella Angeli
Recensione di Sandro Orlandi "Azzurra come il cielo." Inizia come una favola, pian piano diventa una storia mistery, finendo col trasformarsi in fantasy. Il Portagioie misterioso di Maristella Angeli affascina fin dalle prime pagine, per la sua capacità di trasportarci in un'altra dimensione spazio-temporale in punta di poesia. La musicalità del linguaggio norreno, l'armonia della descrizione di luoghi e personaggi, le citazioni poetiche, le filastrocche e non ultimo la profondità dei sentimenti e dei simboli scelti, sono solo alcune delle singolarità che caratterizzano questo originale romanzo. Nella premessa l'Autrice sottolinea come la protagonista Azan sia un'antieroina, umanamente fragile ma consapevole di esserlo e che il Regno delle Tenebre, che rappresenta l'oscurità della mente, si contrappone a quello della luce, a sua volta emblema della capacità di vedere oltre. La Terra Sospesa poi è la dimensione interiore in cui l'uomo si ritrova quando affronta il suo viaggio più arduo: la ricerca di se stesso. Un romanzo di introspezione dunque? Sicuramente, ma con il passo del racconto di avventura più avvincente. Azan affronterà le forze del male, degnamente rappresentate dalla strega Frida e suo figlio Dandel, ma anche da orchi Saropik, mostri terrificanti come i pipistrelli giganti Eaglos, il pitone Dekkar e altre infernali creature, brandendo la sua spada sacra Acrum, costruita con polvere di stelle e frammenti di roccia sacra, che riesce ad uccidere soltanto il male, non la persona; tutto questo con l'aiuto di un esercito davvero straordinario e composito, come il popolo degli Eggar e gli Elfi della notte, ma anche il drago Vogish, tre fatine e oggetti magici: uno specchio, un bottoncino luminoso, e perfino l'albero sacro della saggezza, Saspha. Ce n'è in abbondanza insomma e certo il lettore non si accorgerà nemmeno che in realtà leggendo sarà coinvolto in un viaggio che ha del mistico e analitico. Dopotutto, ci dice ancora l'Autrice, la fantasia fa parte del Regno della luce e senza di essa non potremo mai sconfiggere il male. Un mondo fatato dunque quello in cui entreremo, come descritto peraltro dalla stessa Angeli con la poesia che chiude la narrazione, dove verremo letteralmente trascinati dall'invincibile desiderio di veder trionfare il giusto e quindi di trovare l'agognata serenità . Non a caso infatti questa verrà fatta vivere al lettore dalla dolce e tenera storia d'amore di Azan col suo principe Urban, il fedele e innamoratissimo compagno di avventura. Non mancherà il matrimonio e in occasione di questo l'Autrice descrive minuziosamente, e con dovizia di particolari, gli usi e costumi del popolo elfico, nonché la cerimonia delle nozze, con la commovente partecipazione di tutti coloro che avranno contribuito alla vittoria finale, oggetti magici compresi. Manca la violenza fine a se stessa, di cui molti fantasy sono intrisi e lo stupido, ottuso inneggiare all'onore della battaglia, l'incitamento alla guerra e la sovrabbondanza dello spargimento di sangue. Un fantasy diverso quindi, in un mare di storie più o meno sempre uguali e ripetitive e poco importa se questo o quel personaggio ricorda altri personaggi di romanzi più o meno famosi; l'unicità del Portagioie misterioso si basa sul fatto che, in realtà , siamo noi i protagonisti. Entreremo con Azan nell'antro infernale di Dandel, che fa paura come fa paura il nostro lato oscuro e lo sconfiggeremo, infilzandolo con la spada sacra Acrum. Una vittoria del genere non si dimentica: alla fine ci sentiremo appagati e diversi. Maristella Angeli sito web: http://word.technologeek.eu/maristella-angeli/ Le sue opere pittoriche: http://www.premioceleste.it/maristella..angeli http://lelite.it/angeli.html http://www.artfromworld.com/maristellaangeli.htm La mia personale artistica in 3D Art Gallery: http://youtu.be/LJm1kWucrr0 "Il portagioie misterioso" Il mio primo romanzo fantasy http://www.antipodes.it/prodotti/scheda-prodotto.asp?id=43
14/1/2014
Lo strano caso del dottor Jekyll e del signor Hyde
Introduzione di Massimo Polidoro
Due in uno
Pubblicato nel 1886 questo romanzo può essere definito uno dei più
grandi classici della letteratura fantastica. Però, pur se questo è
vero, sono dell'opinione che esuli dalla pura invenzione letteraria,
ma finisca con il costituire un'analisi profonda della psiche umana.
Non si dimentichi inoltre che all'epoca dell'uscita dell'opera
Sigmund Freud, pur già laureato, non aveva ancora dato alle stampe il
suo primo trattato, L'interpretazione dei sogni, che giustamente lo
rese famoso. Studi sul comportamento dell'uomo erano già stati
tuttavia avviati dal medico tedesco Franz Mesmer circa un secolo
prima.
Robert Louis Stevenson nacque
nel 1850 a Edimburgo,
dove visse fino al 1863. Debole di salute fin dall'infanzia e
tormentato da problemi polmonari, si spostò in Francia, in Italia e
negli Stati Uniti alla ricerca di un clima migliore. La scoperta
della letteratura segnò la sua strada di giovane sensibile e curioso:Shakespeare,
Walter Scott e
Dumas furono i suoi primi maestri. Nel 1878 pubblica i suoi primi
libri di viaggio e i racconti che riunirà nelle Nuove
mille e una notte (1882).
Il successo gli arriva con L'isola
del tesoro (1883),
classico di ogni tempo e di ogni età . Nel 1886 escono Il
fanciullo rapito e Lo
strano caso del Dottor Jekyll e
di Mr. Hyde,
che lo confermano nella fama internazionale. Nel 1885 conosce Henry James,
al quale rimarrà legato da grande amicizia. Terminato nel 1888 il
romanzo Il Master di Ballantrae,
parte per il Pacifico, dove scriverà racconti celeberrimi come Il
diavolo nella bottiglia e La
spiaggia di Falesà , romanzi come Il
naufrago e Il
riflusso della marea, e dove rimarrà fino alla morte, avvenuta
nel 1894 a soli
44 anni.
10/1/2014
Vita di Henry Brulard
Introduzione di Mario Lavagetto
Garzanti Libri
L'autobiografia di Henri Beyle
Non si può certo negare che fra le caratteristiche di Stendhal ci
fosse la passione per gli pseudonimi, e del resto Stendhal stesso è
un nome di fantasia, sotto cui si cela Henry Beyle. Non c'è da
stupirsi, quindi, se alla propria autobiografia, che poteva essere
benissimo intitolata Vita di me medesimo, oppure più
direttamente Vita di Henri Beyle, l'autore abbia preferito
ricorrere ancora una volta a un innocente stratagemma ed è così che
ai posteri è stata tramandata la Vita di Henri Brulard,
dove, guarda caso, le iniziali del nome e del cognome sono le stesse
di quelle dello scrittore francese.
Stendhal,
pseudonimo di Henri Beyle,
nasce a Grenoble il 23 gennaio 1783 e muore a Parigi il 23 marzo
1842. Convinto sostenitore della rivoluzione, alla caduta di
Napoleone assume un atteggiamento di condiscendenza con la
restaurazione intervenuta, in contrasto con le sue idee,
ma indispensabile
per poter vivere; preferisce soggiornare lontano dalla Francia, in
Italia, dove svolge l'attività di Console, di scarso interesse, ma
abbastanza remunerativa per consentirgli di dedicare la maggior parte
del suo tempo alla narrativa. Fra le sue opere ricordiamo Lucien Leuwen, Cronache
italiane, La badessa di Castro, Dell'amore, la
Certosa di
Parma e la sua migliore Il rosso e il nero.
4/1/2014
Racconti di Natale
a cura di Aurelio Caliri
Edizioni Arte e Musica
Da leggere non solo a Natale
Questo libro già si presenta bene ancor prima di aprirlo e di
leggerlo. Infatti, in campo rosso, il colore del Natale, in una
cornice dorata (altra tinta natalizia) spicca La natività
di Salvatore Fiume, un'opera, che pur nella modernità dello stile,
richiama tutte quelle grandi del passato e rappresenta, in un gioco
di luci di grande effetto, la nascita di Gesù.
Nota:
il libro non si trova in libreria, ma può essere richiesto
direttamente all'editore ai numeri telefonici:
Gli Autori
1/1/2014
Ivanhoe
Arnoldo Mondadori Editore S.p.A. Di dame e cavalieri
Confesso che ho letto questo romanzo quando ero ancora un ragazzo e
allora l'ambientazione e la vicenda mi appassionarono. In fondo, a
quell'età , una prosa avventurosa con gli eroi a cui è riservato un
lieto fine fanno sempre colpo. Ma riletto successivamente, da adulto
smaliziato, ho potuto constatare che il fascino dell'opera era
rimasto inalterato, riuscendo inoltre a cogliere aspetti che prima mi
erano sfuggiti. Fra questi lo stile, per nulla barocco, anche se
antiquato, capace di conferire un alone di magia all'intero romanzo,
la cui trama già di per sè assai interessante e inserita in un
preciso contesto storico (XII secolo), all'epoca della reggenza di
Giovanni Senza Terra e delle lotte per il predominio
sull'Inghilterra di Sassoni e Normanni. è un periodo travagliato,
fra chi sogna il ritorno dalle crociate del legittimo re Riccardo
Cuor di Leone e chi invece sostiene il reggente usurpatore. Come in
una serie di pale d'altare, si viene così a delineare un polittico in
cui emerge poco a poco la figura di Wilfred di Ivanhoe, cavaliere
audace, coraggioso, ma nobile d'animo e capace di infondere fiducia
al popolo.
Walter Scott
(Edimburgo, 15 agosto 1771 " Abbotsford House, 21 settembre
1832)è stato poeta e narratore. Ha scritto, fra l'altro, La donna
del lago (1810), L'antiquario (1816), Rob Roy (1818), Ivanhoe (1820). |
| Poetare | Poesie | Licenze | Fucina | Strumenti | Metrica | Figure retoriche | Guida | Lettura | Creazione | Autori | Biografie | Poeti del sito |
Poetare.it © 2002